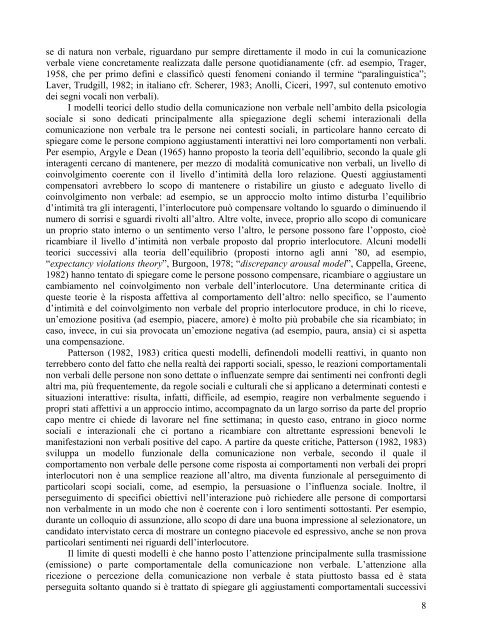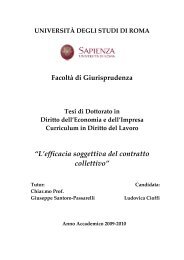Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
se <strong>di</strong> natura non verbale, riguardano pur sempre <strong>di</strong>rettamente il modo in cui la comunicazione<br />
verbale viene concretamente realizzata dalle persone quoti<strong>di</strong>anamente (cfr. ad esempio, Trager,<br />
1958, che per primo definì e classificò questi fenomeni coniando il termine “paralinguistica”;<br />
Laver, Trudgill, 1982; in italiano cfr. Scherer, 1983; Anolli, Ciceri, 1997, sul contenuto emotivo<br />
dei segni vocali non verbali).<br />
I modelli teorici dello stu<strong>di</strong>o della comunicazione non verbale nell’ambito della psicologia<br />
sociale si sono de<strong>di</strong>cati principalmente alla spiegazione <strong>degli</strong> schemi interazionali della<br />
comunicazione non verbale tra le persone nei contesti sociali, in particolare hanno cercato <strong>di</strong><br />
spiegare come le persone compiono aggiustamenti interattivi nei loro comportamenti non verbali.<br />
Per esempio, Argyle e Dean (1965) hanno proposto la teoria dell’equilibrio, secondo la quale gli<br />
interagenti cercano <strong>di</strong> mantenere, per mezzo <strong>di</strong> modalità comunicative non verbali, un livello <strong>di</strong><br />
coinvolgimento coerente con il livello d’intimità della loro relazione. Questi aggiustamenti<br />
compensatori avrebbero lo scopo <strong>di</strong> mantenere o ristabilire un giusto e adeguato livello <strong>di</strong><br />
coinvolgimento non verbale: ad esempio, se un approccio molto intimo <strong>di</strong>sturba l’equilibrio<br />
d’intimità tra gli interagenti, l’interlocutore può compensare voltando lo sguardo o <strong>di</strong>minuendo il<br />
numero <strong>di</strong> sorrisi e sguar<strong>di</strong> rivolti all’altro. Altre volte, invece, proprio allo scopo <strong>di</strong> comunicare<br />
un proprio stato interno o un sentimento verso l’altro, le persone possono fare l’opposto, cioè<br />
ricambiare il livello d’intimità non verbale proposto dal proprio interlocutore. Alcuni modelli<br />
teorici successivi alla teoria dell’equilibrio (proposti intorno agli anni ’80, ad esempio,<br />
“expectancy violations theory”, Burgoon, 1978; “<strong>di</strong>screpancy arousal model”, Cappella, Greene,<br />
1982) hanno tentato <strong>di</strong> spiegare come le persone possono compensare, ricambiare o aggiustare un<br />
cambiamento nel coinvolgimento non verbale dell’interlocutore. Una determinante critica <strong>di</strong><br />
queste teorie è la risposta affettiva al comportamento dell’altro: nello specifico, se l’aumento<br />
d’intimità e del coinvolgimento non verbale del proprio interlocutore produce, in chi lo riceve,<br />
un’emozione positiva (ad esempio, piacere, amore) è molto più probabile che sia ricambiato; in<br />
caso, invece, in cui sia provocata un’emozione negativa (ad esempio, paura, ansia) ci si aspetta<br />
una compensazione.<br />
Patterson (1982, 1983) critica questi modelli, definendoli modelli reattivi, in quanto non<br />
terrebbero conto del fatto che nella realtà dei rapporti sociali, spesso, le reazioni comportamentali<br />
non verbali delle persone non sono dettate o influenzate sempre dai sentimenti nei confronti <strong>degli</strong><br />
altri ma, più frequentemente, da regole sociali e culturali che si applicano a determinati contesti e<br />
situazioni interattive: risulta, infatti, <strong>di</strong>fficile, ad esempio, reagire non verbalmente seguendo i<br />
propri stati affettivi a un approccio intimo, accompagnato da un largo sorriso da parte del proprio<br />
capo mentre ci chiede <strong>di</strong> lavorare nel fine settimana; in questo caso, entrano in gioco norme<br />
sociali e interazionali che ci portano a ricambiare con altrettante espressioni benevoli le<br />
manifestazioni non verbali positive del capo. A partire da queste critiche, Patterson (1982, 1983)<br />
sviluppa un modello funzionale della comunicazione non verbale, secondo il quale il<br />
comportamento non verbale delle persone come risposta ai comportamenti non verbali dei propri<br />
interlocutori non è una semplice reazione all’altro, ma <strong>di</strong>venta funzionale al perseguimento <strong>di</strong><br />
particolari scopi sociali, come, ad esempio, la persuasione o l’influenza sociale. Inoltre, il<br />
perseguimento <strong>di</strong> specifici obiettivi nell’interazione può richiedere alle persone <strong>di</strong> comportarsi<br />
non verbalmente in un modo che non è coerente con i loro sentimenti sottostanti. Per esempio,<br />
durante un colloquio <strong>di</strong> assunzione, allo scopo <strong>di</strong> dare una buona impressione al selezionatore, un<br />
can<strong>di</strong>dato intervistato cerca <strong>di</strong> mostrare un contegno piacevole ed espressivo, anche se non prova<br />
particolari sentimenti nei riguar<strong>di</strong> dell’interlocutore.<br />
Il limite <strong>di</strong> questi modelli è che hanno posto l’attenzione principalmente sulla trasmissione<br />
(emissione) o parte comportamentale della comunicazione non verbale. L’attenzione alla<br />
ricezione o percezione della comunicazione non verbale è stata piuttosto bassa ed è stata<br />
perseguita soltanto quando si è trattato <strong>di</strong> spiegare gli aggiustamenti comportamentali successivi<br />
8