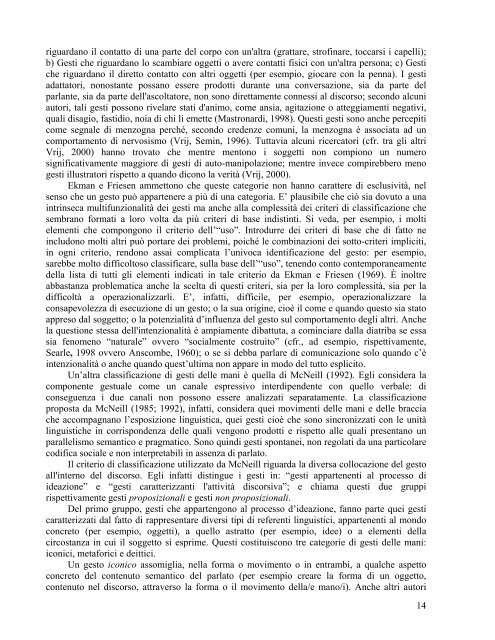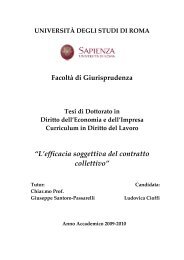Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
iguardano il contatto <strong>di</strong> una parte del corpo con un'altra (grattare, strofinare, toccarsi i capelli);<br />
b) Gesti che riguardano lo scambiare oggetti o avere contatti fisici con un'altra persona; c) Gesti<br />
che riguardano il <strong>di</strong>retto contatto con altri oggetti (per esempio, giocare con la penna). I gesti<br />
adattatori, nonostante possano essere prodotti durante una conversazione, sia da parte del<br />
parlante, sia da parte dell'ascoltatore, non sono <strong>di</strong>rettamente connessi al <strong>di</strong>scorso; secondo alcuni<br />
autori, tali gesti possono rivelare stati d'animo, come ansia, agitazione o atteggiamenti negativi,<br />
quali <strong>di</strong>sagio, fasti<strong>di</strong>o, noia <strong>di</strong> chi li emette (Mastronar<strong>di</strong>, 1998). Questi gesti sono anche percepiti<br />
come segnale <strong>di</strong> menzogna perché, secondo credenze comuni, la menzogna è associata ad un<br />
comportamento <strong>di</strong> nervosismo (Vrij, Semin, 1996). Tuttavia alcuni ricercatori (cfr. tra gli altri<br />
Vrij, 2000) hanno trovato che mentre mentono i soggetti non compiono un numero<br />
significativamente maggiore <strong>di</strong> gesti <strong>di</strong> auto-manipolazione; mentre invece compirebbero meno<br />
gesti illustratori rispetto a quando <strong>di</strong>cono la verità (Vrij, 2000).<br />
Ekman e Friesen ammettono che queste categorie non hanno carattere <strong>di</strong> esclusività, nel<br />
senso che un gesto può appartenere a più <strong>di</strong> una categoria. E’ plausibile che ciò sia dovuto a una<br />
intrinseca multifunzionalità dei gesti ma anche alla complessità dei criteri <strong>di</strong> classificazione che<br />
sembrano formati a loro volta da più criteri <strong>di</strong> base in<strong>di</strong>stinti. Si veda, per esempio, i molti<br />
elementi che compongono il criterio dell’“uso”. Introdurre dei criteri <strong>di</strong> base che <strong>di</strong> fatto ne<br />
includono molti altri può portare dei problemi, poiché le combinazioni dei sotto-criteri impliciti,<br />
in ogni criterio, rendono assai complicata l’univoca identificazione del gesto: per esempio,<br />
sarebbe molto <strong>di</strong>fficoltoso classificare, sulla base dell’“uso”, tenendo conto contemporaneamente<br />
della lista <strong>di</strong> tutti gli elementi in<strong>di</strong>cati in tale criterio da Ekman e Friesen (1969). È inoltre<br />
abbastanza problematica anche la scelta <strong>di</strong> questi criteri, sia per la loro complessità, sia per la<br />
<strong>di</strong>fficoltà a operazionalizzarli. E’, infatti, <strong>di</strong>fficile, per esempio, operazionalizzare la<br />
consapevolezza <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> un gesto; o la sua origine, cioè il come e quando questo sia stato<br />
appreso dal soggetto; o la potenzialità d’influenza del gesto sul comportamento <strong>degli</strong> altri. Anche<br />
la questione stessa dell'intenzionalità è ampiamente <strong>di</strong>battuta, a cominciare dalla <strong>di</strong>atriba se essa<br />
sia fenomeno “naturale” ovvero “socialmente costruito” (cfr., ad esempio, rispettivamente,<br />
Searle, 1998 ovvero Anscombe, 1960); o se si debba parlare <strong>di</strong> comunicazione solo quando c’è<br />
intenzionalità o anche quando quest’ultima non appare in modo del tutto esplicito.<br />
Un’altra classificazione <strong>di</strong> gesti delle mani è quella <strong>di</strong> McNeill (1992). Egli considera la<br />
componente gestuale come un canale espressivo inter<strong>di</strong>pendente con quello verbale: <strong>di</strong><br />
conseguenza i due canali non possono essere analizzati separatamente. La classificazione<br />
proposta da McNeill (1985; 1992), infatti, considera quei movimenti delle mani e delle braccia<br />
che accompagnano l’esposizione linguistica, quei gesti cioè che sono sincronizzati con le unità<br />
linguistiche in corrispondenza delle quali vengono prodotti e rispetto alle quali presentano un<br />
parallelismo semantico e pragmatico. Sono quin<strong>di</strong> gesti spontanei, non regolati da una particolare<br />
co<strong>di</strong>fica sociale e non interpretabili in assenza <strong>di</strong> parlato.<br />
Il criterio <strong>di</strong> classificazione utilizzato da McNeill riguarda la <strong>di</strong>versa collocazione del gesto<br />
all'interno del <strong>di</strong>scorso. Egli infatti <strong>di</strong>stingue i gesti in: “gesti appartenenti al processo <strong>di</strong><br />
ideazione” e “gesti caratterizzanti l'attività <strong>di</strong>scorsiva”; e chiama questi due gruppi<br />
rispettivamente gesti proposizionali e gesti non proposizionali.<br />
Del primo gruppo, gesti che appartengono al processo d’ideazione, fanno parte quei gesti<br />
caratterizzati dal fatto <strong>di</strong> rappresentare <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> referenti linguistici, appartenenti al mondo<br />
concreto (per esempio, oggetti), a quello astratto (per esempio, idee) o a elementi della<br />
circostanza in cui il soggetto si esprime. Questi costituiscono tre categorie <strong>di</strong> gesti delle mani:<br />
iconici, metaforici e deittici.<br />
Un gesto iconico assomiglia, nella forma o movimento o in entrambi, a qualche aspetto<br />
concreto del contenuto semantico del parlato (per esempio creare la forma <strong>di</strong> un oggetto,<br />
contenuto nel <strong>di</strong>scorso, attraverso la forma o il movimento della/e mano/i). Anche altri autori<br />
14