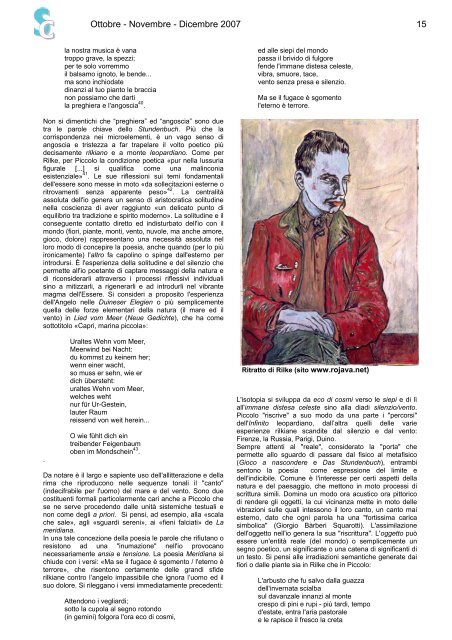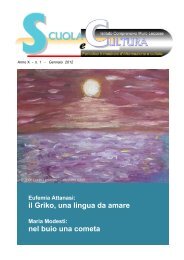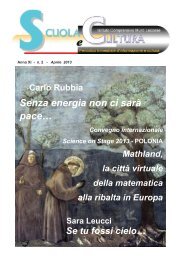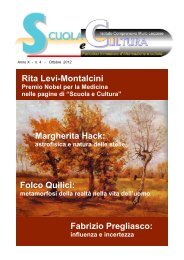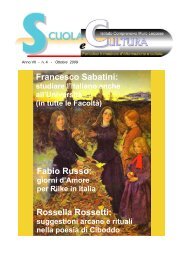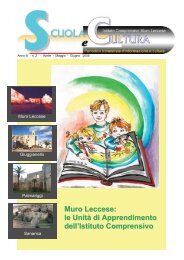Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Ottobre</strong> - Novembre - Dicembre <strong>2007</strong> 15<br />
la nostra musica è vana<br />
troppo grave, la spezzi;<br />
per te solo vorremmo<br />
il balsamo ignoto, le bende...<br />
ma sono inchiodate<br />
dinanzi al tuo pianto le braccia<br />
non possiamo che darti<br />
la preghiera e l'angoscia 40 .<br />
Non si dimentichi che “preghiera” ed “angoscia” sono due<br />
tra le parole chiave dello Stundenbuch. Più che la<br />
corrispondenza nei microelementi, è un vago senso di<br />
angoscia e tristezza a far trapelare il volto poetico più<br />
decisamente rilkiano e a monte leopardiano. Come per<br />
Rilke, per Piccolo la condizione poetica «pur nella lussuria<br />
figurale [...] si qualifica come una malinconia<br />
esistenziale» 41 . Le sue riflessioni sui temi fondamentali<br />
dell'essere sono messe in moto «da sollecitazioni esterne o<br />
ritrovamenti senza apparente peso» 42 . La centralità<br />
assoluta dell'io genera un senso di aristocratica solitudine<br />
nella coscienza di aver raggiunto «un delicato punto di<br />
equilibrio tra tradizione e spirito moderno». La solitudine e il<br />
conseguente contatto diretto ed indisturbato dell'io con il<br />
mondo (fiori, piante, monti, vento, nuvole, ma anche amore,<br />
gioco, dolore) rappresentano una necessità assoluta nel<br />
loro modo di concepire la poesia, anche quando (per lo più<br />
ironicamente) l'altro fa capolino o spinge dall'esterno per<br />
introdursi. È l'esperienza della solitudine e del silenzio che<br />
permette all'io poetante di captare messaggi della natura e<br />
di riconsiderarli attraverso i processi riflessivi individuali<br />
sino a mitizzarli, a rigenerarli e ad introdurli nel vibrante<br />
magma dell'Essere. Si consideri a proposito l'esperienza<br />
dell'Angelo nelle Duineser Elegien o più semplicemente<br />
quella delle forze elementari della natura (il mare ed il<br />
vento) in Lied vom Meer (Neue Gedichte), che ha come<br />
sottotitolo «Capri, marina piccola»:<br />
.<br />
Uraltes Wehn vom Meer,<br />
Meerwind bei Nacht:<br />
du kommst zu keinem her;<br />
wenn einer wacht,<br />
so muss er sehn, wie er<br />
dich übersteht:<br />
uraltes Wehn vom Meer,<br />
welches weht<br />
nur für Ur-Gestein,<br />
lauter Raum<br />
reissend von weit herein...<br />
O wie fühlt dich ein<br />
treibender Feigenbaum<br />
oben im Mondschein 43 .<br />
Da notare è il largo e sapiente uso dell'allitterazione e della<br />
rima che riproducono nelle sequenze tonali il "canto"<br />
(indecifrabile per l'uomo) del mare e del vento. Sono due<br />
costituenti formali particolarmente cari anche a Piccolo che<br />
se ne serve procedendo dalle unità sistemiche testuali e<br />
non come degli a priori. Si pensi, ad esempio, alla «scala<br />
che sale», agli «sguardi sereni», ai «fieni falciati» de La<br />
meridiana.<br />
In una tale concezione della poesia le parole che rifiutano o<br />
resistono ad una "inumazione" nell'io provocano<br />
necessariamente ansia e tensione. La poesia Meridiana si<br />
chiude con i versi: «Ma se il fugace è sgomento / l'eterno è<br />
terrore», che risentono certamente delle grandi sfide<br />
rilkiane contro l’angelo impassibile che ignora l’uomo ed il<br />
suo dolore. Si rileggano i versi immediatamente precedenti:<br />
Attendono i vegliardi;<br />
sotto la cupola al segno rotondo<br />
(in gemini) folgora l'ora eco di cosmi,<br />
ed alle siepi del mondo<br />
passa il brivido di fulgore<br />
fende l'immane distesa celeste,<br />
vibra, smuore, tace,<br />
vento senza presa e silenzio.<br />
Ma se il fugace è sgomento<br />
l'eterno è terrore.<br />
Ritratto di Rilke (sito www.rojava.net)<br />
L'isotopia si sviluppa da eco di cosmi verso le siepi e di lì<br />
all'immane distesa celeste sino alla diadi silenzio/vento.<br />
Piccolo "riscrive" a suo modo da una parte i "percorsi"<br />
dell'Infinito leopardiano, dall’altra quelli delle varie<br />
esperienze rilkiane scandite dal silenzio e dal vento:<br />
Firenze, la Russia, Parigi, Duino.<br />
Sempre attenti al "reale", considerato la "porta" che<br />
permette allo sguardo di passare dal fisico al metafisico<br />
(Gioco a nascondere e Das Stundenbuch), entrambi<br />
sentono la poesia come espressione del limite e<br />
dell'indicibile. Comune è l'interesse per certi aspetti della<br />
natura e del paesaggio, che mettono in moto processi di<br />
scrittura simili. Domina un modo ora acustico ora pittorico<br />
di rendere gli oggetti, la cui vicinanza mette in moto delle<br />
vibrazioni sulle quali intessono il loro canto, un canto mai<br />
esterno, dato che ogni parola ha una "fortissima carica<br />
simbolica" (Giorgio Bàrberi Squarotti). L'assimilazione<br />
dell'oggetto nell'io genera la sua "riscrittura". L'oggetto può<br />
essere un'entità reale (del mondo) o semplicemente un<br />
segno poetico, un significante o una catena di significanti di<br />
un testo. Si pensi alle irradiazioni semantiche generate dai<br />
fiori o dalle piante sia in Rilke che in Piccolo:<br />
L'arbusto che fu salvo dalla guazza<br />
dell'invernata scialba<br />
sul davanzale innanzi al monte<br />
crespo di pini e rupi - più tardi, tempo<br />
d'estate, entra l'aria pastorale<br />
e le rapisce il fresco la creta