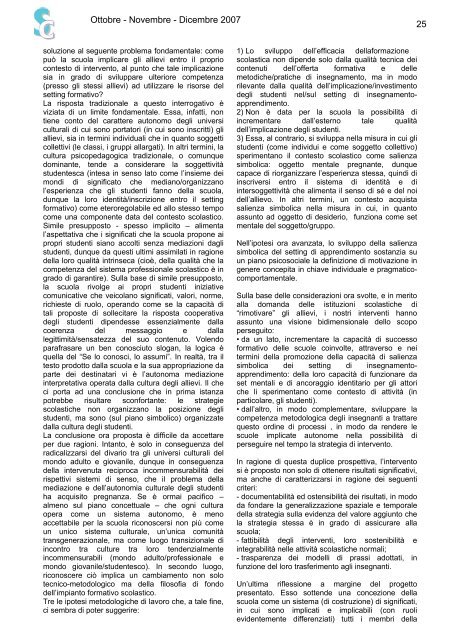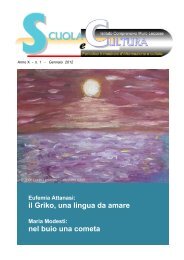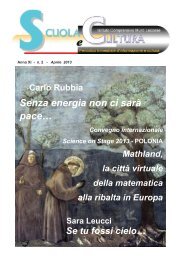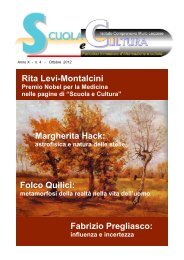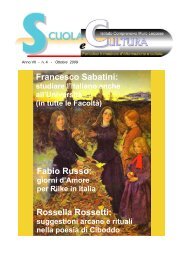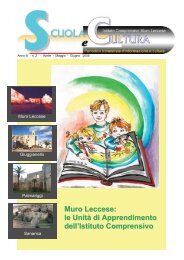Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Ottobre</strong> - Novembre - Dicembre <strong>2007</strong><br />
soluzione al seguente problema fondamentale: come<br />
può la <strong>scuola</strong> implicare gli allievi entro il proprio<br />
contesto di intervento, al punto che tale implicazione<br />
sia in grado di sviluppare ulteriore competenza<br />
(presso gli stessi allievi) ad utilizzare le risorse del<br />
setting formativo?<br />
La risposta tradizionale a questo interrogativo è<br />
viziata di un limite fondamentale. Essa, infatti, non<br />
tiene conto del carattere autonomo degli universi<br />
<strong>cultura</strong>li di cui sono portatori (in cui sono inscritti) gli<br />
allievi, sia in termini individuali che in quanto soggetti<br />
collettivi (le classi, i gruppi allargati). In altri termini, la<br />
<strong>cultura</strong> psicopedagogica tradizionale, o comunque<br />
dominante, tende a considerare la soggettività<br />
studentesca (intesa in senso lato come l’insieme dei<br />
mondi di significato che mediano/organizzano<br />
l’esperienza che gli studenti fanno della <strong>scuola</strong>,<br />
dunque la loro identità/inscrizione entro il setting<br />
formativo) come eteroregolabile ed allo stesso tempo<br />
come una componente data del contesto scolastico.<br />
Simile presupposto - spesso implicito – alimenta<br />
l’aspettativa che i significati che la <strong>scuola</strong> propone ai<br />
propri studenti siano accolti senza mediazioni dagli<br />
studenti, dunque da questi ultimi assimilati in ragione<br />
della loro qualità intrinseca (cioè, della qualità che la<br />
competenza del sistema professionale scolastico è in<br />
grado di garantire). Sulla base di simile presupposto,<br />
la <strong>scuola</strong> rivolge ai propri studenti iniziative<br />
comunicative che veicolano significati, valori, norme,<br />
richieste di ruolo, operando come se la capacità di<br />
tali proposte di sollecitare la risposta cooperativa<br />
degli studenti dipendesse essenzialmente dalla<br />
coerenza del messaggio e dalla<br />
legittimità/sensatezza del suo contenuto. Volendo<br />
parafrasare un ben conosciuto slogan, la logica è<br />
quella del “Se lo conosci, lo assumi”. In realtà, tra il<br />
testo prodotto dalla <strong>scuola</strong> e la sua appropriazione da<br />
parte dei destinatari vi è l’autonoma mediazione<br />
interpretativa operata dalla <strong>cultura</strong> degli allievi. Il che<br />
ci porta ad una conclusione che in prima istanza<br />
potrebbe risultare sconfortante: le strategie<br />
scolastiche non organizzano la posizione degli<br />
studenti, ma sono (sul piano simbolico) organizzate<br />
dalla <strong>cultura</strong> degli studenti.<br />
La conclusione ora proposta è difficile da accettare<br />
per due ragioni. Intanto, è solo in conseguenza del<br />
radicalizzarsi del divario tra gli universi <strong>cultura</strong>li del<br />
mondo adulto e giovanile, dunque in conseguenza<br />
della intervenuta reciproca incommensurabilità dei<br />
rispettivi sistemi di senso, che il problema della<br />
mediazione e dell’autonomia <strong>cultura</strong>le degli studenti<br />
ha acquisito pregnanza. Se è ormai pacifico –<br />
almeno sul piano concettuale – che ogni <strong>cultura</strong><br />
opera come un sistema autonomo, è meno<br />
accettabile per la <strong>scuola</strong> riconoscersi non più come<br />
un unico sistema <strong>cultura</strong>le, un’unica comunità<br />
transgenerazionale, ma come luogo transizionale di<br />
incontro tra culture tra loro tendenzialmente<br />
incommensurabili (mondo adulto/professionale e<br />
mondo giovanile/studentesco). In secondo luogo,<br />
riconoscere ciò implica un cambiamento non solo<br />
tecnico-metodologico ma della filosofia di fondo<br />
dell’impianto formativo scolastico.<br />
Tre le ipotesi metodologiche di lavoro che, a tale fine,<br />
ci sembra di poter suggerire:<br />
1) Lo sviluppo dell’efficacia dellaformazione<br />
scolastica non dipende solo dalla qualità tecnica dei<br />
contenuti dell’offerta formativa e delle<br />
metodiche/pratiche di insegnamento, ma in modo<br />
rilevante dalla qualità dell’implicazione/investimento<br />
degli studenti nel/sul setting di insegnamentoapprendimento.<br />
2) Non è data per la <strong>scuola</strong> la possibilità di<br />
incrementare dall’esterno tale qualità<br />
dell’implicazione degli studenti.<br />
3) Essa, al contrario, si sviluppa nella misura in cui gli<br />
studenti (come individui e come soggetto collettivo)<br />
sperimentano il contesto scolastico come salienza<br />
simbolica: oggetto mentale pregnante, dunque<br />
capace di riorganizzare l’esperienza stessa, quindi di<br />
inscriversi entro il sistema di identità e di<br />
intersoggettività che alimenta il senso di sé e del noi<br />
dell’allievo. In altri termini, un contesto acquista<br />
salienza simbolica nella misura in cui, in quanto<br />
assunto ad oggetto di desiderio, funziona come set<br />
mentale del soggetto/gruppo.<br />
Nell’ipotesi ora avanzata, lo sviluppo della salienza<br />
simbolica del setting di apprendimento sostanzia su<br />
un piano psicosociale la definizione di motivazione in<br />
genere concepita in chiave individuale e pragmaticocomportamentale.<br />
Sulla base delle considerazioni ora svolte, e in merito<br />
alla domanda delle istituzioni scolastiche di<br />
“rimotivare” gli allievi, i nostri interventi hanno<br />
assunto una visione bidimensionale dello scopo<br />
perseguito:<br />
• da un lato, incrementare la capacità di successo<br />
formativo delle scuole coinvolte, attraverso e nei<br />
termini della promozione della capacità di salienza<br />
simbolica dei setting di insegnamentoapprendimento:<br />
della loro capacità di funzionare da<br />
set mentali e di ancoraggio identitario per gli attori<br />
che li sperimentano come contesto di attività (in<br />
particolare, gli studenti).<br />
• dall’altro, in modo complementare, sviluppare la<br />
competenza metodologica degli insegnanti a trattare<br />
questo ordine di processi , in modo da rendere le<br />
scuole implicate autonome nella possibilità di<br />
perseguire nel tempo la strategia di intervento.<br />
In ragione di questa duplice prospettiva, l’intervento<br />
si è proposto non solo di ottenere risultati significativi,<br />
ma anche di caratterizzarsi in ragione dei seguenti<br />
criteri:<br />
- documentabilità ed ostensibilità dei risultati, in modo<br />
da fondare la generalizzazione spaziale e temporale<br />
della strategia sulla evidenza del valore aggiunto che<br />
la strategia stessa è in grado di assicurare alla<br />
<strong>scuola</strong>;<br />
- fattibilità degli interventi, loro sostenibilità e<br />
integrabilità nelle attività scolastiche normali;<br />
- trasparenza dei modelli di prassi adottati, in<br />
funzione del loro trasferimento agli insegnanti.<br />
Un’ultima riflessione a margine del progetto<br />
presentato. Esso sottende una concezione della<br />
<strong>scuola</strong> come un sistema (di costruzione) di significati,<br />
in cui sono implicati e implicabili (con ruoli<br />
evidentemente differenziati) tutti i membri della<br />
25