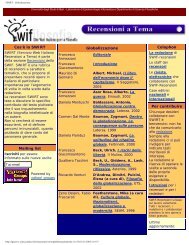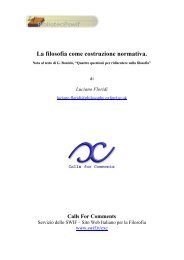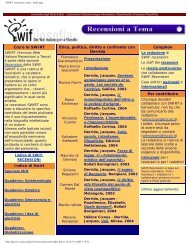indice cronologico maggio 2001 - Swif - Università degli Studi di Bari
indice cronologico maggio 2001 - Swif - Università degli Studi di Bari
indice cronologico maggio 2001 - Swif - Università degli Studi di Bari
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sini, Carlo, Idoli della conoscenza<br />
pratica e della mentalità scientifica che pretende che le verità della scienza siano più vere e<br />
universali <strong>di</strong> tutte le altre in virtù del metodo, della loro capacità pre<strong>di</strong>ttiva e dell'efficacia<br />
reale della loro applicazione al mondo.<br />
Molti scienziati (<strong>di</strong> buone letture epistemologiche) saranno <strong>di</strong>sposti a concedere che<br />
nell'impresa scientifica entrano <strong>di</strong>versi aspetti sociologici, economici, filosofici, ossia molto<br />
più <strong>di</strong> quei presunti "dati <strong>di</strong> realtà" che confermerebbero la teoria. Ma nonostante, non <strong>di</strong>co<br />
Feyerabend, ma anche Popper o Quine, la <strong>maggio</strong>r parte <strong>di</strong> loro (per non <strong>di</strong>re la quasi<br />
totalità) non arriverà mai a porre in <strong>di</strong>scussione quei fatti che la scienza dovrebbe accertare<br />
oggettivamente. "Le verità della scienza, anche se criticamente perfettibili, non sono affatto<br />
relative, almeno tendenzialmente: sono universali, universalmente riproducibili e verificabili,<br />
me<strong>di</strong>ante logica ed esperimento". (p.203) Questa universalità è così evidente che in tutto il<br />
mondo, in<strong>di</strong>pendentemente dalle culture, il modello scientifico trionfa come più vero ed<br />
efficace.<br />
Il presupposto, comune alla scienza e al senso comune, è che le cose accadano come<br />
accadono, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che e dal come le si osserva, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalla pratica teorica che le investe. Il filosofo vuole però indagare i presupposti <strong>di</strong> questa<br />
universalità, ossia mostrare i contorni, la costituzione <strong>di</strong> quest'"immagine" della scienza<br />
trionfante in tutto pianeta. La ricerca genealogica sul fatto della conoscenza e su come<br />
accade la conoscenza scientifica ha proprio il compito <strong>di</strong> portarci verso quella soglia a partire<br />
dalla quale la pratica conoscitiva si costituisce attraverso una serie <strong>di</strong> operazioni che<br />
appunto si tratta <strong>di</strong> esplicitare.<br />
Coerentemente con la pratica filosofica che Sini abita consapevolmente, egli si rivolge a quel<br />
"primo, grande e unico filosofo che egli fu", (p.80) ossia al <strong>di</strong>vino Platone. Ecco, si potrebbe<br />
osservare commentando quest'affermazione, una glossa al motto <strong>di</strong> Whitehead, secondo cui<br />
tutta la filosofia non sarebbe che una glossa a Platone: quella particolare pratica <strong>di</strong>scorsiva,<br />
quell'insieme <strong>di</strong> gesti e atteggiamenti intellettuali che chiamiamo filosofia occidentale sta<br />
tutta dentro l'orizzonte platonico. Ecco perché per comprendere ogni questione filosofica<br />
bisogna ritornare a Platone o riformularla in termini platonici. Una strategia, questa,<br />
ampiamente consolidata e praticata che non è certo l'unica , ma è coerente con un certo<br />
modo <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> fare filosofia.<br />
Ritornando a Platone, Sini sceglie <strong>di</strong> mettere a fuoco il Cratilo, laddove si mostra bene il<br />
problema della separazione tra i nomi e le cose, tra il linguaggio e la realtà. Partendo dalla<br />
questione sofistica sulla naturalità o convenzionalità dei nomi, Platone giunge al problema<br />
del significato. Così Sini in<strong>di</strong>ca il cuore <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>alogo: che cos'hanno in comune il nome e<br />
la cosa, cioè l'immagine che è il nome e la cosa che viene così significata? O come lo<br />
riproporrà nel Novecento il Wittgenstein del Tractatus: come fa la parola "nave" a significare<br />
la nave? Non c'è alcun rapporto <strong>di</strong> somiglianza come , poniamo, tra un <strong>di</strong>segno e il soggetto<br />
ritratto. La parola non imita come la musica e la pittura riferendosi all'aspetto sensibile delle<br />
cose, suoni, tratti colori; essa imita "l'essenza" della cosa. Si potrebbe far riferimento con<br />
Wittgenstein alla "raffigurazione": attraverso un rapporto stabilisco una similitu<strong>di</strong>ne. "Ecco<br />
due fiammiferi sul tavolo. Li pongo in modo da mostrare al giu<strong>di</strong>ce come è avvenuto<br />
l'incidente stradale. Nessuna proprietà del tavolo e dei fiammiferi ha una materia uguale alla<br />
strada e alle automobili, ma la <strong>di</strong>rezione dei fiammiferi corrisponde alla <strong>di</strong>rezione delle<br />
http://lgxserve.ciseca.uniba.it/lei/recensioni/crono/<strong>2001</strong>-05/sini.htm (3 of 7) [09/11/2005 21.25.48]