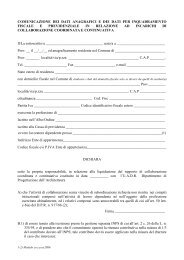letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze
letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze
letture - Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
14<br />
cidentali. È in quegli anni infatti che viene<br />
concepito il piano ambizioso dell’ultima<br />
cinta, legato con ogni probabilità<br />
proprio a tale favorevole congiuntura<br />
economica. La città comincia ad avere<br />
un peso sempre più consistente nello<br />
scacchiere internazionale, anche per<br />
l’intraprendenza dei suoi mercanti, tra i<br />
primi in Europa ad affiancare alle attività<br />
commerciali quelle bancarie: Bar<strong>di</strong> e<br />
Peruzzi finanziano ad<strong>di</strong>rittura le campagne<br />
militari della corona inglese. Il<br />
piano urbanistico <strong>di</strong> Arnolfo (a <strong>Firenze</strong>,<br />
<strong>di</strong>ce Vasari, “niuna cosa d’importanza<br />
senza il suo consiglio si deliberava”)<br />
sancisce <strong>di</strong> fatto la tripartizione dei poteri<br />
nella specializzazione funzionale<br />
delle tre principali piazze “pubbliche”,<br />
piazza del Duomo, dei Priori e quella<br />
interme<strong>di</strong>a del mercato del Grano. Allineate<br />
tutte lungo l’asse processionale<br />
<strong>di</strong> corso <strong>degli</strong> A<strong>di</strong>mari (l’attuale via dei<br />
Calzaiuoli), e caratterizzate architettonicamente<br />
dalla presenza <strong>di</strong> una loggia<br />
autonoma a destinazione <strong>di</strong>versa:<br />
commerciale l’Orsanmichele (la prima<br />
ad essere e<strong>di</strong>ficata), religiosa quella<br />
della Confraternita del Bigallo (1352-<br />
1358) e politico-giuris<strong>di</strong>zionale la loggia<br />
della Signoria (1378-1381).<br />
C’è da <strong>di</strong>re a riguardo che a <strong>Firenze</strong>,<br />
come in molte altre città italiane (Venezia<br />
e Genova: quest’ultima in particolare<br />
qui documentata dalle relazioni <strong>di</strong> A.<br />
Paro<strong>di</strong>, M. L. Falci<strong>di</strong>eno, P. Falzone, M.<br />
Caraffini, G. Pellegri), 10 le logge fanno<br />
parte del costume e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> base, rivestendo<br />
un ruolo importante nelle vicende<br />
processuali delle tipologie abitative<br />
delle cosiddette case-corti mercantili,<br />
dove la presenza <strong>di</strong> un vano aperto a<br />
piano terra rappresenta una fondamen-<br />
72<br />
tale risorsa funzionale, variamente conformata<br />
e <strong>di</strong>sposta a seconda sia delle<br />
<strong>di</strong>verse specificità connesse all’area<br />
culturale, che delle possibili varianti posizionali<br />
nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (le cosiddette<br />
“varianti sincroniche”). 11 A <strong>Firenze</strong><br />
le strade centrali della “città romana”<br />
sono caratterizzate da potenti serie<br />
continue <strong>di</strong> alte arcate a bugnato, che<br />
costituiscono i segni residui della <strong>di</strong>ffusione<br />
delle logge delle case mercantili,<br />
oggi sostituite da negozi o variamente<br />
richiuse e trasformate. Le famiglie più<br />
ricche, come i già citati Peruzzi (che per<br />
il crack finanziario causato dagli enormi<br />
cre<strong>di</strong>ti non rimborsati da parte del re<br />
d’Inghilterra si videro costretti a interrompere<br />
la costruzione della propria<br />
loggia), e ancora nel Quattrocento i Rucellai,<br />
si erano fatti e<strong>di</strong>ficare logge isolate,<br />
ossia non più inserite al piano terra<br />
della propria casa-corte, ma prospicienti<br />
a quello che stava <strong>di</strong>venendo tipologicamente<br />
un palazzo. 12 Potendo<br />
in tal modo utilizzarle, oltre che per gli<br />
affari correnti, come luoghi <strong>di</strong> rappresentanza<br />
in determinate celebrazioni<br />
familiari (feste, matrimoni, ecc.).<br />
Il fenomeno della formazione del palazzo<br />
rinascimentale è argomento troppo<br />
complesso per essere trattato in questa<br />
sede: per ciò che attiene le logge,<br />
occorre solo sottolineare l’inversione <strong>di</strong><br />
tendenza dall’atteggiamento urbano<br />
per così <strong>di</strong>re “estroverso” della casacorte<br />
trecentesca a quello “introverso”<br />
del palazzo quattrocentesco, che determina<br />
la progressiva trasformazione<br />
della loggia nel porticato più o meno rigirante<br />
attorno al cortile dell’e<strong>di</strong>ficio. È<br />
significativo a riguardo ciò che avviene<br />
a palazzo Me<strong>di</strong>ci, dove la chiusura del-<br />
la loggia d’angolo è attuata da Michelangelo<br />
nei primi anni del Cinquecento<br />
allorché il potere citta<strong>di</strong>no è ormai saldamente<br />
nelle mani <strong>di</strong> questa famiglia.<br />
Uguale sorte subiscono i “liberi comuni”<br />
italiani, che con le Signorie vedono<br />
infranto per varie ragioni l’avanzato<br />
progetto politico <strong>di</strong> autonomia, portato<br />
avanti da ciascuno <strong>di</strong> essi per più <strong>di</strong> un<br />
secolo e mezzo: un po’ per l’azione <strong>di</strong>sgregatrice<br />
delle fazioni interne, che<br />
non esitavano ad allearsi coi nemici<br />
esterni, pur <strong>di</strong> prevalere; ma soprattutto<br />
a causa dei mutati equilibri internazionali.<br />
Al consolidamento delle principali<br />
potenze europee (Inghilterra e<br />
Francia, con la fine della guerra dei<br />
Cent’anni; ma soprattutto la Spagna,<br />
avviata, con la scoperta dell’America,<br />
la Reconquista e la riunificazione nazionale,<br />
ad assumere le re<strong>di</strong>ni dell’Impero)<br />
aveva fatto riscontro in Italia il ritorno<br />
in grande stile (dopo l’esilio<br />
d’Avignone) del Papato, che rappresentava<br />
bene o male l’unica forza competitiva<br />
su base territoriale, in virtù del<br />
potere spirituale <strong>di</strong> cui era ancora saldamente<br />
possesso e che ancora impiegava<br />
con successo nella politica internazionale.<br />
Era in pratica ricominciata<br />
la secolare partita tra Impero e<br />
Papato, dopo il giro <strong>di</strong> mano dei liberi<br />
comuni italiani nella breve stagione<br />
delle loro autonomie.<br />
Il terzo ciclo delle logge (1500-1750), <strong>di</strong><br />
“consolidamento tipologico”, coincide<br />
in Toscana con l’età granducale (1569-<br />
1737), preceduta tuttavia dalla presa<br />
del potere da parte <strong>di</strong> Cosimo I (1537),<br />
che può essere a ragione considerato il<br />
fondatore del primo consistente stato<br />
italiano dopo quello della Chiesa. La