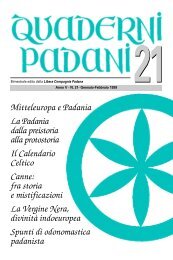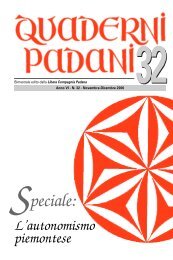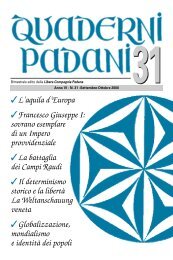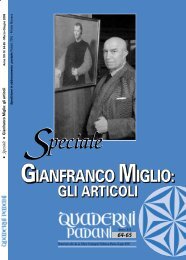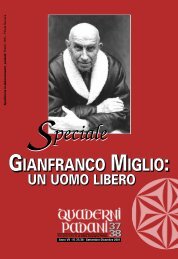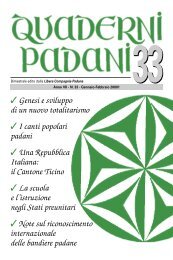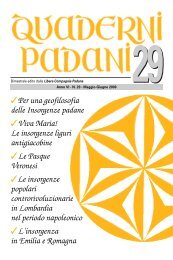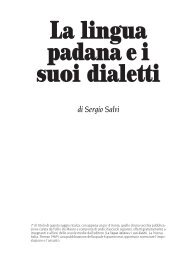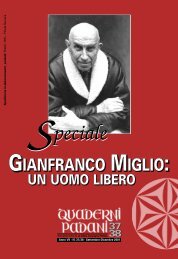Scarica PDF - La Libera Compagnia Padana
Scarica PDF - La Libera Compagnia Padana
Scarica PDF - La Libera Compagnia Padana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mata “Etruria”, erede cioè della tradizione etrusca<br />
e comprendente anche parte dell’Umbria e<br />
del <strong>La</strong>zio. Gli scambi culturali tra Etruria e Padania<br />
erano in quei secoli sicuramente intensi<br />
(più che tra Etruria e terre italiche), tuttavia,<br />
sul piano linguistico-letterario non si può negare<br />
una certa differenza di impostazione e comunicazione,<br />
riconducibile soprattutto alla<br />
non-celticità della Toscana stessa.<br />
Dobbiamo dunque definire “capolavoro della<br />
letteratura toscana” la Divina Commedia (e capolavoro<br />
al tempo stesso della letteratura mondiale,<br />
senza dimenticare comunque che fu ideata<br />
e in parte scritta in Padania durante l’esilio<br />
dantesco); quanto a Dante poi non si può non<br />
riprendere in esame il suo De Vulgari Eloquentia<br />
per sottolineare pregiudizi e arroganza di<br />
valutazione nei giudizi espressi nei confronti<br />
dei linguaggi padani. Se l’Alighieri giudicò inadeguati<br />
alla parlata italiana volgare il milanese<br />
ed il bergamasco, foneticamente insopportabili<br />
i dialetti veneti, gravati da una “zeta” troppo<br />
aspra i genovesi, praticamente stranieri i vernacoli<br />
di Torino, Trento ed Alessandria, troppo<br />
gutturali i dialetti ovest-emiliani, con conseguenze<br />
negative per le rispettive culture letterarie,<br />
lo si deve ad una visione un po’ forzata<br />
dell’italianità, basata unicamente sul modello<br />
tosco-bolognese e già pesantemente votata ad<br />
una sorta di neutralizzazione culturale delle<br />
terre poste ad ovest dell’Enza e a nord del Po.<br />
D’altra parte il senso di estraneità provata da<br />
un famoso toscano nei confronti di queste ultime<br />
conferma le profonde differenze tra Continente<br />
e Penisola, che a quei tempi solo una minoranza<br />
di abitanti della penisola stessa voleva<br />
cancellare.<br />
E veniamo ai tempi umanistico-rinascimentali.<br />
<strong>La</strong> Padania trova nei reggiani Boiardo e<br />
Ariosto due grandi interpreti dell’epos cavalleresco,<br />
due autori che a sud dell’Appennino non<br />
potrebbero mai esser fioriti. Forte è infatti l’eco<br />
della cultura francese e decisamente continentale<br />
la capacità di far viaggiare il lettore in ogni<br />
parte dell’universo assieme ai vari paladini, senza<br />
contare lo spirito di ironico ottimismo che<br />
nulla ha a che fare col sarcasmo toscano, il fatalismo<br />
italico ed il tragico (o farsesco) pessimismo<br />
siciliano. In Etruria il mondo di Orlando<br />
ha trovato solo la goliardica presa in giro di<br />
un Pulci ed in Sicilia ha fornito materia per il<br />
tragicomico teatrino dei pupi, senza ispirare<br />
altro tipo di letteratura.<br />
Alle spalle dei due reggiani ci fu la corte fer-<br />
rarese, magnifico esempio di cultura padana in<br />
grado di rielaborare il meglio di tutta Europa<br />
sia in ambito letterario che in ambito artistico,<br />
apportandovi con gran classe lo spirito fattivo<br />
degli “eridani”, la capacità per certi aspetti inimitata<br />
di tradurre la cultura in ricchezza e la<br />
ricchezza in nuova cultura, senza mai dimenticare<br />
l’ispirazione popolare.<br />
E a Ferrara predicava Gerolamo Savonarola,<br />
un frate di grandi qualità retoriche e letterarie,<br />
che ebbe non a caso per primo il coraggio di<br />
condannare la corruzione romana, rifacendosi<br />
ad un’altissima moralità.<br />
Ma il meglio della cultura padana tra Quattrocento<br />
e Cinquecento sta forse tra Mantova e<br />
Venezia, le due capitali del 1996.<br />
Il mantovano e il padovano di cui “menar vanto”<br />
sono Teofilo Folengo e il Ruzzante, ma anche<br />
il veneziano Bembo merita una rivalutazione<br />
quanto a padanità.<br />
Folengo scrive in una lingua macheronica che<br />
mischia latino e linguaggio padano in un impasto<br />
di straordinaria freschezza e incisività: con<br />
questo strumento in codice che sa tanto di critica<br />
nei confronti di un italiano imposto dalle<br />
classi più abbienti (in qualche modo traditrici<br />
della sanguignità popolare della “Bassa”), ci racconta<br />
il mondo contadino della pianura padana<br />
in tutta la sua realistica generosità e spontaneità,<br />
in barba a quegli intellettuali cinquecenteschi<br />
d’Italia, d’Etruria e in parte della stessa<br />
Padania che cominciano a far credere che non<br />
esista più.<br />
Il Ruzante, specie nella commedia Betìa, mette<br />
in gioco istinti ancor più animaleschi, usando<br />
direttamente il dialetto, un patavino schietto<br />
e ruspante capace di rappresentare perfettamente<br />
la forza dei sentimenti dei più umili, di<br />
un popolo padano che di fronte alle angherie<br />
dei potenti risponde con la manifestazione ingenua<br />
e limpida delle sue gioie e dei suoi dolori.<br />
Di fronte alla primitività del contado sta la<br />
speculazione filosofica dell’aristocrazia veneta,<br />
in parte già piegata agli interessi delle altre aristocrazie<br />
italiane ed europee, plagiata da quelle<br />
forze che iniziano a reclamare l’Unità a tutti i<br />
costi.<br />
Così un Pietro Bembo, costretto dal padre ambasciatore<br />
a respirare l’aria prima di Firenze e<br />
successivamente di Messina, torna a Venezia e<br />
scrive un saggio, Prose della volgar lingua<br />
(1525), in cui esalta la lingua letteraria toscana,<br />
proponendola come modello per tutti gli<br />
Anno III, N. 9 - Gennaio-Febbraio 1997 Quaderni Padani - 29