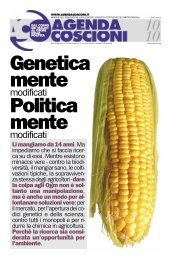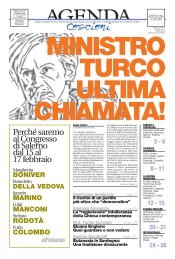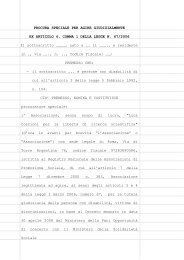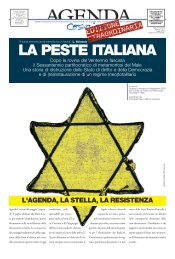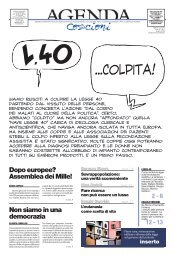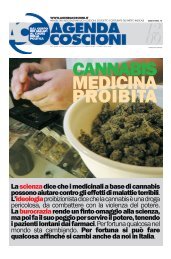Per - Associazione Luca Coscioni
Per - Associazione Luca Coscioni
Per - Associazione Luca Coscioni
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
on line www.agendacoscioni.it - www.freedomofresearch.orgNeuroscienze/2Neuroscienze?Neuroetica!❝Eric RacineIl mio approccio personale si basasulla convinzione che dobbiamoaffrontare le sfide etiche e sociali inmodo propositivo. Ciò significa chequeste questioni non sonosemplicemente timori. Sono sfide,potenzialmente, ed è nostrocompito trovare soluzioni atte adaffrontarle. Ci piacerebbe nutrireuna visione semplice e idealistica deirapporti tra scienza e società. Miappellerò all’opera di una celebrestudiosa di comunicazione dellascienza, Dorothy Nelkin, perevidenziare come questo non siapossibile. Lei sostiene che “Il modoin cui il pubblico percepisce laricerca e ne interpreta costi e beneficipuò essere influenzato non tanto daiparticolari delle prove scientifichequanto dai messaggi mediatici.”Piuttosto preoccupante, direi. C’èpoi anche qualcos’altro che nondimentico, ed è il rapporto tral’autonomia e la libertà scientifica,da un lato e, dall’altro, gli obblighietici posti in essere dalla condottadella ricerca.Vorrei spendere alcune parole sullaneuroetica. La neuroeticarappresenta una risposta allarivoluzione della neuroscienza. Laneuroetica è stata definita in varimodi. La definizione che segue èstata proposta dalla collega JudyIlles, insieme a me:“La neuroetica è un nuovo campo postoall’intersezione tra bioetica eneuroscienza, che studia l’etica dellaricerca sulle neuroscienze e le questionietiche che emergono nella trasposizionedella ricerca sulle neuroscienzenell’ambito clinico e pubblico.Nonostante l’animato dibattito che verteattorno alla natura di questo nuovocampo, il fattore più importante a suofavore è l’opportunità di richiamareancor più l’attenzione sullo studio el’integrazione dell’etica delle specialitàmediche (neurologia, psichiatria eneurochirurgia) e dell’etica della ricercacorrelata allo scopo di migliorare la curadei pazienti”.Questa definizione pone l’accentosulla neuroetica in quanto etica dellaricerca sulle neuroscienze e sullequestioni etiche che emergono nellatrasposizione della ricerca sulleneuroscienze negli ambiti clinici epubblici. Conseguentemente, laneuroetica viene considerataun’opportunità per migliorare lostudio e l’integrazione dell’eticadelle specialità mediche al fine di farprogredire le cure per i pazienti.Il mio è un approccio pragmatico e,dal mio punto di vista, la neuroeticasi pone chiaramente degli obiettivipratici. Riconosco comunque,pronunciando queste parole, cheesistono numerosi altri obiettiviperseguiti dalla neuroetica. Essa èvista anche come un'opportunità perpromuovere il dialogo e il pubblicodibattito, nonché come un modoper affrontare alcune annoseesigenze di base dell'assistenzasanitaria per specifiche popolazionidi pazienti neurologici.Penso che la neuroetica e laEricRacineDirettoredell’Unità diRicerca inNeuroetica,pressol’Istituto diricerca clinicadi Montreal.È editoreassociatodella rivistaNeuroeticarivoluzione della neuroscienzamettano in rilievo una serie diresponsabilità etiche di cui ènecessario farsi carico. Devonoessere affrontate dalla comunitàscientifica con il contributo dellealtre parti in causa. Sonoresponsabilità che vanno dallanecessità di garantire l’integrità nelmondo della ricerca a quella diaffrontare in modo propositivo lequestioni etiche generate dallaneuroscienza. La mia ricercadimostra che dobbiamoabbandonare l’idea che i media – enon solo i media, la divulgazionescientifica in generale – siano unsemplice canale di informazione. Seeravamo convinti che gli espertiscientifici potessero trasmettere inmodo semplice e diretto i proprimessaggi ai media, è bene cherivediamo le nostre posizioni. Larealtà, secondo me, è ben piùcomplicata. La comunicazionescientifica deve adottare unapproccio da definire caso per caso,a seconda del tipo di tecnologie e diproblematiche chiamate in causa.Dobbiamo peraltro considerarel’ipotesi di un modello piùdinamico di comunicazionescientifica, in cui gli scienziati sisforzino di partecipare alladiscussione pubblica e al pubblicodialogo per spiegare la logica da cuimuove il loro studio.Alla base di questo modello, cheabbiamo presentato diversi anni fain Nature Reviews Neuroscience sipone l’idea che la scienzarappresenti un modello per ilpubblico dibattito perché al centrodi questo approccio troviamo nonsolo la discussione pubblica, maanche un modello basato su alcuniobblighi minimi nei confronti di unragionevole dibattito pubblico. Intal senso, la scienza può offrire unmodello estremamente interessanteper il discorso pubblico.21KathinkaEversProfessoreassociato,ricercatoresenior pressoil Centro diricerca Etica eBioetica,all’Universitàdi Uppsala,Svezia, dovedirige anchela ricerca e ladidattica inNeuroeticaNeuroscienze/3La personaneuronaleè veramentesveglia!Kathinka EversIl XXI secolo ha visto un rapido sviluppo dellaneuroscienza e la nascita di una nuova disciplinaaccademica: la neuroetica, ossia il tentativo di spiegare unaparte del giudizio morale in termini di neurobiologia. Èbene distinguere anzitutto tra neuroetica fondamentale,ossia la ricerca su come la conoscenza dell’architetturafunzionale del cervello e la sua evoluzione ci possanoaiutare a capire meglio il pensiero e il giudizio morale, ela neuroetica applicata, che affronta le questioni etichesollevate dalle nuove tecniche di neuroimaging, dalmiglioramento cognitivo o dalla neurofarmacologia. Laneuroetica genera tanta speranza quanta apprensione; laconsapevolezza storica è essenziale per determinare lanatura e la ragion d’essere di questa nuova area di ricerca.Obiettivo di questa presentazione è presentare laneuroetica assieme ad un modello dinamico del cervelloe della mente umana su cui essa possa proficuamenteessere costruita. Storicamente, minacce alla libertàscientifica sono venute da forze politiche e religiose. È notoche le scienze della mente per secoli sono state ostacolateda dogmi cattolici, come quello dell’immaterialità dellospirito dell’uomo. Tuttavia, nel corso del XX secolo, leprincipali minacce a questa parte dello sviluppo scientificonon sono venute dal potere religioso, bensì dalla scienzastessa. Quando, dopo molto tempo, alla fine del XIXsecolo, la scienza della mente è stata finalmente libera distudiare il cervello e la mente umana, essa ha sviluppatoperò la psicofobia. Le teorie scientifiche sulla naturaumana e la mente nel XIX e XX secolo si sono a volteimbattute in due principali trappole: quella del“dirottamento” ideologico e quella della psicofobia, nelleforme dell’ingenuo eliminativismo e dell’ingenuocognitivismo. <strong>Per</strong> non cadere in queste trappole laneuroetica deve costruire solide fondamenta filosofiche escientifiche di un materialismo informato che adotti unavisione evolutiva della coscienza come una parteirriducibile della realtà biologica, quale funzioneIn retewww.freedomofresearch.orgsviluppata del cervello e adeguato oggetto di studioscientifico; riconosca che un’adeguata comprensionedell’esperienza soggettiva consapevole deve tener contosia dell’informazione soggettiva, quale risultantedall’auto-riflessione, sia dell’informazione oggettivaottenuta attraverso osservazioni psicologiche eanatomiche e misurazioni; rappresenti il cervello comeorgano, consciamente e inconsciamente,autonomamente attivo, plastico, proiettivo e narrativoche si è evoluto in una simbiosi socio-culturalebiologica;infine consideri l’emozione come garanziadella coscienza. Le emozioni risvegliarono la materia ela resero capace di produrre una mente dinamica,flessibile e aperta. La persona neuronale, così comedelineata dal materialismo informato, è veramentesveglia, nel senso più profondo della parola. La rilevanzadella neuroscienza nello spiegare l’evoluzione delpensiero morale presuppone un modello della mente edel cervello che tenga conto della variabilità, delleemozioni e del pensiero creativo. Secondo ilmaterialismo informato, il cervello è un sistemaselezionale variabile in cui i valori sono incorporaticome costrizioni necessarie. Dal punto di vista biologico,non c’è creatura con un cervello che nasca senza valori;essa è neuro-biologicamente predisposta a svilupparequesti svariati e complessi sistemi valoriali che larendono capace di funzionare nei suoi ambienti fisici enaturali. In questo modello, la propensione naturale ademettere giudizi morali e la capacità di fare scelte moralilibere e responsabili non solo è logica e sensata, ma èbiologicamente inevitabile in individui sani, adulti.Quanto la neuroscienza sia rilevante per l’etica sia da unpunto di vista teoretico che metodologico staemergendo con decisione e rapidità. Secondo la teoriadell’epigenesi neuronale, le strutture socio-culturali eneuronali si sviluppano in simbiosi ed hanno rilevanzacausale reciproca. Infatti, l’architettura dei nostri cervellidetermina il nostro comportamento sociale, incluse lenostre disposizioni morali, che influenzano il tipo disocietà che costruiamo, e, viceversa, le strutture socioculturaliinfluenzano lo sviluppo dei nostri cervelli. Ciòè compatibile con la posizione per cui le norme nonpossono essere logicamente derivate dai fatti se non acosto di cadere nella cosiddetta “fallacia naturalistica”.La principale sfida della neuro-etica fondamentale èdecifrare questa rete di connessioni causali traprospettive neurobiologiche e socio-culturali edeterminare i valori “universali” pre-specificati nelnostro genoma, e condivisi dalla specie umana,distinguendoli da quelli che sono dati da una certacultura o sistema simbolico. La “fallacia” dell’approccionaturalistico si trasforma così in responsabilità.