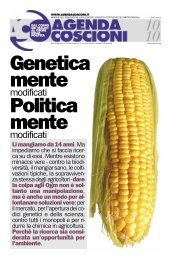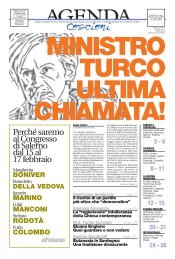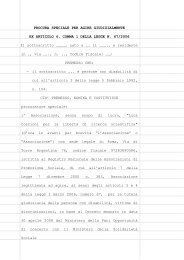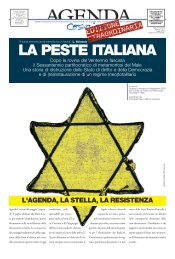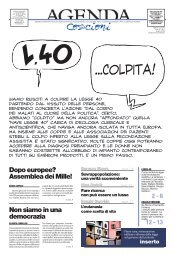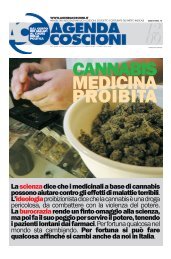Per - Associazione Luca Coscioni
Per - Associazione Luca Coscioni
Per - Associazione Luca Coscioni
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
on line www.agendacoscioni.it - www.lucacoscioni.it7L’INTERVENTOGilbertoCorbelliniScienza e filosofia LA PAROLA AL BIOETICISTAL’illusione del libero arbitrioche già spiegò SpinozaLe nuove sfide neuroscientifiche e neuroetiche sul pianoumano, morale, politico e religioso portano l’Italiasempre indietro rispetto al quadro internazionaleGilberto CorbelliniLa bioetica non è un campo distudi autonomo. Non ha unoggetto definito di indagine.Segue le mode. Meglio, insegue glisviluppi delle scienze biomediche esanitarie, vivendo in buonasostanza di luce riflessa. Da qualcheanno la moda è diventata laneuroetica.Negli anni Settanta era stata lasperimentazione clinica su soggettiumani, ovvero i la tematicacollegate al consenso informato.Negli anni Ottanta i temidominanti erano stati quelli relatividella giustizia sociale nell’accessoalle cure sanitarie, datal’acquisizione durante i duedecenni precedenti che sul pianoeconomico la spesa sanitaria apparefuori controllo. Gli anni Novantaregistravano l’esplosione da un latodelle aspettative sociali e dall’altrodel panico etico per le ricadutemediche dell’ingegneria genetica edell’ingegneria cellulare (leggiclonazione).Nel quadro internazionale deglistudi bioetica l’Italia non ha maispiccato per originalità. E dallepremesse ci si può aspettare che,salvo qualche eccezione e se nonsuccede qualcosa di imprevedibile,anche i contributi nostrani allaneurotica saranno in larga partelavori “di rimessa” o speculazionifatte a tavolino. In altre parole, unpallido riverbero di quello cheaccade nei paesi dove la neuroeticaviene coltivata da circa undecennio. Lo scopo di chi se neoccupa in Italia, per il momento,sembra quello di capire in chemodo si possono adattare le teorieetiche, e le filosofie che le ispirano,tradizionalmente utilizzate peraffrontare i problemi specifici cheemergono nell’area neuroscientificae neurotecnologica. Ovvero comerispondere, ma soprattuttodisinnescare le sfide che leneuroscienze stanno lanciando, enon da pochi anni, alle categorie ealle assunzioni filosofico-politichetradizionalmente utilizzatenell’ambito delle scienze umane.Inclusa la filosofia morale. Insostanza, non sembra che ibioeticisti che si apprestano aoccuparsi di neuroetica sianoparticolarmente interessati econfrontarsi con le più rilevanti econvergenti spiegazioni che le teorieneuroscientifiche, sulla base di unaattenta e il più possibile obiettivalettura dei dati empirici, stannofornendo dei comportamentiumano. Inclusi i comportamentimorali, religiosi e politici.Alla luce delle conoscenze che sonoscaturite dagli studi neuroscientifici,e dalla loro contestualizzazioneevoluzionistica, appare quasipatetica una certa ostinazione, daparte di intellettuali, politici e ingenerale cultori del sapereumanistico, nel difendereconcezioni della coscienza umana odella libertà che sono stateirrimediabilmente confutate. Ma, aldi là della capacità dei difensoridell’irriducibilità della mente umanaal cervello di avvertire un senso delridicolo, che dipende sempreun’ottica soggettiva e quindi daglistrumenti cognitivi, emotivi e culturaliindividuali, l’ostinazione a difendereconcezioni irrealistiche delle funzionimentali umane può determinare gravidanni alle persone.Prendiamo gli studi sulla coscienza.Con buona pace di chi crede che sitratti di una qualità immateriale e distraordinaria importanza, in realtàquella che chiamiamo esperienzacosciente altro probabilmente non èche una funzione del cervello, nonchéun fenomeno marginale nell’economiadei processi di controllo generale delcomportamento, benché essenziale pergovernare adattativamente ledimensioni sociali dell’esperienzaumana. Le teorie della coscienza chetengono conto dei dati neuroscientificihanno inoltre abbandonato l’idea chesi tratti di uno stato definibileindipendentemente da specifici aspettidell’organizzazione neuroanatomicadel cervello. E tenendo conto di quelleche molto plausibilmente sono le basineurofisiologiche della coscienza,nonché in virtù delle qualità attraversocui ne abbiamo esperienza si può direche eventuali danni neurologicipossono determinare disturbi dellacoscienza accompagnati dainsopportabili disagi. Ne deriva chel’orientamento che sta prevalendo inItalia sulle direttive anticipate e lanegazione del diritto di disporre dellapropria vita, è garanzia non di tuteledelle persone ma solo di unaggravamento del carico di dolore per icittadini di questo paese; che sarannomantenuti, indipendentemente da ocontro la loro volontà, in stati in cui lacoscienza si è disintegrata e che sonoChi èGilbertoCorbelliniProfessoreordinario distoria dellamedicina edocente dibioeticapressol'Universitàdi RomaLa Sapienza.È copresidentedell'<strong>Associazione</strong><strong>Luca</strong><strong>Coscioni</strong>associati a gravissime sofferenzepsicologiche.Un’altra discussione incorso nell’ambito della neurotica, chepotrebbe determinare conseguenzenon per tutti desiderabili, è quella cheriguarda il problema del liberoarbitrio. Non va dimenticato che labestia nera delle religioni èl’assunzione che noi siamo liberi discegliere. Un’assunzione che èaddirittura considerata un dirittofondamentale in tutte leliberaldemocrazie. Le bioetichereligiose non hanno mai accettato leconseguenze bioetiche del principioliberaldemocratico, cioè che le personedi cui non sia stata accertatal’incapacità, devono essere trattatecome agenti autonomi. <strong>Per</strong> cuiconverrà vigilare su come sarannoformulate le implicazione etiche dellericerche neuroscientifiche nell’ambitodegli orientamenti religiosi. Acominciare da quello cattolico. Che perovvi motivi ci interessa molto davicino. Che il libero arbitrio siaun’illusione lo aveva già spiegato inmodo insuperabile Spinoza. Ilproblema non è quindi più se il liberoarbitrio esiste. Ma a quali vantaggi dàluogo l’illusione di essere liberi. Si puòragionevolmente immaginare chequesta illusione risulti in effetti moltovantaggiosa, come dimostra il fattostoricamente documentato chel’assunzione dell’autonomia edell’autodeterminazione individualehanno consentito lo sviluppo e ilfunzionamento delle forme diorganizzazione politico-socialedemocratiche. Cioè quelle nell’ambitodelle quali è stato prodotto il piùelevato benessere umano conosciuto.Se questa ipotesi fosse valida, sarebbedel tutto sensato chiedersi che cosa sipuò fare per promuovere il piùdiffusamente e ai livelli migliori lacostruzione individuale dell’illusionedella libertà. E una volta scoperto checosa aiuta lo sviluppo del senso diautonomia personale investire pergarantire che la più larga parte dicoloro che vengono al mondo possaaccedere a queste esperienze formative.Questo potrebbe essere un terreno unpo’ meno vago e scontato per avviareuna discussione che coinvolga inmodo interdisciplinare competenzediverse, e da cui soprattutto cercare conun po’ di concretezza di ricavareindicazioni anche per scelte eprogrammi politici utili sia per gliindividui che per l’insieme dellasocietà.