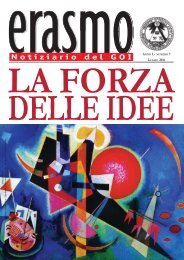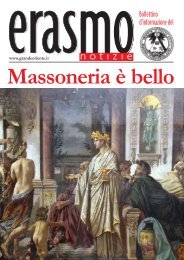Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’Ars Memoriae. Un’antica pratica massonica 37<br />
Tommaso Campanella. Incisione di Balthasar Moncornet,<br />
1658, Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia<br />
dunque un ordine che rispetta la struttura gerarchica imposta<br />
dalla concezione metafisica tradizionale: alla base si trovano le<br />
realtà materiche, sopra le quali si muovono gli enti animati, per<br />
terminare nella comune sottomissione di tutti gli enti alle realtà<br />
intellettuali, dipingendoci un mondo i cui innumerevoli rapporti<br />
seguono la formula neoplatonica omnia sunt in omnibus modo<br />
suo (ogni cosa è presente nelle altre secondo una propria modalità)<br />
9 . Formula esprimente la vita dell’Universo, questa diviene<br />
così la massima che deve informare di sé anche la mente dell’Iniziato,<br />
se quest’ultimo vuole ermeticamente conformarsi al<br />
9<br />
Esplicare diffusamente la concezione gerarchica formulata dal pensiero<br />
metafisico rinascimentale occuperebbe troppo tempo e ci distoglierebbe<br />
dal tema centrale della presente riflessione, tuttavia per<br />
quanti volessero approfondire il tema confrontandosi con uno degli<br />
autori nodali di questa epoca rimando a Giovanni Pico della Mirandola,<br />
Heptaplus – La settemplice interpretazione dei sei giorni della Genesi,<br />
Arktos, Grugliasco (TO) 1996.<br />
Tutto per avere l’opportunità di cogliere la Sofia divina.<br />
Per chiudere il cerchio, adesso che siamo giunti alla fine cercando<br />
di non trascurare le radici operative dell’Ordine, uniche depositarie<br />
della sua identità e autorità tradizionale, sarà proficuo volgersi<br />
a cercare, all’interno della pratica muratoria rinascimentale,<br />
qualche utile indicazione che possa porre in continuità ciò che<br />
finora è stato detto con la prospettiva storica inizialmente esposta<br />
dallo Stevenson. A tale scopo è di notevole interesse ricordare<br />
che nel Rinascimento la figura dell’architetto era divenuta l’immagine<br />
dell’uomo perfetto, non solo perché in ovvio rapporto<br />
analogico con la figura dell’Architetto divino, ma in quanto la sua<br />
formazione richiedeva che egli assommasse in sé, secondo il dettato<br />
vitruviano, la conoscenza di tutte le arti:<br />
Per questo è necessario anche che egli […] abbia una<br />
istruzione letteraria, che sia esperto nel disegno, preparato<br />
in geometria, che conosca un buon numero di racconti<br />
storici, che abbia seguito con attenzione lezioni di<br />
filosofia, che conosca la musica, che abbia qualche nozione<br />
di medicina, che conosca i pareri dei giuristi, che<br />
abbia acquisito le leggi dell’astronomia. 10<br />
Questa implicazione che la formazione di un architetto portava<br />
con sé suggerisce quindi l’idea che l’acquisizione di un sapere<br />
enciclopedico dovesse alla lunga far confluire in un unico bacino<br />
teorico gli interessi sia di coloro che ricercavano una conoscenza<br />
esoterica, sia di quei massoni operativi che fondavano la propria<br />
istruzione e la propria identità di mestiere sulle auctoritates che<br />
questa stessa conoscenza enciclopedica esortavano ad acquisire.<br />
Sarebbe auspicabile in un futuro prossimo riuscire ad approfondire<br />
le motivazioni che agirono in questo periodo integrandosi<br />
con il “ritorno” di Vitruvio, documentando e magari confermando<br />
l’interesse generale dei massoni operativi per quello stesso impianto<br />
mnemotecnico bruniano presente negli statuti scozzesi.<br />
Pur senza queste prove documentali, la sua esclusione dalla riflessione<br />
e dalla tradizione muratoria diviene comunque improbabile<br />
e quasi forzata, una volta considerata la diffusa ed<br />
accettata mentalità ermetica di cui era permeata la civiltà rinascimentale.<br />
Mi sia permesso concludere con un’ultima riflessione riguardante<br />
la difficoltà di proporre oggi la ricerca di un sapere enciclopedico.<br />
La quantità di conoscenze necessarie per la<br />
professione dell’architettura era già percepita dagli antichi come<br />
10<br />
Marco Vitruvio Pollione, De Architectura, 2 voll., Einaudi, Torino 1997,<br />
I, pp. 13-15.