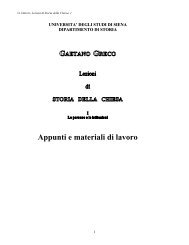Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
G. GRECO, Lezioni <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> della Chiesa. 2<br />
1. La Chiesa cattolica fra Quattrocento e Cinquecento<br />
I mali della Chiesa. Alla fine del Quattrocento la Chiesa cattolica attraversava una<br />
profonda crisi, sia istituzionale ed economica, che ideologica. Dal punto <strong>di</strong> vista istituzionale<br />
si era lacerata la rete territoriale della giuris<strong>di</strong>zione spirituale del clero sui fedeli: le <strong>di</strong>ocesi<br />
(circoscrizioni vescovili), le pievi (raggrupamenti <strong>di</strong> parrocchie rurali, con a capo una chiesa<br />
fornita <strong>di</strong> fonte battesimale), le singole parrocchie sopravvivevano più come nomi <strong>di</strong><br />
ripartizioni territoriali che come uffici veramente funzionanti; la messa veniva celebrata<br />
saltuariamente anche nelle chiese parrocchiali ed i sacramenti - dal battesimo all'estrema<br />
unzione - erano impartiti ai fedeli solo raramente; molti e<strong>di</strong>fici ecclesiastici erano in rovina e<br />
mancavano <strong>di</strong> paramenti; i vescovi, i pievani ed i parroci non adempivano più <strong>di</strong> persona ai<br />
loro doveri <strong>di</strong> governo spirituale e <strong>di</strong> cura d'anime, ma si facevano sostituire da «vicari»<br />
precari, ignoranti e mal pagati, che a loro volta lavoravano il meno possibile. Del resto i<br />
titolari non erano certo migliori dei loro sostituti: esponenti dei ceti più elevati, inseriti in<br />
giovanissima età nell'or<strong>di</strong>ne del clero (con la «tonsura» dei capelli) e talora nient'affatto<br />
intenzionati a <strong>di</strong>ventare sacerdoti, avevano ottenuto per ere<strong>di</strong>tà familiare, con il denaro e con<br />
il potere politico i loro «benefici ecclesiatici» (le doti patrimoniali connesse agli uffici<br />
ricoperti); ma soprattutto occupavano più uffici contemporaneamente.<br />
Il cumulo dei benefici (vescovati, canonicati, pievanati, abbazie, parrocchie), spesso posti<br />
in città e regioni <strong>di</strong>stanti, era all'origine delle maggiori <strong>di</strong>sfunzioni nel servizio sacro: dal<br />
cumulo proveniva la violazione ai precetti <strong>di</strong> residenza e <strong>di</strong> adempimento personale degli<br />
obblighi dell'ufficio, ma da esso si alimentava anche una grande corruzione che investiva il<br />
cuore stesso della Chiesa cattolica. Infatti, per legittimare tante situazioni irregolari <strong>di</strong> solito<br />
questi chierici ricorrevano alla suprema autorità del papa, che li «<strong>di</strong>spensava» dall'osservanza<br />
delle leggi canoniche: queste <strong>di</strong>spense, insieme ad altre, persino in materia sacramentale (per<br />
esempio, in campo matrimoniale), erano concesse dagli uffici della Curia Romana <strong>di</strong>etro il<br />
pagamento <strong>di</strong> apposite tasse, cosicché vi era il fondato sospetto che si trattasse <strong>di</strong> una pratica<br />
simoniaca.<br />
Di tutto questo giro <strong>di</strong> <strong>di</strong>spense e <strong>di</strong> denaro soffrivano in particolare le istituzioni<br />
ecclesiastiche <strong>di</strong>ocesane (perché ogni ufficio aveva un suo patrimonio appetibile) e le case<br />
degli or<strong>di</strong>ni monastici (anche le abbazie ed i monasteri avevano ingenti patrimoni da<br />
sfruttare), anche a causa delle trasformazioni che avvenivano in campo politico. Nel corso del<br />
Quattrocento si erano formati gran<strong>di</strong> stati nazionali o si erano ampliati vecchi stati territoriali,<br />
e gli uni come gli altri avevano avvertito la necessità <strong>di</strong> ricompensare un numero crescente <strong>di</strong><br />
ministri, <strong>di</strong> funzionari, <strong>di</strong> servitori, <strong>di</strong> clienti: gli enti ecclesiastici - in particolare quelli delle<br />
contrade <strong>di</strong> più recente conquista - vennero utilizzati anche per questo scopo. Rispetto a<br />
questa decadenza ben visibile e lamentata dai contemporanei, gli or<strong>di</strong>ni regolari men<strong>di</strong>canti (i<br />
Francescani, i Domenicani, i Serviti, gli Agostiniani, i Carmelitani ed i Minimi <strong>di</strong> Francesco<br />
da Paola) mantenevano un profilo sicuramente più alto: nelle loro chiese era sempre possibile<br />
accostarsi ai sacramenti, partecipare ad una messa, ascoltare una pre<strong>di</strong>ca (spesso si trattava <strong>di</strong><br />
ampi e<strong>di</strong>fici costruiti apposta per accogliere molti fedeli). Certo, anche gli or<strong>di</strong>ni men<strong>di</strong>canti<br />
attraversavano una crisi, ma <strong>di</strong> segno opposto: all'interno delle varie congregazioni lo scontro<br />
avveniva nel nome <strong>di</strong> riforme rigoriste, per riportare le famiglie conventuali all'"osservanza"<br />
delle regole iniziali dei rispettivi or<strong>di</strong>ni. Se gli “osservanti” non vinsero la loro battaglia (la<br />
stessa nascita ufficiale, nel 1517, <strong>di</strong> un ramo separato dell’“Osservanza” nei frati francescani è<br />
il segno <strong>di</strong> questa loro sconfitta), è pur vero che il loro movimento portò nuova linfa agli<br />
or<strong>di</strong>ni men<strong>di</strong>canti e li mantenne più vicini alla sensibilità religiosa popolare.<br />
18