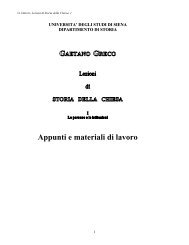Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
G. GRECO, Lezioni <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> della Chiesa. 2<br />
12. Il Concilio <strong>di</strong> Trento e la «Riforma Cattolica»<br />
Il problema del concilio. Fra gli strumenti più adatti per pervenire ad una pacificazione fra<br />
cattolici e luterani, gli elementi più <strong>di</strong>sponibili al <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong> entrambe le parti avevano<br />
in<strong>di</strong>cato sin dagli anni Venti un concilio ecumenico. Benché i luterani non si pronunciassero<br />
mai con chiarezza sulla loro effettiva intenzione <strong>di</strong> sottomettersi al concilio qualunque fossero<br />
state le sue decisioni, non c’è dubbio che la responsabilità principale della mancata<br />
convocazione toccò al papa Clemente VII Me<strong>di</strong>ci (1523-34), che venne meno più volte alle<br />
sue esplicite promesse. Entrato a far parte dei programmi <strong>di</strong> Paolo III (1534-1549) già dal<br />
momento della sua elezione, il concilio fu infine convocato nel 1542 e poté aprirsi solo il 13<br />
<strong>di</strong>cembre 1545, nella città <strong>di</strong> Trento. I suoi lavori durarono - fra alterne vicende ed il tentativo<br />
pontificio <strong>di</strong> trasferirlo a Bologna (1547-49) - ben <strong>di</strong>ciotto anni, fino al <strong>di</strong>cembre del 1563,<br />
non senza lunghe interruzioni e pause dovute sia a motivi <strong>di</strong> carattere sanitario (come le<br />
ricorrenti epidemie) sia a ragioni più schiettamente politiche (lo stato <strong>di</strong> guerra tra Francia e<br />
Spagna negli anni 1552-1559). Gli atti conciliari furono poi ratificati dal papa Pio IV nel<br />
gennaio del 1564 con la bolla Bene<strong>di</strong>ctus Deus, ma non vennero pubblicati prontamente in<br />
tutti gli stati cattolici .<br />
Già la scelta della sede era nata come il frutto <strong>di</strong> un compromesso fra il papa e l’imperatore<br />
Carlo V: Trento era una città italiana (come voleva il pontefice), ma era anche la capitale <strong>di</strong><br />
un principato vescovile membro dell’Impero (e l'imperatore desiderava che l’assise si<br />
svolgesse dentro i confini della sua alta giuris<strong>di</strong>zione, anche a garanzia dei riformatori). Del<br />
resto, chi veramente aveva voluto il Concilio era stato proprio Carlo V, pur essendo sempre<br />
stato avversario delle dottrine <strong>di</strong> Lutero: secondo le aspettative dell’imperatore, una riforma<br />
generale delle istituzioni e degli uomini della Chiesa avrebbe eliminato gran parte delle cause<br />
che erano state all'origine della scissione protestante ed avrebbe costituito la premessa per una<br />
ritrovata unità della cristianità.<br />
Le decisioni del concilio. Nella «lotta per il Concilio» vi era stata anche la speranza che in<br />
questo consesso sarebbe stato possibile raggiungere un'intesa <strong>di</strong> massima fra i cristiani anche<br />
sulle laceranti questione teologiche. Ma sin dall’inizio questo desiderio si rivelò nient'altro<br />
che una pia illusione. I rappresentanti dei protestanti fecero una fugace apparizione soltanto<br />
nel 1551-52 (e solo perché costretti da Carlo V), quando già sin dal 1547, respingendo anche<br />
le proposte <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione avanzate dal car<strong>di</strong>nale Contarini, i padri conciliari avevano riba<strong>di</strong>to<br />
nel decreto sulla giustificazione la dottrina tra<strong>di</strong>zionale cattolica, che vedeva nelle buone<br />
opere - e non solo nella fede - lo strumento in<strong>di</strong>spensabile per la salvezza eterna. Svanì subito<br />
ogni possibilità d'accordo sulle dottrine teologiche, perché in campo sacramentale fu respinta<br />
ogni novità e ci si attenne alla dottrina cattolica sull'esistenza <strong>di</strong> sette sacramenti: il battesimo,<br />
la confermazione o cresima, l’eucarestia, la confessione (che si avviò a <strong>di</strong>ventare un vero e<br />
proprio foro giu<strong>di</strong>ziario: il «tribunale della coscienza»), il matrimonio, l’or<strong>di</strong>ne sacro (cioè il<br />
sacerdozio) e l’estrema unzione (impartito in occasione <strong>di</strong> gravi malattie). Fu inoltre<br />
confermato il valore <strong>di</strong> verità della tra<strong>di</strong>zione orale (purché «custo<strong>di</strong>ta» e riconosciuta dalla<br />
Chiesa), che veniva ad aggiungersi alle Sacre Scritture: per queste l’unica versione ammessa<br />
restava la cosiddetta Vulgata, cioè quella traduzione latina compiuta da san Gerolamo alla<br />
fine del IV secolo e che notoriamente era inficiata da non pochi errori.<br />
Dei propositi iniziali dei fautori del concilio rimaneva solo la speranza <strong>di</strong> intraprendere una<br />
grande riforma della <strong>di</strong>sciplina ecclesiastica, ma anche qui il cammino fu tutt’altro che facile.<br />
Come nei conclavi per l'elezione dei pontefici, anche nel concilio i prelati presenti (assai<br />
42