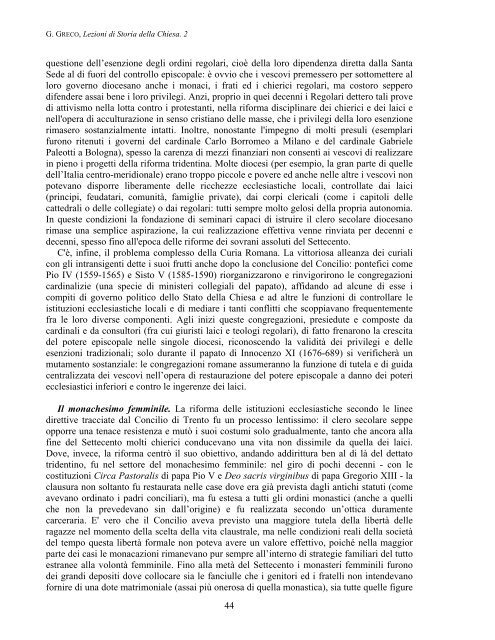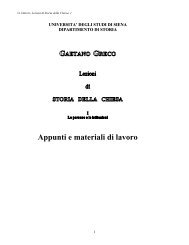Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Gaetano Greco - Dipartimento di Storia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
G. GRECO, Lezioni <strong>di</strong> <strong>Storia</strong> della Chiesa. 2<br />
questione dell’esenzione degli or<strong>di</strong>ni regolari, cioè della loro <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong>retta dalla Santa<br />
Sede al <strong>di</strong> fuori del controllo episcopale: è ovvio che i vescovi premessero per sottomettere al<br />
loro governo <strong>di</strong>ocesano anche i monaci, i frati ed i chierici regolari, ma costoro seppero<br />
<strong>di</strong>fendere assai bene i loro privilegi. Anzi, proprio in quei decenni i Regolari dettero tali prove<br />
<strong>di</strong> attivismo nella lotta contro i protestanti, nella riforma <strong>di</strong>sciplinare dei chierici e dei laici e<br />
nell'opera <strong>di</strong> acculturazione in senso cristiano delle masse, che i privilegi della loro esenzione<br />
rimasero sostanzialmente intatti. Inoltre, nonostante l'impegno <strong>di</strong> molti presuli (esemplari<br />
furono ritenuti i governi del car<strong>di</strong>nale Carlo Borromeo a Milano e del car<strong>di</strong>nale Gabriele<br />
Paleotti a Bologna), spesso la carenza <strong>di</strong> mezzi finanziari non consentì ai vescovi <strong>di</strong> realizzare<br />
in pieno i progetti della riforma tridentina. Molte <strong>di</strong>ocesi (per esempio, la gran parte <strong>di</strong> quelle<br />
dell’Italia centro-meri<strong>di</strong>onale) erano troppo piccole e povere ed anche nelle altre i vescovi non<br />
potevano <strong>di</strong>sporre liberamente delle ricchezze ecclesiastiche locali, controllate dai laici<br />
(principi, feudatari, comunità, famiglie private), dai corpi clericali (come i capitoli delle<br />
cattedrali o delle collegiate) o dai regolari: tutti sempre molto gelosi della propria autonomia.<br />
In queste con<strong>di</strong>zioni la fondazione <strong>di</strong> seminari capaci <strong>di</strong> istruire il clero secolare <strong>di</strong>ocesano<br />
rimase una semplice aspirazione, la cui realizzazione effettiva venne rinviata per decenni e<br />
decenni, spesso fino all'epoca delle riforme dei sovrani assoluti del Settecento.<br />
C'è, infine, il problema complesso della Curia Romana. La vittoriosa alleanza dei curiali<br />
con gli intransigenti dette i suoi frutti anche dopo la conclusione del Concilio: pontefici come<br />
Pio IV (1559-1565) e Sisto V (1585-1590) riorganizzarono e rinvigorirono le congregazioni<br />
car<strong>di</strong>nalizie (una specie <strong>di</strong> ministeri collegiali del papato), affidando ad alcune <strong>di</strong> esse i<br />
compiti <strong>di</strong> governo politico dello Stato della Chiesa e ad altre le funzioni <strong>di</strong> controllare le<br />
istituzioni ecclesiastiche locali e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>are i tanti conflitti che scoppiavano frequentemente<br />
fra le loro <strong>di</strong>verse componenti. Agli inizi queste congregazioni, presiedute e composte da<br />
car<strong>di</strong>nali e da consultori (fra cui giuristi laici e teologi regolari), <strong>di</strong> fatto frenarono la crescita<br />
del potere episcopale nelle singole <strong>di</strong>ocesi, riconoscendo la vali<strong>di</strong>tà dei privilegi e delle<br />
esenzioni tra<strong>di</strong>zionali; solo durante il papato <strong>di</strong> Innocenzo XI (1676-689) si verificherà un<br />
mutamento sostanziale: le congregazioni romane assumeranno la funzione <strong>di</strong> tutela e <strong>di</strong> guida<br />
centralizzata dei vescovi nell’opera <strong>di</strong> restaurazione del potere episcopale a danno dei poteri<br />
ecclesiastici inferiori e contro le ingerenze dei laici.<br />
Il monachesimo femminile. La riforma delle istituzioni ecclesiastiche secondo le linee<br />
<strong>di</strong>rettive tracciate dal Concilio <strong>di</strong> Trento fu un processo lentissimo: il clero secolare seppe<br />
opporre una tenace resistenza e mutò i suoi costumi solo gradualmente, tanto che ancora alla<br />
fine del Settecento molti chierici conducevano una vita non <strong>di</strong>ssimile da quella dei laici.<br />
Dove, invece, la riforma centrò il suo obiettivo, andando ad<strong>di</strong>rittura ben al <strong>di</strong> là del dettato<br />
tridentino, fu nel settore del monachesimo femminile: nel giro <strong>di</strong> pochi decenni - con le<br />
costituzioni Circa Pastoralis <strong>di</strong> papa Pio V e Deo sacris virginibus <strong>di</strong> papa Gregorio XIII - la<br />
clausura non soltanto fu restaurata nelle case dove era già prevista dagli antichi statuti (come<br />
avevano or<strong>di</strong>nato i padri conciliari), ma fu estesa a tutti gli or<strong>di</strong>ni monastici (anche a quelli<br />
che non la prevedevano sin dall’origine) e fu realizzata secondo un’ottica duramente<br />
carceraria. E' vero che il Concilio aveva previsto una maggiore tutela della libertà delle<br />
ragazze nel momento della scelta della vita claustrale, ma nelle con<strong>di</strong>zioni reali della società<br />
del tempo questa libertà formale non poteva avere un valore effettivo, poiché nella maggior<br />
parte dei casi le monacazioni rimanevano pur sempre all’interno <strong>di</strong> strategie familiari del tutto<br />
estranee alla volontà femminile. Fino alla metà del Settecento i monasteri femminili furono<br />
dei gran<strong>di</strong> depositi dove collocare sia le fanciulle che i genitori ed i fratelli non intendevano<br />
fornire <strong>di</strong> una dote matrimoniale (assai più onerosa <strong>di</strong> quella monastica), sia tutte quelle figure<br />
44