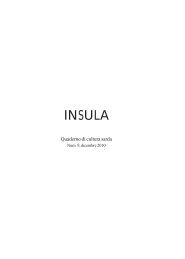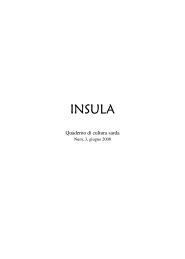Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PER UNA FONETICA STORICA DELLE VARIETÀ SARDO-CORSE<br />
sulle varietà alloglotte ed eteroglotte. In questa sede l’esame in prospettiva<br />
diacronica di alcuni importanti fenomeni del vocalismo e del consonantismo consente<br />
finalmente di incanalare la discussione su parametri e dati oggettivi.<br />
L’altra questione è relativa al periodo in cui il sassarese e il gallurese si<br />
sarebbero formati. Anche qui, il Bottiglioni e il Wagner furono sostenitori di<br />
due tesi contrapposte. Mentre il primo si schierava a favore dell’antichità di<br />
queste varietà, il secondo si faceva assertore di un radicamento che sarebbe<br />
avvenuto a partire dalla fine del Cinquecento e che si sarebbe affermato soltanto<br />
nel Settecento. Quest’ultima posizione può dirsi superata da una serie di dati storici<br />
e linguistici pubblicati in quest’ultimo decennio. Al lato opposto si colloca il<br />
Petkanov che nel gallurese vedeva una fase più antica dell’oltremontano, precedente<br />
al periodo pre-toscano. Ora le posizioni di M. Alinei relative alle origini del<br />
corso paiono alimentare la tesi, cara ad alcuni cultori militanti, che vede il gallurese<br />
procedere addirittura dall’idioma parlato dagli antichi Corsi, già stanziati nella<br />
parte più settentrionale della Sardegna prima della conquista romana.<br />
Si deve ammettere che sul piano storico il gallurese è testimone, per più aspetti,<br />
della fase più remota del sistema corso, ma anche che i suoi rapporti diretti col<br />
toscano durante il basso Medioevo sono evidenti. Vi sono, viceversa, dei problemi<br />
che non consentono, soprattutto per l’assenza di fonti scritte, di accostarsi con sufficiente<br />
sicurezza al lungo periodo che separa l’età tardo-antica dai secoli XI-XII.<br />
Se intorno alla nascita del sassarese su un preesistente fondo sardo logudorese<br />
non sussistono particolari dubbi, 12 una continuità tra gli antichi Corsi attestati<br />
nell’odierna Gallura e la popolazione del regno o giudicato di Gallura non può<br />
essere negata a priori. Il problema, semmai, riguarda la lingua che la popolazione<br />
protocorsa di Sardegna, ormai romanizzata, parlava nell’alto Medioevo. Se,<br />
cioè, la loro lingua potesse essere la stessa in uso nelle restanti aree sardofone<br />
dell’isola e, in particolare, il logudorese, oppure se, a partire da un’idioma originario<br />
diverso da quello delle popolazioni circostanti (Balari, Iliesi), possa<br />
esservi una continuità storica con la varietà che oggi conosciamo col nome di<br />
gallurese. A questo riguardo le attestazioni del sostrato e la documentazione<br />
medioevale presentano un quadro abbastanza uniforme nel quale i toponimi e le<br />
12 Molti toponimi dei territori di Sassari, Porto Torres, Stintino, dell’Asinara, di Castelsardo e<br />
Sedini conservano ancora oggi una veste logudorese; per esempio: (Sassari) Abba Currente,<br />
Abba Méiga, Abeàlzu, S’Abbàdiga, Sa Pedra Bianca, Tottubella; (Porto Torres) Babbànghelu,<br />
Badde Fenuju, Biùnis; (Sorso) Badde Pira, Muros de Maria, Pedras de Fogu, Silis, Tres Montes;<br />
(Castelsardo) Monte Òschiri, Piana Muddéggiu, Salàggiu (ant. Salàjos); (Sedini) Badu de<br />
Sùes, Giannas, Li Algas, Saraghinu, Su Furraghe.<br />
39