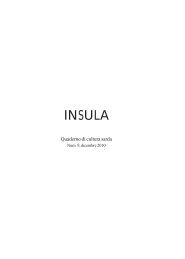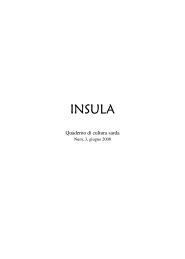Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PER UNA FONETICA STORICA DELLE VARIETÀ SARDO-CORSE<br />
avuto dei riflessi anche sugli studi relativi alle parlate della Sardegna settentrionale.<br />
Questo atteggiamento, in parte, ha coinvolto lo stesso logudorese. Specialmente<br />
sul piano etimologico, si è preferito attribuire l’origine di certi forestierismi al<br />
catalano o allo spagnolo o anche al piemontese piuttosto che al ligure. Un esempio<br />
di questa predisposizione si osserva nel verbo chittì(ssi) ‘ripagare, rivaler(si)’<br />
e nell’aggettivo chìttu ‘pareggiato, saldato (sul piano economico)’, che è comune<br />
al logudorese e alle parlate sardo-corse. Le voci in questione rappresentano dei<br />
francesismi (fr. quitte ‘libero da debiti, obblighi, tasse, ecc’) passati in catalano e<br />
spagnolo ma anche nel genovese. Non a caso quest’ultimo ha un’espressione come<br />
semmo chitti ‘siamo pari’ 58 sulla quale si è operato il calco sass. cast. sed. sèmmu<br />
chìtti, gall. sèmu chìtti e log. sémus chìttos ‘siamo pari, abbiamo pareggiato i<br />
conti’. Ebbene, Wagner riteneva che il log. chìttu derivasse dallo sp. quite e che il<br />
verbo chittìre venisse dal cat. quedar quiti ‘essere in pace’ 59 senza chiedersi,<br />
trattandosi di forme attestate nella Sardegna settentrionale, se potessero essere<br />
penetrate per il tramite del genovese. Accanto alla pretesa toscanità del sassarese,<br />
dunque, si deve considerare il fatto che su non pochi ligurismi fonetici, morfologici,<br />
sintattici e lessicali del gallurese resta ancora molto da studiare.<br />
Per cercare di superare gli ostacoli che in qualche misura sembrano ancora<br />
impastoiare il dibattito sulle eteroglossie della Sardegna settentrionale 60 si è<br />
cercato di reperire il maggior numero di testimonianze documentarie su queste<br />
varietà, fossero esse di carattere onomastico, letterario, epigrafico oppure soltanto<br />
rappresentate da interferenze nel corpo di testi scritti in altre lingue come<br />
il latino, l’italiano e il sardo.<br />
È innegabile, come si accennava, che le eteroglossie sardo-corse non dispongano<br />
di un corpus documentario significativo. Tuttavia le pur frammentarie testimonianze<br />
non sono affatto da trascurare e costituiscono una base per impiantare<br />
un confronto con le fonti scritte, medioevali e moderne, di cui si dispone per il<br />
corso, il toscano, il ligure e il sardo, cioè i principali referenti linguistici con i<br />
quali le parlate sardo-corse si sono confrontate nel corso della loro storia. Ciò<br />
comporta che la lettura di determinati fenomeni debba avvenire necessariamente<br />
in filigrana. Concetto, questo, che è stato assunto come elemento fondante per<br />
qualsivoglia approccio alle varietà linguistiche corse: «La langue corse est présente<br />
58 A. GISMONDI, Nuovo vocabolario genovese-italiano, Torino, Edizioni Fides, 1955, p. 101.<br />
59 DES, I, p. 351.<br />
60 Su questo aspetto cfr. V. ORIOLES, Per una ridefinizione dell’alterità linguisttica. Lo statuto<br />
delle eteroglossie interne, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», anno 25 (2005),<br />
3, Nuova Serie, pp. 407-423.<br />
53