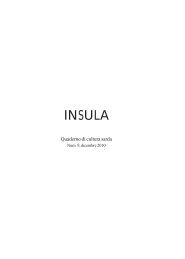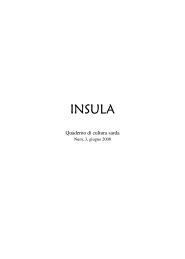Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PER UNA FONETICA STORICA DELLE VARIETÀ SARDO-CORSE<br />
A favore dell’ipotesi che il gallurese odierno sia giunto in Sardegna dalla<br />
Corsica meridionale in epoca medioevale milita anche il fatto che esso presenta<br />
moltissimi sardismi a lato dei quali, in alcuni casi, si conservano le corrispondenti<br />
forme patrimoniali corse. La struttura di alcuni di questi sardismi<br />
dimostra che essi furono acquisiti dalle varietà corse prima del Cinquecento.<br />
Questo aspetto presuppone una fase in cui l’oltremontano, una volta trapiantato<br />
in Gallura, dovette conoscere un lungo periodo di acclimatamento a fianco<br />
del logudorese.<br />
I dati che emergono dalla ricerca permettono di affermare che la base del<br />
gallurese ha i più convincenti confronti, piuttosto che col dialetto di Sartene, 54<br />
col rucchisgianu, cioè con la parlata dell’Alta Rocca, che rappresenta la varietà<br />
più conservativa dei dialetti corsi. Soltanto il rucchisgianu condivide col gallurese<br />
tutta una serie di fenomeni caratterizzanti come la conservazione di I <br />
e U * origi-<br />
narie; il mantenimento di K, P, T intervocaliche; l’uscita unica del pronome personale<br />
i∂∂i ‘essi, esse’; lo sviluppo cacuminale sia per LL che per LJ (fi∂∂ólu<br />
‘figliolo’, pi∂∂à ‘pigliare’, vó∂∂u ‘voglio’); le uscite dell’imperfetto indicativo<br />
in -à(v)ami, -à(v)ati, -à(v)ani e altre importanti particolarità. Sono questi dati a<br />
lasciare ritenere che i primi colonizzatori corsofoni siano giunti in Gallura –<br />
forse già prima della conquista genovese della Corsica e della fondazione della<br />
colonia di Bonifacio – dalla regione montana e pastorale del Tallano e da comunità<br />
come quelle di Carghjaca, Loretu, Mela, Zoza, Auddè, Quenza, Scupamena,<br />
Surbuddà, Càrbini, Livìa e Zonza. Comunità corse che per secoli, quasi fino ad<br />
oggi, hanno condiviso con le comunità corsofone della Gallura l’antica tradizione<br />
della transumanza dai villaggi montani alle pianure costiere e viceversa.<br />
6. «Nessuna regione italiana ha avuto una storia linguistica unitaria» e «nessuna<br />
storia regionale può fare a meno delle esperienze linguistiche del suo territorio». 55<br />
Queste considerazioni, che nulla tolgono all’originalità della situazione sarda,<br />
valgono tuttavia anche per la Sardegna proprio e soprattutto a causa della presenza<br />
nella sua parte settentrionale delle parlate giunte dalla Corsica.<br />
Alle varietà sardo-corse, in generale, è stata dedicata un’attenzione minore<br />
rispetto a quella riservata al sardo che, per via delle sue strutture e del suo<br />
54 È questa la tesi cara al Wagner; cfr. M.L. WAGNER, La lingua sarda. Storia spirito e forma, a<br />
cura di Giulio Paulis, Nuoro, 1997, p. 345.<br />
55 B. DEVOTO – G. GIACOMELLI, I dialetti delle regioni d’Italia, Firenze, Bompiani, 1972, Introdu-<br />
zione, VI.<br />
49