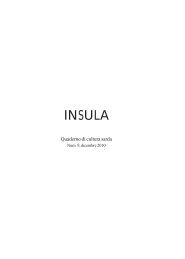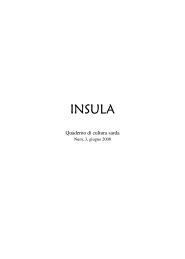Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Impaginato 5.p65 - Universitat Rovira i Virgili
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
Mauro Maxia<br />
Sia il gallurese che l’oltremontano, ma anche il sassarese, presentano non<br />
pochi fenomeni, spesso relativi ai nessi consonantici, che sono condivisi con<br />
l’italiano mediano, meridionale e dell’estremo sud. In ciò va vista una testimonianza<br />
di maggiore coesione, in antico, di queste varietà rispetto a quanto si<br />
rilevi in sincronia. Ma il gallurese, specie nella morfologia, presenta tratti più<br />
arcaici e non di rado autonomi rispetto allo stesso oltremontano che, pure, è<br />
considerato unanimemente la varietà più conservativa del corso. Ancora, il<br />
gallurese conserva sia pur rari sviluppi di basi latine non attestati in altre aree<br />
romanze. Forse grazie alla sua posizione appartata, il gallurese, in modo non<br />
dissimile dal sardo, parrebbe rappresentare un antico testimone di una maggiore<br />
coesione linguistica che in passato poteva accomunare l’Italia mediana con la<br />
Corsica e la Sardegna settentrionale. Se si potesse astrarre dal forte influsso e,<br />
per vari aspetti, dalla compenetrazione avuta col sardo fin dal Medioevo, si<br />
potrebbe sostenere che il gallurese rappresenti la varietà più conservativa del<br />
corso. D’altra parte, non si possono dimenticare i frequenti e contestuali contatti<br />
che le popolazioni corse ebbero durante il Quattrocento sia con la Tuscia e<br />
l’Umbria sia con l’intero territorio della Sardegna.<br />
7. Lo studio delle varietà sardo-corse ha sempre incontrato ostacoli di varia<br />
natura. L’interesse dei maggiori studiosi, come si accennava, è stato calamitato<br />
dall’importanza che il sardo riveste per la ricostruzione del passaggio del latino<br />
al romanzo. Al sassarese e al gallurese, e ancora di più alle altre varietà meno<br />
note, è stata dedicata un’attenzione certamente inferiore, sebbene dal Guarnerio<br />
in poi non siano mancati contributi anche di notevole spessore. Tuttavia, si può<br />
dire che soltanto il Bottiglioni, benché le sue conclusioni non siano sempre<br />
condivisibili, abbia riservato interessi e sforzi commisurati ai problemi che lo<br />
studio di queste varietà riserva a chi intenda accostarvisi.<br />
Si deve riconoscere che tra altri ostacoli non sono mancate difficoltà di carattere<br />
politico, motivate sia dall’appartenenza della Corsica alla Francia sia<br />
dalla sua plurisecolare e orgogliosa opposizione alla dominazione genovese.<br />
Difficoltà che per certi versi hanno alimentato dei pregiudizi che tuttora si<br />
frappongono rispetto a una visione della complessiva questione scevra da<br />
condizionamenti ideologici.<br />
Una delle conseguenze più notevoli di tali difficoltà è rappresentata dalla generale<br />
sottovalutazione dell’importanza che l’elemento ligure ebbe per la storia<br />
sia del corso sia delle varietà sardo-corse, nessuna esclusa. Il pregiudizio<br />
antigenovese, che fortunamente condiziona sempre meno la linguistica corsa, ha