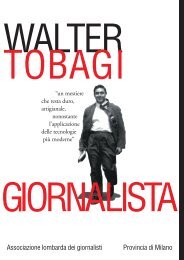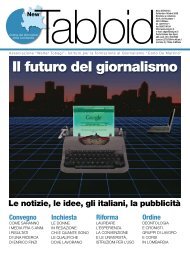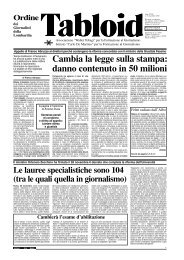Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Trentadue medaglie d’oro il 29 marzo <strong>2007</strong> al Circolo della Stampa<br />
AGLIE<br />
R<br />
Vieri Poggiali<br />
Giornalista a 360 gradi<br />
tra Toscana e Mitteleuropa<br />
Quando il curriculum dell’interlocutore riempie tre pagine fitte<br />
fitte, vuol dire che la chiacchierata si prospetta intensa e interessante.<br />
Vieri Poggiali, classe 1934, vive in una casa elegante<br />
nel centro di Milano, e non appena si varca la soglia della<br />
sua abitazione gli occhi cadono sui busti di due personaggi a<br />
lui particolarmente cari: Giuseppe Verdi e Franz Joseph<br />
(Francesco Giuseppe), l’ultimo kaiser dell’impero austro-ungarico.<br />
Sono il ricordo di una grande passione, la musica lirica, e<br />
delle origini della madre. Poggiali è nato a Milano, figlio di un<br />
toscano – da qui il nome tipicamente fiorentino – e di una triestina,<br />
quando ancora Trieste era sotto l’impero austro-ungarico<br />
ed emergeva in Europa come crogiuolo di etnie e di lingue. “In<br />
casa – ricorda – si parlava tedesco. Infatti ho frequentato la<br />
scuola tedesca, dove le suore non venivano a dividere due che<br />
si azzuffavano, ma si preoccupavano solo che i contendenti<br />
non si colpissero nelle parti basse, perché quello era un segno<br />
di vigliaccheria”.<br />
Vieri si laurea all’Università Cattolica di Milano in Scienze<br />
Politiche. Il padre, giornalista, gli sconsiglia di intraprendere la<br />
sua stessa carriera e preferirebbe per il figlio un incarico da di-<br />
O<br />
di Alessandro Ruta<br />
plomatico. Ma Vieri non cede: a 22 anni diventa redattore del<br />
quotidiano economico “Il Sole”, e a 27 anni ne è già vice-direttore.<br />
In seguito, però, sceglie di diventare free-lance: “Le proposte<br />
alternative non mancavano. Mi avevano chiamato per fare<br />
il caposervizio agli interni del Corriere della Sera, ma erano<br />
tempi in cui si finiva troppo tardi e avevo problemi in famiglia.<br />
Poi mi volevano corrispondente fisso da Vienna, ma rifiutai anche<br />
quell’incarico: la capitale austriaca mi sembrava troppo<br />
lontana. Fosse stato oggi, chissà”.<br />
Inizia così a collaborare con vari giornali, dal “Sole 24 Ore” a<br />
“Gente”, da “La nazione” alla “Domenica del Corriere”. In più,<br />
dal 1966, comincia una quasi trentennale collaborazione fissa<br />
con la Rai: “Il servizio pubblico è un gran carrozzone, ma è un<br />
ambiente simpatico. Ho lavorato per i telegiornali, le rubriche<br />
economiche e i giornali-radio. Nel 1978 dovevo diventare caporedattore<br />
del Tg1 ma le beghe politiche, già allora d’attualità,<br />
mi tennero nel limbo per un anno e mezzo. Quando la situazione<br />
si sbloccò era troppo tardi: avevo già rinunciato all’incarico.<br />
In Rai comunque non entro più dal 1995”.<br />
Da libero professionista, Poggiali comincia ad accostarsi agli<br />
uffici stampa. Dal 1972 al 1976 e dal 1978 al 1982, Vieri è direttore<br />
responsabile delle Relazioni esterne del gruppo<br />
Montedison. “Sono convinto – ammette – di essere stato corretto<br />
in entrambi gli ambiti. C’era chi mi criticava aspramente,<br />
ad esempio L’Espresso, accusandomi di conflitto d’interesse, in<br />
quanto facevo commenti di borsa e la Montedison era quotata.<br />
Ma ho sempre avuto sufficiente onestà intellettuale per non<br />
farmi influenzare negativamente dalle mie due occupazioni. Se<br />
uno ha la coscienza a posto può conciliare il lavoro giornalistico<br />
e di ufficio stampa. Certo, quando Montedison ha comprato<br />
Il Messaggero e ha dato soldi a Rizzoli per il Corriere della<br />
Sera, allora lì ho fatto un passo indietro e me ne sono andato<br />
dal Gruppo. D’altronde, era un periodo in cui ero anche sindacalista”.<br />
Poggiali, infatti, è attivo quasi da sempre nel sindacato.<br />
Dal 1961 al 1991 è stato delegato per la Lombardia a tutti i<br />
congressi nazionali della Fnsi. Dal 1964 al 1997 è stato componente<br />
del consiglio direttivo dell’Alg, del Consiglio dell’ordine<br />
<strong>dei</strong> giornalisti di Milano, del Consiglio nazionale dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong><br />
giornalisti e del Consiglio nazionale della Fnsi. È stato inoltre<br />
presidente dell’Inpgi.<br />
Giornalista, soprattutto, ma anche scrittore di libri di successo<br />
come Antonio Ghiringhelli, una vita per la Scala, dedicato allo<br />
storico sovrintendente del teatro milanese, e Montedisoneide:<br />
quest’ultimo poema eroicomico in endecasillabi rimati in 33<br />
canti, composto sotto pseudonimo. A questi vanno aggiunti i<br />
saggi didattici, soprattutto sul linguaggio del giornalismo economico,<br />
che definisce “spesso troppo criptico e incomprensibile,<br />
mentre invece dovrebbe essere un misto di informazione e<br />
formazione”. Poggiali, infatti, ha insegnato dal 1993 al 2005<br />
Dottrina e tecnica dell’informazione economica alla Cattolica di<br />
Milano. Ora le sue occupazioni predilette sono le collaborazioni<br />
su un sito economico-finanziario e la musica lirica: “Sono abbonato<br />
alla Scala, alla Fenice di Venezia e all’Opera di Roma.<br />
Ho fatto abbonare persino la mia nipotina di 13 anni, così già<br />
abitua l’orecchio alle meravigliose note di Verdi e di Richard<br />
Strauss”.<br />
Gian Carlo Ferretti<br />
A lezione da Pasolini<br />
per capire dove va il domani<br />
di Massimo Lanari<br />
Pontedera, quartiere operaio, inizio anni Cinquanta. “Scendi<br />
Gian Carlo, cercano un redattore al Calendario del Popolo!”.<br />
Sorride Gian Carlo Ferretti nel ricordare l’episodio che gli cambiò<br />
la vita. Un sorriso nostalgico perché rivede il personaggio<br />
che pronunciò quella frase. “Si chiamava Firenze Rovini”, racconta,<br />
“era un sarto, aveva uno di quei nomi un po’ strani tipici<br />
della Toscana. Uno di quei personaggi non rari all’epoca, gli autodidatti:<br />
reduci dalla guerra partigiana, ex deportati, studenti<br />
che avevano dovuto abbandonare la scuola, operai desiderosi<br />
di apprendere. Tutta gente che amava la storia, la scienza, la<br />
letteratura, ma che per ragioni di reddito o di lavoro non pote-<br />
va pagarsi gli studi. E che nel tempo libero leggeva libri e giornali<br />
creandosi così una cultura vivace e originale ”.<br />
Ferretti si era appena laureato all’Università di Pisa. Si era accostato<br />
al giornalismo scrivendo sul “Tirreno” e su altri quotidiani<br />
locali. “Fin da piccolo sognavo di fare il giornalista in una<br />
grande città. La mia passione erano le pagine culturali, ma seguivo<br />
anche la vita politica di quel periodo. Mi sentivo vicino alle<br />
posizioni del Pci e avevo molti amici tra gli operai comunisti,<br />
anche se non ero ancora un militante”.<br />
Per uno come Ferretti “Il Calendario del Popolo” era perfetto:<br />
un mensile di cultura popolare, “fiancheggiatore” del Pci e con<br />
sede a Milano. Nelle pagine del periodico, Ferretti risponde alle<br />
domande di quegli autodidatti che aveva conosciuto bene a<br />
Pontedera: “Chi era Alessandro Manzoni Oppure, quali sono<br />
le principali religioni nel mondo”<br />
Nel 1955 il passaggio all’“Unità”, prima agli Interni e poi in terza<br />
pagina. Qui Ferretti si occupa di critica letteraria e intervista<br />
molti autori italiani del tempo, da Pasolini a Sereni, fino a<br />
Calvino”.<br />
Ferretti rimane colpito, in particolare, da Pier Paolo Pasolini:<br />
“Un intellettuale ‘disorganico’ e controcorrente rispetto a tutto,<br />
ai partiti, alle tradizioni letterarie, al potere. Un pessimista che<br />
criticava la società senza pretendere però di cambiarla secondo<br />
modelli utopistici. Era unilaterale, come tutti i grandi che<br />
sanno vedere il futuro: questa era la grande forza di Pasolini, e<br />
io mi definisco un pasolinista”.<br />
Nel 1968 lavora a “Tempo medico”. Nel 1976 approda nel mondo<br />
dell’editoria: dal 1982 al 1984 diventa direttore editoriale degli<br />
Editori Riuniti. Nel frattempo, infatti, Ferretti si dedica allo studio<br />
del mercato editoriale librario fino a quando, nel 1987, ottiene<br />
la cattedra di Letteratura italiana contemporanea<br />
all’Università La Sapienza di Roma.<br />
Durante la sua carriera, Ferretti ha vissuto il giornalismo e la<br />
letteratura con la stessa intensità, ma con ottiche diverse. “Dal<br />
mio maestro Luigi Russo ho imparato che ogni autore è<br />
espressione di un determinato periodo storico. Ma mentre il<br />
grande scrittore sa fare qualcosa di più, sa incidere sulla società,<br />
il giornalista deve solo riportare la notizia e commentarla<br />
con onestà. Il lettore, ieri come oggi, è un soggetto maturo”.<br />
Giuseppe Rossetti<br />
Legato da un filo magico<br />
al mondo della sua Pavia<br />
di Valentina Colosimo<br />
Prima, gli anni di lavoro sette giorni su sette, senza altro pensiero<br />
che il giornale. Infine, l’addio continuamente rimandato<br />
alla sua prima passione, nata ai tempi dell’università e coltivata<br />
con determinazione in un piccolo quotidiano di provincia,<br />
“Il Giornale di Pavia”.<br />
Per Giuseppe Rossetti il legame con il giornalismo non si è<br />
mai allentato, e anche quando è diventato dirigente dell’Aler<br />
(Azienda lombarda per l’Edilizia residenziale) a Pavia, ha trovato<br />
il modo di occuparsi di carta stampata, gestendo la società<br />
editrice di Federcasa. A 73 anni, Rossetti ci riflette su:<br />
“Rimangono sempre <strong>dei</strong> fili rossi”.<br />
A percorrerlo a ritroso, il filo rosso conduce all’Università di<br />
Firenze. È il 1954. Il giovane studente di Scienze politiche<br />
Giuseppe Rossetti dirige il giornale universitario “Nuova generazione”.<br />
Sono solo le prove generali del futuro incarico. Ha<br />
già le idee chiare e una professione che lo attira. Comincia infatti<br />
a frequentare la redazione della “Gazzetta di Mantova”.<br />
L’occasione per diventare praticante nasce per un caso: “Uno<br />
<strong>dei</strong> redattori della Gazzetta di Mantova era andato a fare il militare<br />
e quindi si liberò un posto”. Quel posto Rossetti lo occupa<br />
da praticante lavorando in cronaca “senza un giorno di vacanza,<br />
neppure a Natale”. Nonostante tutto, quell’anno<br />
Rossetti riesce ancora a studiare: “Dormivo sul treno di notte<br />
per andare a Firenze e il pomeriggio seguente ero di nuovo a<br />
Mantova al giornale”.<br />
Quando nel 1956 diventa professionista, viene assunto dal<br />
“Giornale di Pavia”. Dodici mesi da redattore ordinario, poi l’incarico<br />
più prestigioso. Un primato: a 27 anni è il più giovane<br />
direttore di quotidiano d’Italia. “Non ho mai avuto grossi problemi,<br />
anche con i giornalisti più vecchi di me: l’ambiente era<br />
piccolo e ci si conosceva bene”, racconta Rossetti.<br />
Lavora tantissimo, dalle dieci del mattino alle tre di notte, ma<br />
considera l’impegno “una fatica piacevole”, sommando sforzi<br />
e passione per il mestiere.<br />
Di quell’esperienza, Rossetti ricorda soprattutto la vitalità del<br />
microcosmo provinciale, dove i contatti sono più diretti e i personaggi<br />
più coloriti; dove non manca neppure l’assessore che<br />
si offende e denuncia il giovane direttore per diffamazione per<br />
un’interiezione mal interpretata: un “per Bacco” scritto così,<br />
con la B maiuscola, a indicare il dio del vino e, secondo l’assessore<br />
vilipeso, una sottile insinuazione al suo vizio di bere.<br />
Nel 1971 la società editrice Athena viene dichiarata fallita dal<br />
Tribunale di Milano e “Il Giornale di Pavia” cessa le pubblicazioni.<br />
Giuseppe Rossetti si trasferisce a Milano, dove comincia a dirigere<br />
l’ufficio stampa della Federazione regionale delle industrie<br />
lombarde, e registra la testata “Lombardia Notizie”. Poi,<br />
gli incarichi dirigenziali: direttore dell’Unione industrie della<br />
provincia di Pavia, infine presidente dell’Aler della sua città.<br />
Ma il filo rosso continua a tenerlo legato al giornalismo, tanto<br />
che da alto dirigente riesce ancora a occuparsi di carta stampata,<br />
gestendo le riviste di settore di Federcasa.<br />
Carla Stampa<br />
Da “Epoca” a Montecitorio<br />
una vita tra inchieste e politica<br />
“Politica, in una sintesi elementare, è l’agire comune per il bene<br />
comune, non l’agire in proprio per il bene di pochi”. Così<br />
Carla Stampa, all’anagrafe Stampacchia, definiva la gestione<br />
della cosa pubblica in un articolo del febbraio 2002. Parole forti<br />
nella loro semplicità, espresse da chi per una vita intera ha<br />
avuto a che fare, da giornalista e da personaggio istituzionale,<br />
con le problematiche legate alla deontologia professionale e alla<br />
politica.<br />
ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />
di Matthias Pfaender<br />
Carla Stampa nasce a Roma nel 1930 e si trasferisce a Milano<br />
nel 1965. Qui, come ha raccontato nello stesso articolo, ha avvio<br />
la sua carriera, svolta ininterrottamente nell’ambito del maggiore<br />
gruppo editoriale italiano: “Ho trascorso una trentina d’anni<br />
in Mondadori, anni conclusi con una singolare coincidenza:<br />
quando Berlusconi si appropriava della prima casa editrice nazionale,<br />
dopo una feroce battaglia proprietaria con Carlo De<br />
Benedetti (Lodo Mondadori), io me ne uscivo per andare in<br />
parlamento come deputata del Pds nel proporzionale della<br />
Lombardia. Era il 1994”.<br />
Per la Mondadori lavora come inviata per il settimanale<br />
“Epoca”, realizzando inchieste sociali e di costume. Scrive anche<br />
un libro sul caso di Sacco e Vanzetti (Mondatori, 1974).<br />
Durante gli anni da inviata muove i primi passi nel mondo della<br />
politica, e ricopre prima il ruolo di rappresentante del<br />
Comitato di redazione a “Epoca”, poi di consigliere nazionale<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>.<br />
Una volta passata alla politica, mette la sua esperienza di giornalista<br />
a disposizione della VII Commissione della Camera<br />
(Cultura, Scienza, Informazione) e della Commissione speciale<br />
Napolitano per il riordino del sistema radiotelevisivo e per<br />
l’Editoria.<br />
Pur trasferitasi a Roma per frequentare le sedute della<br />
Camera, la Stampa mantiene stretti contatti con il suo collegio<br />
elettorale e con il territorio lombardo, seguendo in particolare,<br />
direttamente con interpellanze, i problemi della piccola editoria<br />
e del volontariato, la questione della chiusura della discarica di<br />
Cerro Maggiore, la ristrutturazione del settore periodici della<br />
Rizzoli, la vicenda delle scuole civiche e <strong>dei</strong> Centri Donna di<br />
Milano.<br />
Anche se in questa circostanza ha preferito non rilasciare interviste,<br />
l'<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia trova doveroso<br />
rendere omaggio alla sua carriera.<br />
25