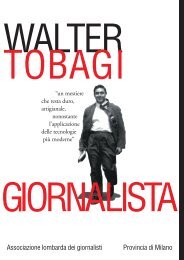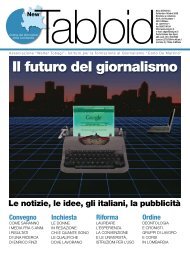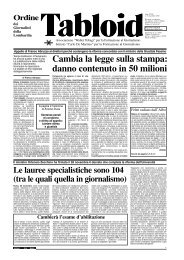Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio - Febbraio - Marzo 2007 - Ordine dei Giornalisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LIBRERIA DI TABLOID<br />
Maria Rosaria Ostuni, Gian Antonio Stella<br />
Sogni e fagotti<br />
Fino a quando, nel 1961, il<br />
neocaporedattore del Corriere<br />
d’Informazione Luigi<br />
Chiarelli chiese inaspettatamente<br />
a Buzzati di averne<br />
una copia.<br />
Forse poteva essere la volta<br />
buona, ma ancora l’improvvisa<br />
scomparsa di<br />
Chiarelli mandò l’elaborato<br />
a dormire fra le sue carte; fino<br />
a quando, nell’anno<br />
2000, proprio durante la rivoluzione<br />
in corso per preparare<br />
l’edizione fascicolata<br />
della cronaca milanese, il figlio<br />
di Chiarelli, Paolo, lo ritrovò<br />
e lo portò a Gian Giacomo<br />
Schiavi capocronista<br />
del Corriere.<br />
“Per cinque anni il rapporto<br />
è rimasto in Cronaca in un<br />
cassetto, poi il caso ha voluto<br />
che il capocronista ne<br />
parlasse in pubblico.<br />
Qualcuno ha pensato che<br />
potesse essere uno scoop.<br />
Invece è l’ultimo mistero di<br />
Buzzati. Un giornale da fare<br />
e che nessuno farà mai”<br />
scrive Schiavi nel suo commento<br />
di presentazione del<br />
volumetto Dino Buzzati il<br />
giornale segreto edito dalla<br />
Fondazione del Corriere<br />
della Sera nella collana “le<br />
carte del Corriere” per ricordare<br />
il centenario della nascita<br />
del grande giornalista.<br />
Recensire questo libro non<br />
è così semplice, anche perché,<br />
dopo la presentazione<br />
dell’opera a cura del presidente<br />
della Fondazione<br />
Pier Gaetano Marchetti, un<br />
approfondito commento si<br />
trova già nell’apertura del libro,<br />
scritto appunto dall’autore<br />
dello scoop.<br />
Sono trenta pagine di ricerche<br />
e di riflessioni nelle<br />
quali Schiavi non nasconde<br />
il suo stupore e la sua ammirazione<br />
per un progetto<br />
pieno di intuizioni ancora<br />
oggi così attuali.<br />
“Un Pomeriggio fra la Notte<br />
e il Giorno” titola Schiavi il<br />
suo commento, e quanto si<br />
poteva riscontrare dalla lettura<br />
delle quindici cartelle,<br />
lo ha già detto. Rimangono<br />
così solo poche briciole di<br />
commento a questo intervento<br />
per ribadire che ancora<br />
una volta Buzzati ci riserva<br />
una straordinaria lezione<br />
di buonsenso, nel rispetto<br />
del buon gusto e della<br />
buona educazione.<br />
Un contentino finale a chi si<br />
aspetta, leggendo una recensione,<br />
di conoscere<br />
non solo i lati positivi del lavoro<br />
in esame ma anche<br />
quelli negativi.<br />
Dedico a costoro una sola,<br />
piccolissima macchia che<br />
ho rilevato da lettore pignolo.<br />
Il grande attore comico<br />
romano, citato nel commento<br />
di Schiavi, famoso conduttore<br />
del programma televisivo<br />
“Il musichiere” si<br />
chiamava in realtà Mario, e<br />
non Mariolino Riva.<br />
Mi auguro che nelle prossime<br />
ristampe del volume<br />
questo veniale errore venga<br />
sistemato.<br />
Dino Buzzati,<br />
Il giornale segreto<br />
(collana<br />
“ le carte del Corriere”),<br />
Fondazione del Corriere<br />
della Sera,<br />
2006 tiratura limitata,<br />
pagine 99<br />
di Filippo Senatore<br />
“Noi andavam per lo solingo<br />
piano / com’om che torna alla<br />
perduta strada, / che ‘nfino<br />
ad essa li pare ire invano.”<br />
(Purg. C. I, vv.118/120).<br />
In cento anni, dal 1876 al<br />
1976, gli emigrati italiani sono<br />
stati almeno ventisette<br />
milioni. Questa è la nostra<br />
storia da riscoprire e rivalutare<br />
senza enfasi o censure<br />
falsamente patriottiche.<br />
È un evento epocale che interessa<br />
oggi drammaticamente<br />
altri popoli migranti,<br />
ma ci tocca da vicino con il<br />
fenomeno in ripresa dall’inizio<br />
degli anni ’90. Gli italiani<br />
sono i nuovi emigranti in<br />
Germania e in altri paesi<br />
anche se l’emigrazione di<br />
massa non esiste più, secondo<br />
la studiosa Edith<br />
Pichler dell’università di<br />
Berlino.<br />
Un passato non troppo remoto<br />
di persone in cerca di<br />
un altrove. Un presente che<br />
ci mette di fronte lo straniero<br />
che si spinge verso le nostre<br />
sponde. Da qui il bisogno<br />
di preservare una memoria<br />
collettiva per rispettare<br />
i nostri antenati ed allo<br />
stesso modo, gli immigrati<br />
extracomunitari leggendo<br />
nei loro occhi il medesimo<br />
smarrimento familiare di coloro<br />
che hanno abbandonato<br />
la patria fuggendo le malattie<br />
e la fame alla ricerca<br />
di una dignità nuova.<br />
Sogni e fagotti. Immagini,<br />
parole e canti degli emigranti<br />
italiani, il volume illustrato<br />
e corredato da un cd,<br />
di Maria Rosaria Ostuni e<br />
Gian Antonio Stella, ha il<br />
vantaggio rispetto ai precedenti<br />
libri sull’emigrazione<br />
di focalizzare l’immaginario<br />
e di sviluppare anticorpi<br />
contro il razzismo.<br />
“Le lettere, le parole che<br />
viaggiano per il mondo sono<br />
il filo sottile ma resistente<br />
che tiene unite le due<br />
parti di una famiglia divisa<br />
dall’emigrazione”.<br />
Chi scrive ricorda ancora<br />
negli anni Sessanta, Annuzza,<br />
un’anziana madre<br />
che viveva in un catoio buio,<br />
col viso scuro del fumo insalubre<br />
dello scaldino invernale,<br />
attendere con emozione<br />
la lettera del figlio dal<br />
Canada, emigrato da più di<br />
venti anni senza tornare al<br />
paesello.<br />
Quando il postino le consegnava<br />
quell’involucro con<br />
l’emblema postale straniero,<br />
la donnina in nero andava<br />
dalla vicina per farsi leggere<br />
la lettera. Gliela portava<br />
chiusa e il primo impatto<br />
era la caduta di banconote<br />
di vario taglio, per dimostrare<br />
a se stessa e agli altri<br />
che il figliolo aveva raggiunto<br />
il benessere ambito dopo<br />
anni di sacrifici. “Cara matre...<br />
tuo devotissimo figlio<br />
Cicero Antonio”. Sento ancora<br />
con emozione la voce<br />
perduta della mia nonna,<br />
trasmettere alla madre<br />
analfabeta da un altrove<br />
fantastico, le emozioni di un<br />
emigrato col rimpianto della<br />
lontananza incolmabile.<br />
Ostuni e Stella raccontano<br />
storie individuali e collettive<br />
scavando negli archivi e<br />
raccontando codeste vicende<br />
di miseria, illusioni e<br />
sfruttamento.<br />
Gli autori assemblano frammenti<br />
d’inchieste, testimonianze<br />
dirette e documenti<br />
cercando di interpretare, di<br />
capire e di spiegare.<br />
La grande emigrazione italiana<br />
è illustrata attraverso<br />
una straordinaria collezione<br />
di fotografie, copertine<br />
(dall’Illustrazione Italiana alla<br />
Domenica del Corriere),<br />
cartoline, manifesti e vignette.<br />
Sono spunti che sollecitano<br />
approfondimenti e curiosità<br />
che il lettore potrà soddisfare<br />
per i rimandi bibliografici<br />
continui.<br />
La felice suddivisione del libro<br />
è scandita dal passo attento,<br />
dato al visitatore di un<br />
museo che è anche una finestra<br />
sul presente. Si snoda<br />
un lungo flash back con<br />
una tecnica filmica e documentarista.<br />
La partenza, il viaggio e<br />
l’arrivo. L’insediamento. Il<br />
dramma del mancato riscatto.<br />
Il razzismo che degenera<br />
in linciaggio ed ecatombe.<br />
Ostuni e Stella descrivono<br />
la violenza e l’orrore,<br />
subiti dagli emigranti.<br />
Dal massacro di New<br />
Orleans nel 1891 all’eccidio<br />
d’Aigues Mortes in Camargue<br />
nel 1893.<br />
Tante famiglie hanno atteso<br />
il riscatto nelle generazioni<br />
successive.<br />
Pochi i successi immediati.<br />
Tante le illusioni di trovare il<br />
nuovo mondo lastricato d’oro.<br />
I fortunati trasmettono, ai<br />
parenti rimasti in Italia, foto<br />
che ostentano benessere<br />
ed abbondanza.<br />
A volte mascherano le ambientazioni<br />
con colpi di teatro<br />
per millantare ricchezze<br />
ed agiatezze.<br />
Una piccola minoranza ce<br />
l’ha fatta. Personaggi noti e<br />
meno noti in pochi anni sono<br />
stati baciati dalla fortuna<br />
e possono fregiarsi del nome<br />
di zio d’America.<br />
Gli autori mescolano immagini<br />
di luoghi ed epoche diverse<br />
con l’intento del raffronto,<br />
dell’uso intelligente<br />
della decifrazione. I dormitori<br />
della Ginevra del 1962<br />
non sono molto diversi da<br />
quelli della New York del<br />
1898.<br />
Lavori insalubri e pericolosi,<br />
mortalità infantile, incidenti<br />
sul lavoro e case malsane<br />
riproducono la miseria del<br />
luogo di provenienza. Il sogno<br />
si è infranto, ma la volontà<br />
emancipa la speranza.<br />
Il tempo lenisce le storie dolorose<br />
col ritornello di qualche<br />
vecchia strofa.<br />
In allegato al libro c’è un cd<br />
della Compagnia delle<br />
Acque e di Gualtiero<br />
Bertelli, che riproduce vecchie<br />
canzoni sull’emigrazione.<br />
Mamma mia dammi<br />
cento lire, La ballata di<br />
Sacco e Vanzetti”, La partenza<br />
per la Merica ecc.<br />
Grazie agli archivi della<br />
Fondazione Cresci, del<br />
Corriere della Sera, d’altri<br />
fondi privati ed alla passione<br />
<strong>dei</strong> due autori vengono<br />
alla luce ricordi di un album<br />
ritrovato, dimenticato in soffitta<br />
che ci fa riscoprire le<br />
nostre radici lontane.<br />
Maria Rosaria Ostuni,<br />
Gian Antonio Stella<br />
Sogni e fagotti.<br />
Immagini, parole e canti<br />
degli emigranti italiani,<br />
con cd della Compagnia<br />
delle Acque,<br />
Rizzoli libri illustrati,<br />
pagine 160, euro 25,00<br />
sta la voglia di fare confusione<br />
il meno possibile ma di ricordare,<br />
ricordare tutto, rimettere<br />
in sesto (e bene in fila)<br />
gli avvenimenti, a cominciare<br />
da quelli <strong>dei</strong> quali siamo<br />
stati testimoni diretti, non<br />
sempre sereni, il più delle<br />
volte inquieti, tormentati, pieni<br />
di paure, nervosi, lupi solitari,<br />
oppure completamente<br />
sbadati, svaniti, increduli,<br />
perfino incoscienti. C’è rimasta<br />
una gran voglia di comporre<br />
il “puzzle (il ‘prima’, il<br />
‘poi’ il ‘durante’) e sentiamo<br />
che dobbiamo finirlo in fretta,<br />
il nostro puzzle, perché il fiato<br />
viene a mancare di giorno<br />
in giorno, la memoria corre il<br />
rischio di sbriciolarsi quando<br />
non è esercitata, ed è proprio<br />
questo (lo sbriciolamento,<br />
l’annullamento della memoria:<br />
quella individuale, quella<br />
collettiva, quella storica) l’obbiettivo<br />
di chi vuole mettere<br />
una grossa pietra sopra a<br />
tutte queste storie, con il pretesto<br />
che sono storie che dividono,<br />
fomentano l’odio,<br />
provocano le divisioni, allontanano<br />
gli equilibri, le riconciliazioni,<br />
gli accordi.<br />
È vero il contrario. Quel passato<br />
aiuta a capire. Illumina i<br />
comportamenti, altrimenti incomprensibili,<br />
<strong>dei</strong> personaggi<br />
che affollano i palcoscenici<br />
di oggi”.<br />
Scritte nel 1999, queste parole<br />
appaiono profetiche, anzi,<br />
come fossero scritte oggi.<br />
Fra le molte lezioni di giornalismo<br />
che Nozza, inconsapevolmente,<br />
ha lasciato ce n’è<br />
una di cui ha fatto tesoro<br />
Alberto Papuzzi, nello scrivere<br />
il suo Manuale del giornalista.<br />
Rievoca, proprio nel primo<br />
capitolo dedicato alla ‘notizia’,<br />
un episodio avvenuto<br />
alla fine degli anni Sessanta<br />
e legato alla venuta in Italia<br />
del filosofo Herbert Marcuse.<br />
A Venezia, all’appuntamento<br />
con una decina di giornalisti<br />
al suo posto si presentò l’addetto<br />
stampa di un editore<br />
che aveva acquistato in<br />
esclusiva per una rivista il<br />
racconto del viaggio italiano<br />
di Marcuse. Spiegò che<br />
Marcuse non poteva parlare<br />
ma che lui era a disposizione<br />
per raccontare tutto quello<br />
che aveva fatto e aveva visto.<br />
Di necessità virtù: dopo qualche<br />
timida protesta i giornalisti<br />
cominciarono a fare domande.<br />
Tutti, tranne uno:<br />
Marco Nozza. il quale scorto<br />
un signore alto e allampanato<br />
che, dall’ascensore si avviava<br />
svelto, al fianco della<br />
moglie, verso l’uscita (era<br />
proprio Marcuse), abbandonò<br />
il gruppo e si mise a seguirlo.<br />
Papuzzi dietro Nozza,<br />
e un fotografo dietro i due. Di<br />
rispondere a domande, neanche<br />
l’ombra. A un certo<br />
Marco Nozza a Venezia con Herbert Marcuse.<br />
punto, chiaramente infastidito,<br />
torna sui suoi passi, rientra<br />
in albergo e rientra in<br />
ascensore. E Nozza dietro.<br />
Fino alla porta della camera<br />
che gli viene sbattuta in faccia.<br />
Che fare Papuzzi, allora alle<br />
prime armi, si adegua. E come<br />
altri ricicla le notizie fornite<br />
dall’addetto stampa.<br />
Qualcuno spudoratamente<br />
aveva finto di aver veramente<br />
intervistato il personaggio.<br />
L’indomani legge i giornali. E<br />
qui da Marco Nozza, la grande<br />
lezione di giornalismo.<br />
Sul Giorno raccontava passo<br />
dopo passo l’intera storia<br />
della fuga di Marcuse e<br />
signora dall’albergo, l’inseguimento,<br />
il dietrofront, la<br />
ritirata in camera.<br />
Descriveva la salita in<br />
ascensore, il cronista con i<br />
signori Marcuse, sordi alle<br />
domande più innocenti: “Le<br />
piace Venezia, professore<br />
Le piace Venezia, signora”<br />
Ci rimasi malissimo.<br />
Nozza raccontava ciò che<br />
era veramente accaduto. È<br />
stata la migliore lezione di<br />
giornalismo che io abbia<br />
mai ricevuto.<br />
E qui si riabilita la figura romantica<br />
del giornalista (andare,<br />
vedere, raccontare).<br />
Il commento di Papuzzi, ad<br />
uso degli studenti di giornalismo,<br />
va anche al di là.“La notizia<br />
non era Marcuse a<br />
Venezia, che passava indifferente<br />
davanti ai muri dell’Istituto<br />
di architettura imbrattati<br />
di scritte in spray rosso<br />
ispirate alla contestazione.<br />
La notizia non erano i suoi<br />
progetti editoriali nel riassunto<br />
dell’addetto stampa. Né il<br />
suo giudizio sul movimento<br />
studentesco in America o in<br />
Europa. Qual era la notizia<br />
Che l’autore de L’uomo a<br />
una dimensione, il collaboratore<br />
di Horkeimer, il pensatore<br />
che denunciava la non-libertà<br />
delle società industriali<br />
avanzate, appariva così vincolato<br />
da un contratto editoriale<br />
in esclusiva da rifiutare<br />
qualsiasi altro rapporto, mostrandosi<br />
di fatto prigioniero<br />
delle leggi del mercato e della<br />
concorrenza. Il critico <strong>dei</strong><br />
sistemi di controllo dentro un<br />
sistema di controllo.<br />
Nel ricordare Marco Nozza,<br />
attraverso le avvincenti pagine<br />
de Il Pistarolo, rivado a un<br />
giorno lontano, agli inizi degli<br />
anni cinquanta. Ci eravamo<br />
conosciuti a Lecco a un piccolo<br />
Premio, tra il giornalistico<br />
e il letterario, vincitori ex<br />
aequo di un concorso dedicato<br />
al paesaggio manzoniano.<br />
Lui aveva pubblicato il<br />
suo articolo su L’eco di<br />
Bergamo, io sul Corriere<br />
Lombardo con il nome de<br />
plume di Elio Pomi (lavorando<br />
in Rai, al Giornale radio,<br />
non ero autorizzato a firmare<br />
con il mio nome). Il premio<br />
era modesto, diviso in due,<br />
poi. Ma per noi, poco più che<br />
ventenni, i soldi non contavano.<br />
Ci domandammo a vicenda<br />
“Quanto ci danno” Per<br />
pura curiosità. Sul non dare<br />
valore al denaro ci accorgemmo,<br />
da subito, di essere<br />
d’accordo. E non cambiammo<br />
mai parere.<br />
Marco Nozza,<br />
Il pistarolo<br />
(da piazza Fontana,<br />
trent’anni di storia<br />
raccontati da un grande<br />
cronista),<br />
introduzione<br />
di Corrado Staiano<br />
Il Saggiatore, Milano 2006,<br />
pagine 384, euro 19,00<br />
ORDINE 1- 2- 3 <strong>2007</strong><br />
43