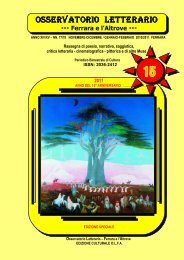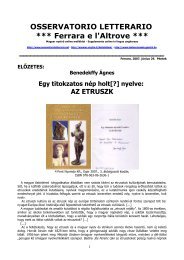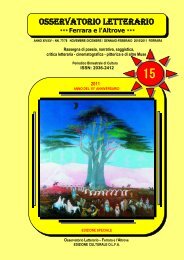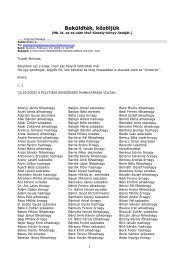Editoriali NN. 77/78 - Osservatorio Letterario
Editoriali NN. 77/78 - Osservatorio Letterario
Editoriali NN. 77/78 - Osservatorio Letterario
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nei linguaggi della malavita, dei soldati, dei mestieri, dei<br />
giovani, etc. Non si deve dimenticare che il gergo è<br />
usato spesso in ambienti e circostanze diverse da quelle<br />
originarie. Voci ed espressioni gergali, quando sono<br />
introdotte nella conversazione ordinaria, servono per un<br />
fine stilistico. In varie epoche la lingua letteraria italiana<br />
ha assunto termini ed espressioni dai gerghi per<br />
ricavarne espressività e colore: dal Rinascimento ai<br />
romanzi di Emilio Gadda (1893-1979) i gerghi hanno<br />
circolato nel mondo letterario italiano…<br />
Il grande studioso filologo ungherese Béla Bárczi<br />
(1894-1985) così si era espresso: «La lingua è lo<br />
strumento dei nostri pensieri e sentimenti, dei nostri<br />
rapporti quotidiani, è il componente principale, anzi è<br />
la condizione di ogni sviluppo umano. Senza la lingua<br />
non è immaginabile alcuna società umana neanche ad<br />
un livello più primitivo. La "lingua" è per ognuno la<br />
madrelingua. Si può imparare una lingua straniera, anzi<br />
in casi eccezionali si può anche saperla molto bene,<br />
ma a livello di madrelingua ogni suo elemento è pieno<br />
di mille colori e di contenuti espressivi, ed essa ci<br />
accompagna durante la nostra educazione e durante la<br />
nostra evoluzione, anzi in certo senso determina anche<br />
la nostra mentalità, il nostro modo di pensare… La<br />
profonda conoscenza della lingua, l'autoconsapevolezza<br />
linguistica sono doveri elementari di tutti, ma<br />
particolarmente di color che con intento artistico si<br />
presentano davanti al pubblico lettore…»<br />
Qui accennerei qualcosa a proposito un aspetto<br />
particolare della lingua nazionale d'Italia - della vostra<br />
lingua - nel rapporto tra la lingua italiana ed i dialetti.<br />
Per capire la realtà linguistica italiana d'oggi, bisogna<br />
tener conto della loro esistenza: la comunità linguistica<br />
fondamentale è rappresentata dall'insieme dei dialetti<br />
italiani che sono una parte importante della storia<br />
italiana. Tra gli Italiani c'è sempre stata anche la<br />
tendenza a riunirsi in un unico Stato e a parlare la<br />
stessa lingua. Quando Firenze riuscì ad affermare la sua<br />
civiltà e la sua lingua, quello fu l'inizio per ritrovare<br />
l'unità. Lo sforzo per diffondere l'uso di una lingua<br />
comune e l'aspirazione all'unità politica portarono al<br />
Risorgimento ed alla nascita dello Stato italiano. È<br />
questa l'altra storia della storia d'Italia, per gli Italiani<br />
oggi la più importante. La civiltà di Firenze ha dato<br />
origine alla “lingua italiana”: alla fine del Duecento<br />
Firenze era diventata una delle «grandi potenze»<br />
d'Europa. Questa forza economica e politica favorì lo<br />
sviluppo di una splendida civiltà: Firenze fu presto<br />
popolata di artisti e di scrittori. Nel Trecento tre scrittori<br />
- Dante, Petrarca, Boccaccio - scrissero opere di grande<br />
valore nel volgare fiorentino, loro lingua nativa. Gli<br />
scrittori delle altre regioni, affascinati dai modelli<br />
fiorentini della «Commedia», del «Canzoniere», del<br />
«Decameron», cominciarono fin dal Trecento ad<br />
imparare il fiorentino e a scrivere in questa lingua.<br />
Anche la diffusione della stampa, verso 1470, rafforzò<br />
questa tendenza. E così un po' alla volta il fiorentino fu<br />
considerato non più dialetto, ma la lingua comune degli<br />
Italiani. Naturalmente, gli scrittori di ogni epoca e gli<br />
abitanti di ogni regione hanno aggiunto via via al<br />
fiorentino molti elementi nuovi. Ma la struttura<br />
fondamentale della lingua comune era quella del<br />
fiorentino e tale è rimasta fino ad oggi.<br />
Per molto tempo la lingua italiana fu usata solo per<br />
scrivere. La lingua di tutti era il dialetto. Nel Seicento,<br />
Settecento ed Ottocento scrittori e scienziati di ogni<br />
regione usarono sempre più la lingua unitaria. Ma tale<br />
lingua era conosciuta solo dalle persone colte, che se<br />
ne servivano unicamente per scrivere; queste stesse<br />
persone non sapevano usarla con facilità quando<br />
parlavano! In fondo, la lingua italiana si parlava<br />
soltanto in Toscana, e un po' anche alla corte papale di<br />
Roma. Nel resto d'Italia le persone di ogni classe<br />
sociale, istruite o no, nella conversazione di qualsiasi<br />
genere e anche nelle discussioni in pubblico si<br />
servivano del dialetto locale. Insomma era ancora il<br />
dialetto la lingua viva e spontanea per la gran massa<br />
degli Italiani. Servendosi del solo dialetto, però, gli<br />
abitanti delle varie regioni non riuscivano a stabilire<br />
saldi legami tra loro; e di ciò si preoccuparono scrittori<br />
e studiosi. Mentre in Europa si compivano grandi eventi<br />
storici, si sentiva sempre più nel Paese la necessità che<br />
la lingua unitaria fosse compresa da tutti. Da alcuni<br />
secoli gli scrittori discutevano sulla «questione della<br />
lingua», cioè sulle difficoltà che creava in Italia la<br />
mancanza di una lingua comune, parlata da tutti.<br />
Nell'Ottocento le discussioni si fecero più vive, perché si<br />
constatava che la mancanza di unità linguistica<br />
ostacolava l'unificazione politica. I molti problemi<br />
discussi dagli scrittori dell'Ottocento cominciarono a<br />
risolversi davvero solo quando si formò lo Stato italiano<br />
unificato. L'unificazione politica dell'Italia - compiutasi<br />
tra 1859 e il 1870 - è l'avvenimento fondamentale che<br />
ha modificato le condizioni di vita del Paese e ha spinto<br />
per la prima volta la massa degli Italiani ad usare una<br />
lingua comune. Poi altri avvenimenti hanno avuto un<br />
effetto più rapido come gli spostamenti di popolazione,<br />
i nuovi mezzi di comunicazione di massa, l'istruzione<br />
gratuita ed obbligatoria. La lingua italiana è dunque,<br />
ormai, una lingua viva e largamente diffusa, però le<br />
abitudini della popolazione italiana sono in parte<br />
ancora diverse da un luogo all'altro. L'italiano ed il<br />
dialetto vivono ancora l'uno vicino all'altro. Perciò,<br />
anche chi parla sempre l'italiano, attraverso il suo<br />
ambiente ha preso almeno qualcosa dal dialetto locale.<br />
Ma i dialetti italiani sono tanti e diversi, e perciò<br />
l'italiano parlato è un po' diverso da regione a regione.<br />
Tant'è vero che spesso possiamo indovinare da quale<br />
regione proviene una persona, anche se parla soltanto<br />
in italiano. Questo italiano così “insaporito” di dialetto<br />
si chiama italiano parlato regionale.<br />
Se la lingua italiana non avesse accolto centinaia di<br />
vocaboli anche delle varie regioni, oggi ci<br />
mancherebbero molte parole ed espressioni più tipiche<br />
che usiamo. Queste voci dialettali sono penetrate nella<br />
lingua italiana un po' in tutte le epoche. Si nota che le<br />
parole prestate dai dialetti si riferiscono a moltissimi<br />
settori della vita comune e ciò vuol dire che gli Italiani<br />
nell'ultimo secolo hanno cominciato a conoscersi<br />
davvero. I legami sempre più stretti tra gli Italiani<br />
hanno permesso che si diffondessero rapidamente<br />
espressioni della lingua familiare o dei sopraccitati<br />
gerghi.<br />
La lingua italiana d'oggi, quindi, ha raccolto in sé<br />
tutta la storia del Paese: nella lingua si ritrova la traccia<br />
di tutti gli eventi che si sono succeduti nel tempo… A<br />
parere mio però è un errore opprimere il proprio<br />
OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l’Altrove A<strong>NN</strong>O XIV/XV – <strong>NN</strong>. <strong>77</strong>/<strong>78</strong> NOV. – DIC./GEN. – FEBB. 2010/2011 21