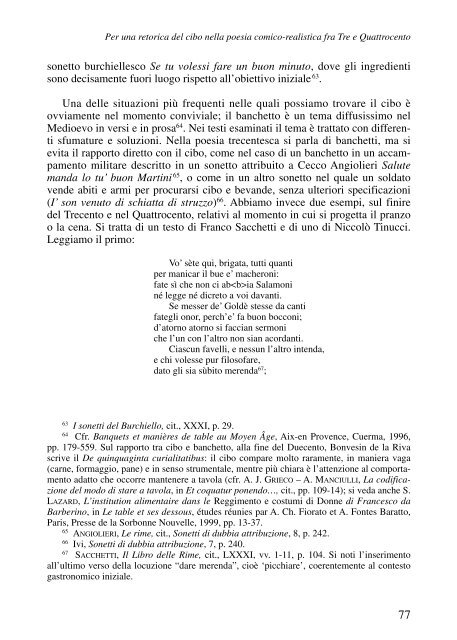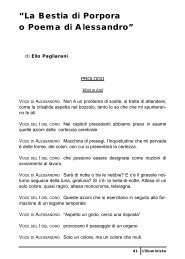Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Per</strong> <strong>una</strong> <strong>retorica</strong> <strong>del</strong> <strong>cibo</strong> <strong>nella</strong> <strong>poesia</strong> comico-realistica fra Tre e Quattrocento<br />
sonetto burchiellesco Se tu volessi fare un buon minuto, dove gli ingredienti<br />
sono decisamente fuori luogo rispetto all’obiettivo iniziale 63 .<br />
Una <strong>del</strong>le situazioni più frequenti nelle quali possiamo trovare il <strong>cibo</strong> è<br />
ovviamente nel momento conviviale; il banchetto è un tema diffusissimo nel<br />
Medioevo in versi e in prosa 64 . Nei testi esaminati il tema è trattato con differenti<br />
sfumature e soluzioni. Nella <strong>poesia</strong> trecentesca si parla di banchetti, ma si<br />
evita il rapporto diretto con il <strong>cibo</strong>, come nel caso di un banchetto in un accampamento<br />
militare descritto in un sonetto attribuito a Cecco Angiolieri Salute<br />
manda lo tu’ buon Martini 65 , o come in un altro sonetto nel quale un soldato<br />
vende abiti e armi per procurarsi <strong>cibo</strong> e bevande, senza ulteriori specificazioni<br />
(I’ son venuto di schiatta di struzzo) 66 . Abbiamo invece due esempi, sul finire<br />
<strong>del</strong> Trecento e nel Quattrocento, relativi al momento in cui si progetta il pranzo<br />
o la cena. Si tratta di un testo di Franco Sacchetti e di uno di Niccolò Tinucci.<br />
Leggiamo il primo:<br />
Vo’ sète qui, brigata, tutti quanti<br />
per manicar il bue e’ macheroni:<br />
fate sì che non ci abia Salamoni<br />
né legge né dicreto a voi davanti.<br />
Se messer de’ Goldè stesse da canti<br />
fategli onor, perch’e’ fa buon bocconi;<br />
d’atorno atorno si faccian sermoni<br />
che l’un con l’altro non sian acordanti.<br />
Ciascun favelli, e nessun l’altro intenda,<br />
e chi volesse pur filosofare,<br />
dato gli sia sùbito merenda 67 ;<br />
63 I sonetti <strong>del</strong> Burchiello, cit., XXXI, p. 29.<br />
64 Cfr. Banquets et manières de table au Moyen Âge, Aix-en Provence, Cuerma, 1996,<br />
pp. 179-559. Sul rapporto tra <strong>cibo</strong> e banchetto, alla fine <strong>del</strong> Duecento, Bonvesin de la Riva<br />
scrive il De quinquaginta curialitatibus: il <strong>cibo</strong> compare molto raramente, in maniera vaga<br />
(carne, formaggio, pane) e in senso strumentale, mentre più chiara è l’attenzione al comportamento<br />
adatto che occorre mantenere a tavola (cfr. A. J. GRIECO – A. MANCIULLI, La codificazione<br />
<strong>del</strong> modo di stare a tavola, in Et coquatur ponendo…, cit., pp. 109-14); si veda anche S.<br />
LAZARD, L’institution alimentaire dans le Reggimento e costumi di Donne di Francesco da<br />
Barberino, in Le table et ses dessous, études réunies par A. Ch. Fiorato et A. Fontes Baratto,<br />
Paris, Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1999, pp. 13-37.<br />
65 ANGIOLIERI, Le rime, cit., Sonetti di dubbia attribuzione, 8, p. 242.<br />
66 Ivi, Sonetti di dubbia attribuzione, 7, p. 240.<br />
67 SACCHETTI, Il Libro <strong>del</strong>le Rime, cit., LXXXI, vv. 1-11, p. 104. Si noti l’inserimento<br />
all’ultimo verso <strong>del</strong>la locuzione “dare merenda”, cioè ‘picchiare’, coerentemente al contesto<br />
gastronomico iniziale.<br />
77