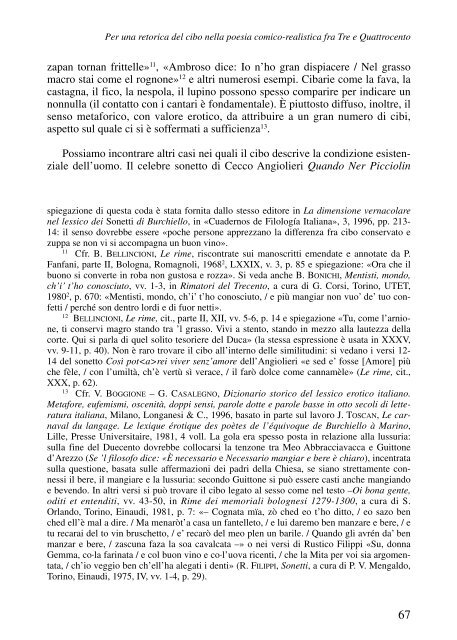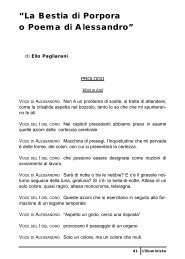Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Per una retorica del cibo nella poesia comicorealistica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Per</strong> <strong>una</strong> <strong>retorica</strong> <strong>del</strong> <strong>cibo</strong> <strong>nella</strong> <strong>poesia</strong> comico-realistica fra Tre e Quattrocento<br />
zapan tornan frittelle» 11 , «Ambroso dice: Io n’ho gran dispiacere / Nel grasso<br />
macro stai come el rognone» 12 e altri numerosi esempi. Cibarie come la fava, la<br />
castagna, il fico, la nespola, il lupino possono spesso comparire per indicare un<br />
nonnulla (il contatto con i cantari è fondamentale). È piuttosto diffuso, inoltre, il<br />
senso metaforico, con valore erotico, da attribuire a un gran numero di cibi,<br />
aspetto sul quale ci si è soffermati a sufficienza 13 .<br />
Possiamo incontrare altri casi nei quali il <strong>cibo</strong> descrive la condizione esistenziale<br />
<strong>del</strong>l’uomo. Il celebre sonetto di Cecco Angiolieri Quando Ner Picciolin<br />
spiegazione di questa coda è stata fornita dallo stesso editore in La dimensione vernacolare<br />
nel lessico dei Sonetti di Burchiello, in «Cuadernos de Filología Italiana», 3, 1996, pp. 213-<br />
14: il senso dovrebbe essere «poche persone apprezzano la differenza fra <strong>cibo</strong> conservato e<br />
zuppa se non vi si accompagna un buon vino».<br />
11 Cfr. B. BELLINCIONI, Le rime, riscontrate sui manoscritti emendate e annotate da P.<br />
Fanfani, parte II, Bologna, Romagnoli, 1968 2 , LXXIX, v. 3, p. 85 e spiegazione: «Ora che il<br />
buono si converte in roba non gustosa e rozza». Si veda anche B. BONICHI, Mentisti, mondo,<br />
ch’i’ t’ho conosciuto, vv. 1-3, in Rimatori <strong>del</strong> Trecento, a cura di G. Corsi, Torino, UTET,<br />
1980 2 , p. 670: «Mentisti, mondo, ch’i’ t’ho conosciuto, / e più mangiar non vuo’ de’ tuo confetti<br />
/ perché son dentro lordi e di fuor netti».<br />
12 BELLINCIONI, Le rime, cit., parte II, XII, vv. 5-6, p. 14 e spiegazione «Tu, come l’arnione,<br />
ti conservi magro stando tra ’l grasso. Vivi a stento, stando in mezzo alla lautezza <strong>del</strong>la<br />
corte. Qui si parla di quel solito tesoriere <strong>del</strong> Duca» (la stessa espressione è usata in XXXV,<br />
vv. 9-11, p. 40). Non è raro trovare il <strong>cibo</strong> all’interno <strong>del</strong>le similitudini: si vedano i versi 12-<br />
14 <strong>del</strong> sonetto Così potrei viver senz’amore <strong>del</strong>l’Angiolieri «e sed e’ fosse [Amore] più<br />
che fèle, / con l’umiltà, ch’è vertù sì verace, / il farò dolce come cannamèle» (Le rime, cit.,<br />
XXX, p. 62).<br />
13 Cfr. V. BOGGIONE – G. CASALEGNO, Dizionario storico <strong>del</strong> lessico erotico italiano.<br />
Metafore, eufemismi, oscenità, doppi sensi, parole dotte e parole basse in otto secoli di letteratura<br />
italiana, Milano, Longanesi & C., 1996, basato in parte sul lavoro J. TOSCAN, Le carnaval<br />
du langage. Le lexique érotique des poètes de l’équivoque de Burchiello à Marino,<br />
Lille, Presse Universitaire, 1981, 4 voll. La gola era spesso posta in relazione alla lussuria:<br />
sulla fine <strong>del</strong> Duecento dovrebbe collocarsi la tenzone tra Meo Abbracciavacca e Guittone<br />
d’Arezzo (Se ’l filosofo dice: «È necessario e Necessario mangiar e bere è chiaro), incentrata<br />
sulla questione, basata sulle affermazioni dei padri <strong>del</strong>la Chiesa, se siano strettamente connessi<br />
il bere, il mangiare e la lussuria: secondo Guittone si può essere casti anche mangiando<br />
e bevendo. In altri versi si può trovare il <strong>cibo</strong> legato al sesso come nel testo –Oi bona gente,<br />
oditi et entenditi, vv. 43-50, in Rime dei memoriali bolognesi 1279-1300, a cura di S.<br />
Orlando, Torino, Einaudi, 1981, p. 7: «– Cognata mïa, zò ched eo t’ho ditto, / eo sazo ben<br />
ched ell’è mal a dire. / Ma menaròt’a casa un fantelleto, / e lui daremo ben manzare e bere, / e<br />
tu recarai <strong>del</strong> to vin bruschetto, / e’ recarò <strong>del</strong> meo plen un barile. / Quando gli avrén da’ ben<br />
manzar e bere, / zasc<strong>una</strong> faza la soa cavalcata –» o nei versi di Rustico Filippi «Su, donna<br />
Gemma, co·la farinata / e col buon vino e co·l’uova ricenti, / che la Mita per voi sia argomentata,<br />
/ ch’io veggio ben ch’ell’ha alegati i denti» (R. FILIPPI, Sonetti, a cura di P. V. Mengaldo,<br />
Torino, Einaudi, 1975, IV, vv. 1-4, p. 29).<br />
67