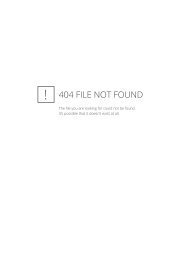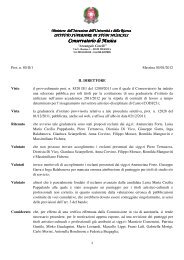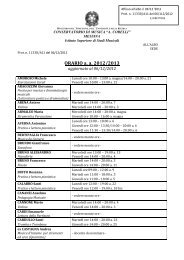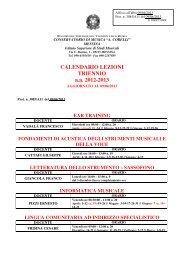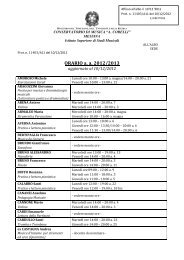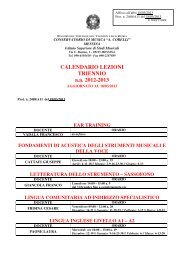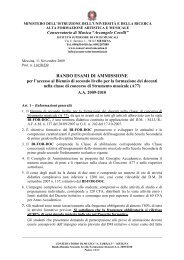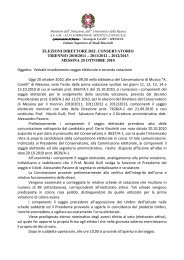6 LABATE - Conservatorio di Messina
6 LABATE - Conservatorio di Messina
6 LABATE - Conservatorio di Messina
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RINTRACCIARE IL NOVECENTO. IL TESTO LETTERARIO NEL TEATRO MUSICALE 291<br />
incessante gioco <strong>di</strong> Leitmotive, in linguaggio letterario 37 , creare insomma<br />
una versione romanzesca del dramma musicale wagneriano. Già<br />
in Trionfo della Morte e finalmente col romanzo Il Fuoco (1900) D’Annunzio<br />
cerca attraverso Wagner la nuova opera italiana che abbia come<br />
motivo conduttore la superiorità dell’arte italiana su quella tedesca, la<br />
schietta melo<strong>di</strong>a popolare me<strong>di</strong>terranea contro la cerebrale polifonia armonica<br />
‘nor<strong>di</strong>ca’ del Parsifal. D’Annunzio, dunque, in nome dell’opera<br />
totale, per mezzo <strong>di</strong> continui ritorni in circolo del materiale verbale,<br />
intraprende lo scar<strong>di</strong>namento del suo sistema espressivo e si <strong>di</strong>rige<br />
verso nuove più autentiche acquisizioni conoscitive, tecniche e tematiche<br />
fino a creare una prosa plastica e musicale 38 : limatura della lingua<br />
che continuerà anche dopo aver superato il wagnerismo. È il periodo<br />
nel quale Fausto Torrefranca, Giannotto Bastianelli e Raffaello De Rensis<br />
– pur continuando a riconoscere la grandezza <strong>di</strong> Wagner – auspicano<br />
un superamento <strong>di</strong> lui e sollecitano l’avvento del dramma musicale<br />
italiano dell’avvenire. In questo rinnovarsi del nazionalismo musicale<br />
D’Annunzio che prima <strong>di</strong>sprezzava ‘la giovane scuola italiana’ ora<br />
37 Il termine Leitmotiv è stato coniato appositamente per il noto proce<strong>di</strong>mento wagneriano, ma<br />
secondo Carl Dahlhaus tale proce<strong>di</strong>mento era già prefigurato nel dramma <strong>di</strong> Shakespeare, principalmente<br />
nella sua forma aperta. Quanto più autonoma si presenta la singola scena o la singola situazione<br />
e quanto meno essa appare come funzione del tutto, tanto più spontaneo <strong>di</strong>viene ricostruire<br />
o in<strong>di</strong>care una connessione legando tra loro le singole parti attraverso metafore ricorrenti o parole<br />
capaci <strong>di</strong> rimanere impresse. Dunque il Leitmotiv è originariamente un proce<strong>di</strong>mento poetico che<br />
trova sviluppo nella musica più che nella letteratura stessa, la quale, per ovvie ragioni, sopporta<br />
soltanto un minimo grado <strong>di</strong> ripetizione. (CARL DAHLHAUS, La concezione wagneriana del dramma<br />
musicale, Firenze, Discanto, 1983, p. 28).<br />
38 Nel Fuoco è possibile incontrare una duplice e <strong>di</strong>versa musicalità. Prevalentemente nella<br />
prima fase del romanzo lo scrittore tenta <strong>di</strong> introdurre una prosa musicale per mezzo <strong>di</strong> tecniche<br />
proprie dell’oratoria, giungendo quin<strong>di</strong> alla creazione <strong>di</strong> pagine sonore ed altisonanti. Ma via via,<br />
attraverso un <strong>di</strong>ssolvimento delle strutture logico-narrative, D’Annunzio giunge ad un comporre<br />
puramente musicale nel quale domina un senso <strong>di</strong> meraviglia e <strong>di</strong> soffusa malinconia. La stessa<br />
materia verbale appare rarefatta ed alleggerita, capace <strong>di</strong> piegarsi ad ogni più sottile mutamento<br />
interiore, fino alla scoperta del valore musicale del silenzio. La musicalità della sua prosa, ricca<br />
<strong>di</strong> una scelta sapiente <strong>di</strong> vocaboli sonori ed eloquenti, si accresce infatti <strong>di</strong> un particolare uso della<br />
punteggiatura, volto sia a scan<strong>di</strong>re ritmicamente i perio<strong>di</strong>, sia a sottolineare, con dei silenzi, determinati<br />
pensieri. (ANNAMARIA D’AMATO, Influenze wagneriane ne «Il fuoco» <strong>di</strong> G. D’Annunzio, in<br />
«Il Monocordo», anno 2°, 1997, n.3/4, maggio/settembre, pp. 49-56).