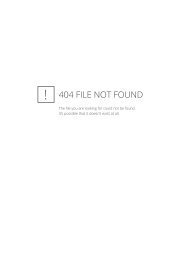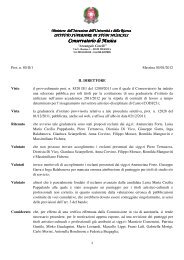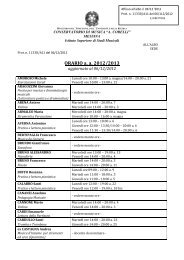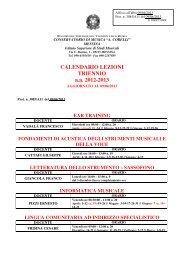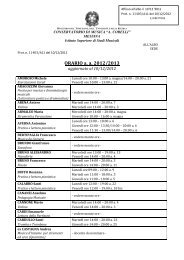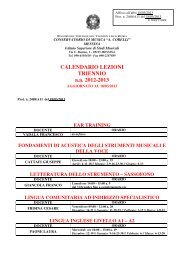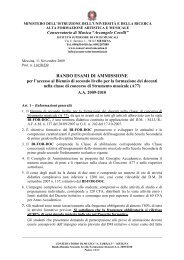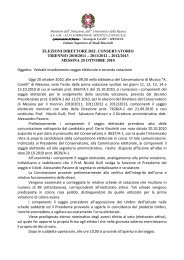6 LABATE - Conservatorio di Messina
6 LABATE - Conservatorio di Messina
6 LABATE - Conservatorio di Messina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RINTRACCIARE IL NOVECENTO. IL TESTO LETTERARIO NEL TEATRO MUSICALE 313<br />
ha un prevalente carattere contemplativo, una sotterranea trepidazione<br />
che ne accompagna lo scorrimento, con uno strano senso <strong>di</strong> stupore, talora<br />
anche <strong>di</strong>vertito ma privo <strong>di</strong> ottimismo. Non meno che nella drammaturgia<br />
pirandelliana. I tre caratteri sopra esposti, già ampiamente<br />
presenti nelle Sette canzoni, impliciti nello spettacolo <strong>di</strong> immagini del<br />
primo teatro <strong>di</strong> Malipiero, <strong>di</strong>verranno più evidenti in La favola grazie<br />
alla collaborazione con Pirandello.<br />
La favola del figlio cambiato appartiene al filone pirandelliano dei<br />
miti concretato nella trilogia costituita dalla Nuova colonia, da Lazzaro<br />
e dagli incompiuti Giganti della montagna. Anche La favola si allaccia<br />
all’archetipo della Grande Madre-Terra quale erogatrice <strong>di</strong> vita, archetipo<br />
<strong>di</strong> una civiltà arcaica matriarcale, incarnato dalla protagonista nella<br />
figura della Madre. Pirandello ha ben coscienza <strong>di</strong> completare La favola<br />
mentre dà ad essa la funzione <strong>di</strong> libretto: «È il primo vero e proprio libretto<br />
che io scrivo. Gli altri erano riduzioni <strong>di</strong> lavori preesistenti». Da<br />
questo momento Pirandello si investe responsabilmente del ruolo <strong>di</strong><br />
librettista. E infatti, a partire dal secondo atto egli acuisce il gioco delle<br />
rime, fornisce ritmi metrici acconci alle situazioni musicali, porge tipiche<br />
situazioni melodrammatiche e opportunità <strong>di</strong> emergenze liriche.<br />
Sono caratteristici ad esempio gli accenti ternari sul ritmo <strong>di</strong> una tarantella<br />
nell’episo<strong>di</strong>o dell’Uomo Saputo del primo quadro; le rime da canzonetta<br />
nella scena della Sciantosa che apre il secondo atto: «La mia vita<br />
è qua, / la mia vita è là, / trottola, trottola, / requie non ha»; l’esibizione<br />
<strong>di</strong> luoghi canonici tipici del melodramma, come quelli dell’agnizione<br />
e del tripu<strong>di</strong>o conclusivi; ed ancora le occasioni da romanza allestite<br />
soprattutto nel terzo atto. Pirandello, in definitiva, assume il ruolo convenzionale<br />
<strong>di</strong> librettista, visibile in quell’atteggiamento subalterno dello<br />
scrittore nei confronti del musicista, al quale si rimette completamente.<br />
E, nell’inviare i primi due quadri a Malipiero, gli lascia piena libertà <strong>di</strong><br />
aggiungere, togliere e adattare. Malipiero tuttavia è riluttante ad accettare<br />
i libretti altrui dotati <strong>di</strong> uno sviluppo drammatico e che con l’aggiunta<br />
della musica sarebbero <strong>di</strong>ventati per lui insopportabilmente melodrammatici.<br />
Per questo in altre composizioni confeziona un proprio