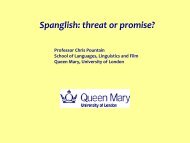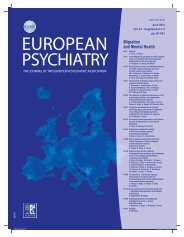la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l a P s i c h i a t r i a d i c o m u n i t à t r a r a z i o n a l i t à e P a s s i o n e<br />
alle quali corrispondono poi purtroppo soggetti reali e<br />
operatori destinati a occuparsene.<br />
La democraticità era, per Rapaport (1960), uno<br />
degli strumenti distintivi del<strong>la</strong> comunità terapeutica<br />
rispetto al<strong>la</strong> psichiatria tradizionale; <strong>la</strong> democrazia dei<br />
trattamenti e <strong>la</strong> possibilità di realizzarli rispettando <strong>la</strong><br />
volontà del<strong>la</strong> persona e intervenendo in modo rispettoso<br />
del suo ambiente naturale di vita sono ancora per <strong>la</strong><br />
PdC uno strumento clinico centrale, più ancora che un<br />
aspetto, pur doveroso, di carattere etico (Farkas, 2006;<br />
Warner, 2006). Per questo <strong>la</strong> PdC ha bisogno di guardare<br />
al <strong>paziente</strong> <strong>con</strong> sguardo generoso, di valorizzare<br />
le potenzialità di autoaiuto dei singoli e dei gruppi, di<br />
esserci e di sapersi fare da parte al momento opportuno<br />
(Peloso, 2006). Incessantemente, e senza scheletri nel<br />
proprio armadio: e quindi anche <strong>con</strong> un’attenzione<br />
per i diritti del<strong>la</strong> persona in crisi, un impegno volto<br />
a non abbandonare il <strong>paziente</strong> e per il <strong>con</strong>tenimento<br />
del ricorso al TSO, per rendere <strong>la</strong> <strong>con</strong>tenzione fisica<br />
costante oggetto di problematizzazione e <strong>con</strong>tenerne al<br />
massimo frequenza e durata fino ad abolir<strong>la</strong> (Catanesi<br />
et al., 2006). Le esperienze di autoaiuto, o quelle che si<br />
collocano sulle frontiere del<strong>la</strong> riabilitazione (pensiamo<br />
al viaggio in barca a ve<strong>la</strong>), il coinvolgimento dei pazienti<br />
nel<strong>la</strong> valutazione di processi ed esiti dei servizi sono<br />
strumenti ai quali, ancora, è riservata un’attenzione<br />
troppo di nicchia, in grado, se più diffusi e approfonditi,<br />
di rianimare (nel duplice significato di riportare<br />
in vita e restituire l’anima) pratiche talora comatose, e<br />
dimostrarsi utili, forse, a formare e appassionare buoni<br />
operatori, oltre che a <strong>con</strong>tribuire al<strong>la</strong> guarigione dei<br />
pazienti.<br />
In se<strong>con</strong>do luogo, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia mentale, e in partico<strong>la</strong>re<br />
<strong>la</strong> psicosi, rappresenta, per le modalità in cui si declina<br />
in rapporto <strong>con</strong> le caratteristiche del<strong>la</strong> persona e del<strong>la</strong><br />
reazione <strong>con</strong> l’ambiente, un fenomeno complesso, che<br />
necessita di un approccio non riduzionistico (Angelozzi<br />
et al., 2005): <strong>la</strong> psichiatria antiistituzionale preoccupata<br />
di divenire istituzione, sguardo oggettivante sul corpo<br />
del <strong>paziente</strong>, quale <strong>la</strong> cogliamo in due scritti centrali di<br />
Basaglia (1965, 1968), <strong>la</strong> psichiatria del<strong>la</strong> persona e dei<br />
piccoli gruppi sociali, che tanto ha ricevuto in questi<br />
anni dal patrimonio di riflessione fenomenologica e<br />
psicodinamica dei nostri servizi, nel<strong>la</strong> sua modestia e<br />
sobrietà perciò non offre certezze assolute, e rimane<br />
istanza critica che rende insoddisfacente, provvisoria<br />
ogni soluzione al problema del modello, come al problema<br />
del<strong>la</strong> risposta da dare, qui e ora, al soggetto.<br />
Ma proprio per <strong>la</strong> sua complessità, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia mentale<br />
89<br />
deve anche essere affrontata, nel quadro di una presa<br />
in carico improntata al<strong>la</strong> <strong>con</strong>tinuità terapeutica e al<br />
funzionamento dell’équipe, come momento unificante<br />
di culture, professionalità e soggetti, <strong>con</strong> trattamenti<br />
(Ciancaglini et al., 2000) mirati e puntiformi, decisamente<br />
sostenuti nel<strong>la</strong> letteratura internazionale, volti<br />
ad aggredir<strong>la</strong> iso<strong>la</strong>ndone gli elementi <strong>con</strong> una tattica a<br />
“foglie di carciofo”. Interventi strutturati psicoeducazionali<br />
e cognitivo-comporta<strong>mentali</strong>, ad esempio, che<br />
costituis<strong>con</strong>o una scommessa sul fatto che ciascuno,<br />
se informato e sostenuto, può metterci del suo per<br />
farce<strong>la</strong> e insieme uno sforzo generoso di essere vicini<br />
e presenti al <strong>paziente</strong> e pensarlo – come fa, in riferimento<br />
al corpo, il fisioterapista – nel<strong>la</strong> realtà dei suoi<br />
problemi uno per uno: rego<strong>la</strong>zione delle emozioni,<br />
disturbi cognitivi, disabilità re<strong>la</strong>zionali, cura del corpo,<br />
dell’abitare, del<strong>la</strong> gestione dei farmaci ecc. (Lamonaca<br />
et al., 2003, 2006).<br />
In terzo luogo spesso, in partico<strong>la</strong>re ma non solo<br />
nelle psicosi, i bisogni primari sono legati al corpo e al<strong>la</strong><br />
soddisfazione di esigenze materiali: corpo certo vissuto,<br />
ma per essere autenticamente e non astrattamente tale,<br />
anche – e prima – corpo medico da preservare dalle<br />
ma<strong>la</strong>ttie e corpo sociale da mantenere pulito, accudire,<br />
aiutare a muoversi, abitare, da alloggiare, nutrire, coinvolgere<br />
nei momenti del<strong>la</strong> socialità, dello sport, del<strong>la</strong><br />
cultura e del <strong>la</strong>voro. Interventi che implicano una presa<br />
in carico complessiva del<strong>la</strong> persona certo non solo, ma<br />
anche, quando occorre, nel<strong>la</strong> <strong>con</strong>cretezza dei bisogni<br />
– simile a quel<strong>la</strong> che altri servizi, per esempio geriatrici,<br />
garantis<strong>con</strong>o – attraverso processi di sostegno o, dove<br />
non basta, di assistenza <strong>con</strong>creta cui un approccio solo<br />
attento al verbale, al simbolico, non risponde; vale in<br />
questi casi per <strong>la</strong> psichiatria, come per altre aree del<strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>zione di aiuto, l’obiettivo di <strong>con</strong>iugare protezione<br />
e promozione ed essere “un mestiere in cui prevale <strong>la</strong><br />
dimensione squisitamente pratica” in cui l’operatore<br />
sarà, caso per caso, “quello che fa fare”, “quello che<br />
aiuta a”, “quello che si prende cura di”, “quello che<br />
fa” (Brandani & Zuffinetti, 2004).<br />
Infine, re<strong>la</strong>tivamente al decorso, se un maggior impegno<br />
dei servizi sul versante del trattamento precoce<br />
è oggi doveroso e potrà evitare probabilmente in futuro<br />
molte situazioni che oggi vediamo evolvere negativamente,<br />
ciò non offre però ragioni etiche o prognostiche<br />
per un disinvestimento da quelle situazioni in cui un<br />
trattamento precoce non è più possibile; scrive Ballerini<br />
(1987) che: “Il gruppo operativo si misura sul<strong>la</strong><br />
quantità e sul tipo di progetti, fantasie e realizzazioni<br />
Psich Com v6n2 2007.indd 89 21-06-2007 12:07:21