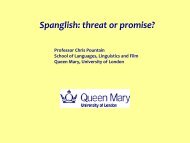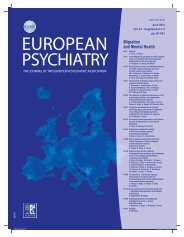la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
a l l e a n z a t e r a P e u t i c a , t e o r i a d e l l ’ a t t a c c a m e n t o e m e n t a l i z z a z i o n e<br />
lento costituirsi di uno spazio mentale che <strong>con</strong>senta<br />
poi <strong>la</strong> comunicazione di osservazioni e ipotesi utili<br />
al<strong>la</strong> comprensione riflessiva del<strong>la</strong> sua persona.<br />
alleanza terapeutica, teoria dell’attaccamento<br />
e <strong>mentali</strong>zzazione<br />
L’alleanza terapeutica (AT), intesa nel<strong>la</strong> sua accezione<br />
più ampia come accordo intorno agli obiettivi<br />
del trattamento, ai compiti reciproci e allo stabilirsi<br />
del necessario legame affettivo-empatico a livello sia<br />
individuale che istituzionale, quando sono coinvolte<br />
più figure professionali come nei setting pubblici,<br />
rappresenta un buon esempio del <strong>la</strong>voro sul positivo<br />
già accennato. In ogni modo l’alleanza terapeutica è<br />
per definizione bassa all’inizio del trattamento <strong>con</strong> i<br />
pazienti difficili e, quando è troppo elevata, rischia di<br />
essere <strong>la</strong> <strong>con</strong>seguenza di un eccesso di idealizzazione,<br />
che ugualmente può comportare cadute e rotture importanti.<br />
Il suo costituirsi nel corso del trattamento, il<br />
passaggio cioè dal<strong>la</strong> fase di accettazione del <strong>con</strong>tratto<br />
iniziale a quel<strong>la</strong> di <strong>la</strong>voro, in cui il <strong>paziente</strong> effettivamente<br />
ri<strong>con</strong>osce nel terapeuta un col<strong>la</strong>boratore esperto<br />
e affidabile che lo aiuta a comprendere se stesso come<br />
persona, è un processo lungo e difficile, del<strong>la</strong> durata a<br />
volte di anni, sovente, nei casi favorevoli, un punto di<br />
arrivo e non di partenza. Anzi, visto che nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione<br />
terapeutica si crea un forte coinvolgimento emotivo,<br />
il percorso è spesso costel<strong>la</strong>to da inevitabili rotture<br />
di questo legame e dal<strong>la</strong> sua riparazione successiva.<br />
Il ripetersi di queste sequenze può essere utile a<br />
formare una situazione terapeutica nel<strong>la</strong> quale l’identificazione<br />
<strong>con</strong> il terapeuta e il suo modo di affrontare<br />
le difficoltà costituis<strong>con</strong>o un modo per interiorizzarlo<br />
e un meccanismo di cambiamento significativo per il<br />
<strong>paziente</strong>. Dal<strong>la</strong> nostra ricerca empirica sui rapporti tra<br />
lo sviluppo dell’alleanza terapeutica e i risultati del<strong>la</strong><br />
cura psichiatrica su un piano sintomatologico all’interno<br />
di un Day Hospital territoriale (Pulido et al., in corso<br />
di pubblicazione), risulta che non ha tanto importanza<br />
il suo livello iniziale, quanto che essa si sviluppi positivamente,<br />
anche se di poco, <strong>con</strong>fermando l’impressione<br />
clinica che in quest’area di pazienti i livelli precoci di<br />
AT non sono di per sé corre<strong>la</strong>ti <strong>con</strong> esiti positivi.<br />
In fondo lo sviluppo dell’AT può essere <strong>con</strong>siderato<br />
del tutto simile al costituirsi nel tempo di un legame<br />
di attaccamento, agli stessi meccanismi cioè che sono i<br />
requisiti fondanti <strong>la</strong> base sicura, per dir<strong>la</strong> nel linguaggio<br />
clinicamente così evocativo del<strong>la</strong> teoria dell’attaccamento.<br />
Essi sono operativi nel<strong>la</strong> diade madre-bambino<br />
103<br />
e possono essere applicati metaforicamente anche<br />
ai rapporti terapeutici <strong>con</strong> i pazienti adulti (Holmes,<br />
2001). Consistenza personale, costanza, affidabilità,<br />
capacità empatica di sintonizzazione, di mantenere <strong>la</strong><br />
prossimità emotiva e di riparare <strong>la</strong> rottura del legame<br />
e capacità negativa di aspettare il momento opportuno<br />
per riproporre le ipotesi di cura, garantendosi non solo<br />
nelle fasi più mature del trattamento una certa <strong>libertà</strong> di<br />
movimento: dal<strong>la</strong> scherzosità all’espressione <strong>con</strong>trol<strong>la</strong>ta<br />
del<strong>la</strong> propria partecipazione emotiva all’interno del<br />
setting terapeutico. Infine, il <strong>la</strong>voro clinico all’interno<br />
del<strong>la</strong> prospettiva del<strong>la</strong> teoria dell’attaccamento prevede<br />
che il terapeuta comunichi attivamente al <strong>paziente</strong> che<br />
egli è lì per pensare insieme a lui a che cosa sta succedendo<br />
nel<strong>la</strong> sua mente, cercando di capire e <strong>con</strong>tenere<br />
le rappresentazioni <strong>mentali</strong> dei suoi sentimenti e di<br />
trasporle in parole. È questa funzione riflessiva o <strong>mentali</strong>zzazione<br />
che Bateman e Fonagy (2004) ritengono<br />
debba essere specificamente sviluppata nel<strong>la</strong> terapia<br />
dei pazienti <strong>gravi</strong> e difficili, i quali a loro volta si trovano<br />
fin dall’infanzia nel<strong>la</strong> <strong>con</strong>dizione di non riuscire<br />
a <strong>con</strong>cepire, per gli ambienti variamente traumatici in<br />
cui sono vissuti, una “teoria del<strong>la</strong> mente” nel genitore<br />
ancor prima che in se stessi. Essi <strong>la</strong> definis<strong>con</strong>o come<br />
“il processo mentale mediante il quale un individuo<br />
esplicitamente o implicitamente interpreta le proprie<br />
azioni o quelle degli altri come significative sul<strong>la</strong> base<br />
di stati <strong>mentali</strong> intenzionali quali desideri personali, bisogni,<br />
sentimenti, opinioni e ragioni” (pag. XXI). Senza<br />
entrare nel merito dei <strong>con</strong>cetti teorici su cui si fonda<br />
questo costrutto, <strong>la</strong> fenomenologia del<strong>la</strong> <strong>mentali</strong>zzazione<br />
si basa su alcuni aspetti che sono clinicamente assai<br />
significativi: ha a che fare <strong>con</strong> <strong>la</strong> capacità di mettersi<br />
nei panni altrui, coinvolge l’abilità di vedere e valutare<br />
se stesso e i sentimenti dell’altro dal di fuori, denota <strong>la</strong><br />
capacità di differenziare i sentimenti intorno al<strong>la</strong> realtà<br />
dal<strong>la</strong> realtà stessa, è un fenomeno graduale e discreto<br />
e non funziona se<strong>con</strong>do una modalità “tutto o nul<strong>la</strong>”,<br />
dipende dalle <strong>con</strong>dizioni emozionali del soggetto ed è<br />
potenziata dal<strong>la</strong> presenza vicina di una figura di accudimento<br />
sicura o di altra persona, <strong>con</strong> cui si sia instaurata<br />
una re<strong>la</strong>zione affettivamente significativa.<br />
Non è certo un <strong>con</strong>cetto psicoanalitico nuovo: i<br />
<strong>con</strong>cetti di rêverie di Bion (1962), di preoccupazione<br />
materna primaria di Winnicott (1958) di interiorizzazione<br />
trasmutante di Kohut (1977) e anche di alcuni<br />
autori del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> francese, tra cui ultimi Lecours e<br />
Bouchard (1997), del<strong>la</strong> <strong>mentali</strong>zzazione come antitesi<br />
al<strong>la</strong> pensée opératoire, sono solo alcuni esempi di come<br />
Psich Com v6n2 2007.indd 103 21-06-2007 12:07:35