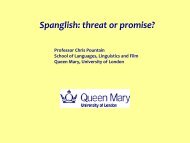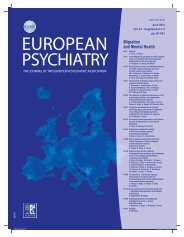la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
la libertà Di scelta Del paziente con Disturbi mentali gravi - Personal ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a l l e a n z a t e r a P e u t i c a , t e o r i a d e l l ’ a t t a c c a m e n t o e m e n t a l i z z a z i o n e<br />
danni iatrogeni, se proposta in termini rigidi che non<br />
tengono <strong>con</strong>to del<strong>la</strong> capacità del <strong>paziente</strong> di utilizzar<strong>la</strong>,<br />
in quanto rischia di causare un’iperattivazione dei<br />
sistemi di attaccamento dei pazienti <strong>con</strong> grave disturbo<br />
borderline, che avverrebbe a detrimento ulteriore delle<br />
già compromesse capacità di <strong>mentali</strong>zzazione (Fonagy<br />
& Bateman, 2006). Insomma nei casi più <strong>gravi</strong> occorre<br />
avere <strong>la</strong> realistica modestia di individuare il setting o<br />
il <strong>con</strong>testo interpersonale più semplice da proporre,<br />
per esempio un rapporto di cura <strong>con</strong> uno psichiatra,<br />
evitando premature spiegazioni <strong>con</strong>sce o in<strong>con</strong>sce<br />
del problema. Risuona anche in questo caso <strong>la</strong> frase<br />
di Winnicott, “nel <strong>la</strong>voro ambu<strong>la</strong>toriale cerco di fare<br />
il minimo che è necessario”, che in questo <strong>con</strong>testo<br />
diviene un monito <strong>con</strong>tro proposte dettate più dal<br />
desiderio del terapeuta che non dall’effettivo bisogno<br />
del <strong>paziente</strong>.<br />
Per quanto riguarda le modalità <strong>con</strong> cui porgere le<br />
ipotesi interpretative, intendo qui sottolineare l’importanza<br />
del tono colloquiale <strong>con</strong> cui vengono espresse,<br />
dell’aspetto terminologico prossimo il più possibile al<br />
vocabo<strong>la</strong>rio del <strong>paziente</strong> e <strong>la</strong> possibilità che tali ipotesi<br />
siano proposte a mezza via tra terapeuta e <strong>paziente</strong>,<br />
come qualcosa che può essere non solo accettato o<br />
rifiutato, ma anche ampliato, digerito in un se<strong>con</strong>do<br />
tempo o fatto proprio. Anche una certa enfasi affermativa<br />
in tutti gli interventi ordinari del terapeuta, volti a<br />
<strong>con</strong>fermare <strong>la</strong> sicurezza del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione e a valorizzare <strong>la</strong><br />
significatività del senso di sé e del<strong>la</strong> propria esperienza<br />
intima, può costituire per il <strong>paziente</strong> una prova del suo<br />
essere compreso.<br />
Molte altre possono essere le dotazioni necessarie<br />
per affrontare questi inizi difficili, ma rimando al ben<br />
più ampio <strong>la</strong>voro del 2000. Vorrei solo soffermarmi sul<br />
fatto che da un <strong>la</strong>to, nel<strong>la</strong> dinamica transfert-<strong>con</strong>trotransfert,<br />
è spesso inevitabile trovarci ad agire insieme<br />
al <strong>paziente</strong> ciò che egli non è in grado di esprimere<br />
altrimenti e che dall’altro occorre <strong>la</strong>sciarsi coinvolgere<br />
in una qualche forma di responsività di ruolo, amma<strong>la</strong>rsi<br />
parzialmente del<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia del <strong>paziente</strong>, per poterne<br />
riemergere poi riflessivamente e riprendere una funzione<br />
di pensiero. È una grossa illusione infatti quel<strong>la</strong> di<br />
mantenere sotto <strong>con</strong>trollo in tempo reale nel corso del<strong>la</strong><br />
seduta ciò che il <strong>paziente</strong> ci comunica ed è più spesso<br />
<strong>con</strong> il senno di poi che possiamo comprendere queste<br />
situazioni, riuscendo a rie<strong>la</strong>borare ciò che avviene in<br />
seduta solo quando il <strong>paziente</strong> ne è uscito. Tutto questo<br />
rende ragione delle difficoltà che possiamo in<strong>con</strong>trare,<br />
del tempo che è necessario, del<strong>la</strong> costanza di cercare<br />
105<br />
di svolgere <strong>la</strong> nostra funzione anche nelle fasi di maggiore<br />
tempesta emotiva del <strong>paziente</strong> e nostra e del<strong>la</strong><br />
ragionevole speranza che possiamo <strong>con</strong>tinuare a coltivare<br />
realisticamente dentro di noi, nonostante tutto. Un<br />
altro rischio che è facile mettere in moto in questi casi<br />
è rappresentato dal<strong>la</strong> sequenza Persecutore-Vittima-Salvatore<br />
(Barale, 2006), che può permeare potentemente<br />
e insidiosamente <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione terapeutica non solo <strong>con</strong> i<br />
curanti più giovani e inesperti, inducendo riaccensioni<br />
sintomatologiche e regressioni in<strong>con</strong>trol<strong>la</strong>bili.<br />
Va da sé che, se uno dei compiti terapeutici è quello<br />
di “fare sicurezza” al <strong>paziente</strong>, il terapeuta deve mettersi<br />
egli stesso nel<strong>la</strong> <strong>con</strong>dizione di essere “in sicurezza”<br />
a opera di un terzo. Quando le cose vanno bene questa<br />
terzietà può essere rappresentata dal<strong>la</strong> formazione<br />
individuale e dalle teorie che sono al<strong>la</strong> base del nostro<br />
operare, ma in situazioni di crisi un’analisi personale,<br />
una supervisione <strong>con</strong> qualcuno più esperto, il gruppo<br />
dei colleghi o il gruppo di <strong>la</strong>voro nelle situazioni istituzionali<br />
possono costituire situazioni che ci mettono in<br />
“sicurezza” e che ci <strong>con</strong>sentono di riprendere a pensare,<br />
cercando di recuperare quel<strong>la</strong> corda che noi, magari<br />
senza accorgerci, avevamo tagliato. In alcuni pochi casi<br />
però “tagliare <strong>la</strong> corda”, in situazioni pericolose per il<br />
<strong>paziente</strong> e perciò impraticabili in quel<strong>la</strong> fase sul piano<br />
psicoterapeutico, comporta molta riflessione, coraggio<br />
e dolore, ma a volte è l’unica cosa da fare e non è detto<br />
che abbia <strong>con</strong>seguenze negative.<br />
■ bibliografia<br />
Bacal H.A. (1998). Optimal responsiveness. Jason Aronson: Northvale,<br />
New Jersey and London.<br />
Barale F. (2006). Il fondo instabile dell’esperienza: riflessioni su trauma<br />
e <strong>con</strong>dizione borderline. Seminario per operatori psichiatrici presso<br />
Centro Psicoanalitico di Bologna, febbraio 2006.<br />
Bateman A. & Fonagy P. (2004). Il trattamento basato sul<strong>la</strong> <strong>mentali</strong>zzazione.<br />
Raffaello Cortina Editore: Mi<strong>la</strong>no, 2006.<br />
Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Armando: Roma,<br />
1972.<br />
B<strong>la</strong>ck D.M. (2004). Sympathy re<strong>con</strong>figured: some reflections on<br />
sympathy, empathy and the discovery of values. International Journal<br />
of Psychoanalysis 85, 579-596.<br />
Bolognini S. & Borghi L. (1989). Empatia. Rivista di Psicoanalisi<br />
35,1077-1099.<br />
Correale A. (2006). Area traumatica e campo istituzionale. Bor<strong>la</strong>:<br />
Roma.<br />
Fonagy P. & Bateman A. (2006). Progress in the treatment<br />
of borderline personality disorder. British Journal of Psychiatry<br />
188,1-3.<br />
Psich Com v6n2 2007.indd 105 21-06-2007 12:07:38