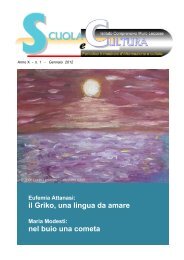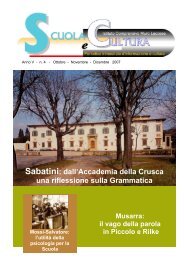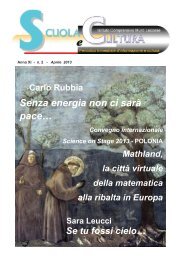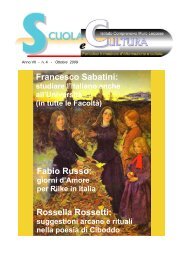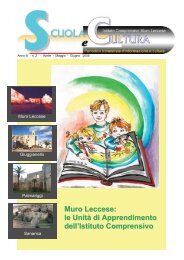Scuola e Cultura - Ottobre 2012 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2012 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2012 - scuola e cultura - rivista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ottobre</strong> <strong>2012</strong><br />
La nuova astronomia del '900: l’astrofisica e la<br />
natura fisica delle stelle<br />
Fino all’inizio dell’800 l’astronomia consisteva<br />
soprattutto nella determinazione delle posizioni<br />
e dei moti delle stelle e dei pianeti e nella<br />
misura delle loro distanze. In realtà la prima misura<br />
diretta della distanza di una stella è avvenuta solo nel<br />
1838 ad opera di Friedrich Wilhelm Bessel.<br />
Nel 1835 un filosofo francese, Auguste Comte<br />
scriveva: gli astronomi riusciranno a misurare con<br />
sempre maggior precisione, posizioni, moti e<br />
distanze delle stelle, ma non riusciranno mai a capire<br />
la loro natura fisica, la loro composizione chimica.<br />
Nel suo corso di filosofia positiva, per sottolineare<br />
che la vera scienza è impossibile se non è basata<br />
sull’esperienza, affermava che ogni nozione sulla<br />
vera temperatura media delle stelle ci rimarrà<br />
necessariamente sempre sconosciuta.<br />
Eppure proprio in quegli anni si stava affermando la<br />
tecnologia che avrebbe permesso di conoscere<br />
temperatura, densità e quindi stato della materia di<br />
cui sono fatte le stelle, la loro composizione chimica,<br />
le fonti dell’energia che esse irradiano, la loro<br />
formazione ed evoluzione, tutti temi che sono stati<br />
ampiamente studiati e risolti nel corso del '900- la<br />
spettroscopia.<br />
La spettroscopia consiste nell’analizzare la luce<br />
bianca emessa da un qualsiasi corpo luminoso<br />
studiandone le componenti monocromatiche dal<br />
rosso al violetto.<br />
L’immagine di una stella data dal telescopio è un<br />
puntolino biancastro. Se sul cammino del fascio di<br />
luce in arrivo si interpone un prisma di vetro si ottiene<br />
una successione di immagini colorate dal rosso al<br />
violetto, quello che si chiama lo spettro della stella. In<br />
esso sono contenute informazioni sulla temperatura,<br />
densità, composizione chimica, moti della stella, che<br />
in gran parte si è imparato a leggere compiutamente<br />
solo nei primi decenni del '900, grazie alla nuova<br />
fisica, la fisica quantistica sviluppata da Max Planck<br />
(1848-1947) e da Niels Bohr (1885-1962). Ma già<br />
Aldebaran<br />
nella seconda metà<br />
dell’800, in gran parte<br />
grazie alle osservazioni di<br />
un gran numero di spettri<br />
stellari, Angelo Secchi<br />
(1818-1878) capì che il<br />
colore delle stelle è un<br />
indice della loro<br />
temperatura superficiale:<br />
stelle rossastre come<br />
Aldebaran o Betelgeuse<br />
sono meno calde delle<br />
stelle bianco azzurre come<br />
Sirio, Vega o Rigel. Infatti<br />
ASTRONOMIA<br />
Margherita Hack<br />
Astrofisica di fama<br />
internazionale<br />
Secchi faceva l’analogia con un pezzo di metallo<br />
portato all’incandescenza: questo infatti dapprima<br />
emette solo calore (cioè radiazione infrarossa), poi<br />
diventa rosso cupo, poi rosso brillante, giallastro e<br />
infine bianco azzurrastro. Con Planck si trova<br />
l’espressione matematica della radiazione irraggiata<br />
nei vari colori (cioè alle varie lunghezze d’onda, dalle<br />
più brevi nel violetto alle più lunghe nel rosso) e la<br />
sua dipendenza dalla temperatura del corpo<br />
raggiante, in particolare si trova che la lunghezza<br />
d’onda λ del massimo di irraggiamento cade a<br />
lunghezze d’onda tanto più corte quanto più alta è la<br />
temperatura T:<br />
λT= costante = 0,289789 cm * gradi Kelvin<br />
Le osservazioni degli spettri stellari permettono così<br />
di stabilire che anche le stelle più fredde, quelle di<br />
colore rossastro hanno temperatura superficiali di<br />
circa 2000 gradi kelvin (la scala di gradi kelvin<br />
differisce dalla centigrada perché lo zero centigrado<br />
cade a 273 gradi kelvin o gradi assoluti, a -273 gradi<br />
centigradi cade lo zero assoluto, cioè la minima<br />
temperatura possibile, i 100 gradi centigradi<br />
corrispondono a 373 gradi kelvin). A queste<br />
temperature l’unico stato possibile della materia è<br />
quello gassoso. Si capisce così che le stelle sono dei<br />
palloni di gas e poiché il gas è lo stato<br />
più semplice della materia, utilizzando le<br />
leggi sul comportamento dei gas,<br />
studiate in laboratorio, si riesce a<br />
stabilire anche come vari la temperatura<br />
e la densità nell’interno della stella, dai<br />
suoi strati più superficiali fino al centro.<br />
Una caratteristica degli spettri stellari,<br />
scoperta per la prima volta nello spettro<br />
solare da Joseph Fraunhofer (1787-<br />
1826) consiste nella presenza di<br />
numerose righe scure che solcano lo<br />
spettro, perpendicolarmente alla striscia<br />
dal rosso al violetto.<br />
Per molto tempo la natura e l’origine<br />
delle “righe di Fraunhofer” rimase un<br />
mistero, che fu risolto da Gustav<br />
Kirchhoff (1824-1887). Illuminando la<br />
sottile fenditura di uno spettroscopio (un<br />
7