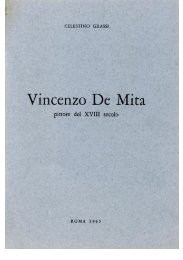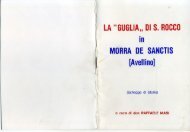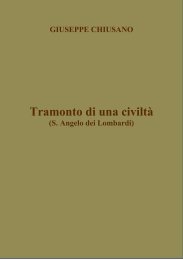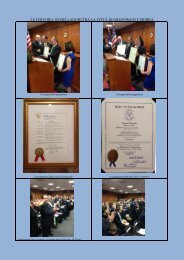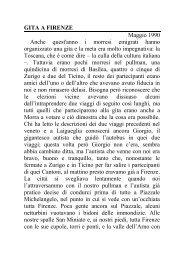Tra cronaca e storia - Morreseemigrato.ch
Tra cronaca e storia - Morreseemigrato.ch
Tra cronaca e storia - Morreseemigrato.ch
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fibula a navicella con apofisi laterali e bracciale ad arco inflesso<br />
(Vili-VI sec. a. C.). Morra De Sanctis - Piano di Cerasuolo.<br />
di carbonio, dando alla ceramica quel colore nero,<br />
talvolta di una lucentezza metallica.<br />
Il corredo metallico è costituito essenzialmente<br />
da manufatti di bronzo. Abbiamo le fibule ad<br />
oc<strong>ch</strong>iali, ad arco serpeggiante, a sanguisuga, a<br />
navicella, <strong>ch</strong>e fungevano da spille di sicurezza per il<br />
vestiario.<br />
Accanto a queste fibule realmente funzionali e di<br />
uso comune, si rinvengono nelle tombe altre di<br />
notevoli dimensioni, ritrovate a Morra nei pressi<br />
della Cappella della Maddalena, dette « da parata »,<br />
<strong>ch</strong>e attestavano nel corredo il prestigio di classe del<br />
defunto. Caratteristico è il bracciale « ad arco inflesso<br />
» ritrovato a Morra nella zona di Piano di Cerasuolo e<br />
delle Fontanelle, espresso in moltissimi esemplari<br />
fino al VI sec. a. C., <strong>ch</strong>e costituisce quasi il bronzo<br />
fossile ed emblematico di questa cultura. Splendido<br />
poi, nel suo elegante e stilizzato portamento, un<br />
bronzetto figurativo di cavallo, forse del VII sec. a.<br />
C., tipicamente « illirico », proveniente dalla zona<br />
della Cappella della Maddalena; è l’animale prediletto<br />
La fibula a navicella vista da un'altra angolazione.<br />
corredo metallico in bronzo <strong>ch</strong>e testimoniano<br />
l’origine balcanica di queste popolazioni.<br />
Corredo tombale — Per vasellame d’impasto<br />
si intende l’argilla poco o niente affatto depurata,<br />
cotta in forno aperto e lavorata a mano, senza<br />
l’uso del tornio, per cui naturalmente la ceramica<br />
non raggiungeva quella compattezza <strong>ch</strong>e si ebbe<br />
poi con l’introduzione dei forni <strong>ch</strong>iusi, in seguito<br />
agli influssi greci attraverso le colonie dei centri<br />
costieri (Poseidonia, Cuma). Quest’impasto poteva<br />
essere sia in colore <strong>ch</strong>iaro (6), quello più<br />
grossolano, sia di color scuro, nerastro, per<strong>ch</strong>é<br />
cotto con legna ancora verde <strong>ch</strong>e bruciando<br />
sviluppava ossido<br />
c’è un grande ritardo nel superare uno stadio di civiltà<br />
primitiva. Per questa grande diversità culturale, mentre<br />
nell’Egeo fioriva la grande civiltà di Creta e poi di Micene,<br />
qui si esce dalla prei<strong>storia</strong> dopo <strong>ch</strong>e quelle civiltà erano già<br />
tramontate.<br />
Dopo il 1000 a. C., con l’Età del Ferro, il popolamento<br />
della Campania diviene molto più intenso; è possibile<br />
riconoscere gruppi culturali diversi, <strong>ch</strong>e si distinguono non<br />
soltanto per la provenienza e per le caratteristi<strong>ch</strong>e proprie<br />
della produzione artigianale, ma an<strong>ch</strong>e per il modo in cui si<br />
dispongono sul territorio e per le scelte economi<strong>ch</strong>e. L’Età<br />
del Ferro rappresenta per la Campania un momento in cui<br />
prevale il particolarismo culturale, e si definisce la<br />
fisionomia di alcuni comprensori <strong>ch</strong>e condizioneranno nei<br />
secoli la <strong>storia</strong> più recente della regione.<br />
Intorno alla metà dell’VIII sec. a. C., con la fondazione<br />
di Cuma, si definisce il quadro delle componenti etni<strong>ch</strong>e e<br />
culturali <strong>ch</strong>e determineranno l’aspetto della Campania preromana:<br />
da un lato le popolazioni itali<strong>ch</strong>e, osco-sanniti<strong>ch</strong>e,<br />
più o meno legate alle culture indigene dell’Età del Ferro,<br />
dall’altro la componente etrusca (Capua, Fratte di Salerno,<br />
Pontecagnano), <strong>ch</strong>e si ricollega all’aspetto « Villanoviano » di<br />
cui conserva la vitalità dei rapporti con i centri del- l’Etruria<br />
meridionale e la caratteristica funeraria di incenerire i morti;<br />
infine la componente «reca limitata alla costa, con i centri di<br />
Pitecusa (Is<strong>ch</strong>ia), Cuma, Parthenope-Neapolis (Napoli) e<br />
Dicear<strong>ch</strong>ia (Pozzuoli), ed oltre il Sele, Poseidonia (Paestum)<br />
ed Elea (Velia).<br />
(5) Un vaso ora restaurato, della fine dell’Età del<br />
Bronzo (X sec. a. C.), decorato a incisioni e con prese laterali<br />
mammellonate, è stato rinvenuto a Morra, nella zona di<br />
Piano di Cerasuolo.<br />
(6) Dalle Fontanelle proviene un’olla, d’impasto <strong>ch</strong>iaro,<br />
grezzo, con orlo decorato ad intac<strong>ch</strong>i e con ciotola-attingitoio<br />
a vernice nera; quest’insieme tombale è simbolo<br />
dell’accumulo delle ric<strong>ch</strong>ezze <strong>ch</strong>e, per una comunità<br />
agricola, è rappresentata innanzitutto dalle derrate<br />
alimentari.