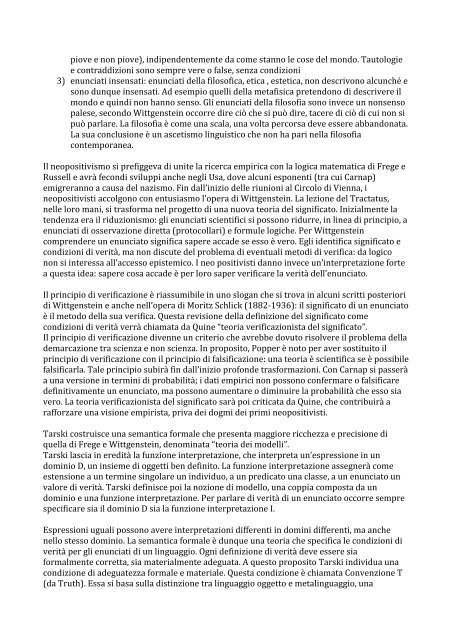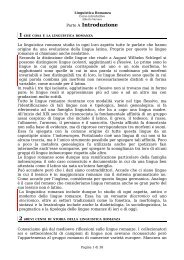Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
piove e non piove), indipendentemente da come stanno le cose del mondo. Tautologie<br />
e contraddizioni sono sempre vere o false, senza condizioni<br />
3) enunciati insensati: enunciati della filosofica, etica , estetica, non descrivono alcunché e<br />
sono dunque insensati. Ad esempio quelli della metafisica pretendono di descrivere il<br />
mondo e quindi non hanno senso. Gli enunciati della filosofia sono invece un nonsenso<br />
palese, secondo Wittgenstein occorre dire ciò che si può dire, tacere di ciò di cui non si<br />
può parlare. La filosofia è come una scala, una volta percorsa deve essere abbandonata.<br />
La sua conclusione è un ascetismo linguistico che non ha pari nella filosofia<br />
contemporanea.<br />
Il neopositivismo si prefiggeva di unite la ricerca empirica con la logica matematica di Frege e<br />
Russell e avrà fecondi sviluppi anche negli Usa, dove alcuni esponenti (tra cui Carnap)<br />
emigreranno a causa del nazismo. Fin dall’inizio delle riunioni al Circolo di Vienna, i<br />
neopositivisti accolgono con entusiasmo l’opera di Wittgenstein. La lezione del Tractatus,<br />
nelle loro mani, si trasforma nel progetto di una nuova teoria del significato. Inizialmente la<br />
tendenza era il riduzionismo: gli enunciati scientifici si possono ridurre, in linea di principio, a<br />
enunciati di osservazione diretta (protocollari) e formule logiche. Per Wittgenstein<br />
comprendere un enunciato significa sapere accade se esso è vero. Egli identifica significato e<br />
condizioni di verità, ma non discute del problema di eventuali metodi di verifica: da logico<br />
non si interessa all’accesso epistemico. I neo positivisti danno invece un’interpretazione forte<br />
a questa idea: sapere cosa accade è per loro saper verificare la verità dell’enunciato.<br />
Il principio di verificazione è riassumibile in uno slogan che si trova in alcuni scritti posteriori<br />
di Wittgenstein e anche nell’opera di Moritz Schlick (1882-‐1936): il significato di un enunciato<br />
è il metodo della sua verifica. Questa revisione della definizione del significato come<br />
condizioni di verità verrà chiamata da Quine “teoria verificazionista del significato”.<br />
Il principio di verificazione divenne un criterio che avrebbe dovuto risolvere il problema della<br />
demarcazione tra scienza e non scienza. In proposito, Popper è noto per aver sostituito il<br />
principio di verificazione con il principio di falsificazione: una teoria è scientifica se è possibile<br />
falsificarla. Tale principio subirà fin dall’inizio profonde trasformazioni. Con Carnap si passerà<br />
a una versione in termini di probabilità; i dati empirici non possono confermare o falsificare<br />
definitivamente un enunciato, ma possono aumentare o diminuire la probabilità che esso sia<br />
vero. La teoria verificazionista del significato sarà poi criticata da Quine, che contribuirà a<br />
rafforzare una visione empirista, priva dei dogmi dei primi neopositivisti.<br />
Tarski costruisce una semantica formale che presenta maggiore ricchezza e precisione di<br />
quella di Frege e Wittgenstein, denominata “teoria dei modelli”.<br />
Tarski lascia in eredità la funzione interpretazione, che interpreta un’espressione in un<br />
dominio D, un insieme di oggetti ben definito. La funzione interpretazione assegnerà come<br />
estensione a un termine singolare un individuo, a un predicato una classe, a un enunciato un<br />
valore di verità. Tarski definisce poi la nozione di modello, una coppia composta da un<br />
dominio e una funzione interpretazione. Per parlare di verità di un enunciato occorre sempre<br />
specificare sia il dominio D sia la funzione interpretazione I.<br />
Espressioni uguali possono avere interpretazioni differenti in domini differenti, ma anche<br />
nello stesso dominio. La semantica formale è dunque una teoria che specifica le condizioni di<br />
verità per gli enunciati di un linguaggio. Ogni definizione di verità deve essere sia<br />
formalmente corretta, sia materialmente adeguata. A questo proposito Tarski individua una<br />
condizione di adeguatezza formale e materiale. Questa condizione è chiamata Convenzione T<br />
(da Truth). Essa si basa sulla distinzione tra linguaggio oggetto e metalinguaggio, una