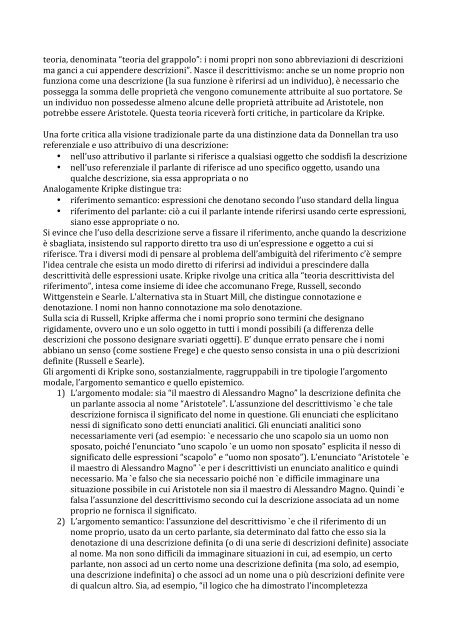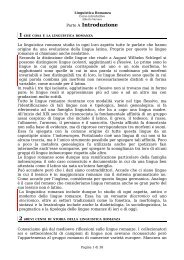Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
teoria, denominata “teoria del grappolo”: i nomi propri non sono abbreviazioni di descrizioni<br />
ma ganci a cui appendere descrizioni”. Nasce il descrittivismo: anche se un nome proprio non<br />
funziona come una descrizione (la sua funzione è riferirsi ad un individuo), è necessario che<br />
possegga la somma delle proprietà che vengono comunemente attribuite al suo portatore. Se<br />
un individuo non possedesse almeno alcune delle proprietà attribuite ad Aristotele, non<br />
potrebbe essere Aristotele. Questa teoria riceverà forti critiche, in particolare da Kripke.<br />
Una forte critica alla visione tradizionale parte da una distinzione data da Donnellan tra uso<br />
referenziale e uso attribuivo di una descrizione:<br />
• nell’uso attributivo il parlante si riferisce a qualsiasi oggetto che soddisfi la descrizione<br />
• nell’uso referenziale il parlante di riferisce ad uno specifico oggetto, usando una<br />
qualche descrizione, sia essa appropriata o no<br />
Analogamente Kripke distingue tra:<br />
• riferimento semantico: espressioni che denotano secondo l’uso standard della lingua<br />
• riferimento del parlante: ciò a cui il parlante intende riferirsi usando certe espressioni,<br />
siano esse appropriate o no.<br />
Si evince che l’uso della descrizione serve a fissare il riferimento, anche quando la descrizione<br />
è sbagliata, insistendo sul rapporto diretto tra uso di un’espressione e oggetto a cui si<br />
riferisce. Tra i diversi modi di pensare al problema dell’ambiguità del riferimento c’è sempre<br />
l’idea centrale che esista un modo diretto di riferirsi ad individui a prescindere dalla<br />
descrittività delle espressioni usate. Kripke rivolge una critica alla “teoria descrittivista del<br />
riferimento”, intesa come insieme di idee che accomunano Frege, Russell, secondo<br />
Wittgenstein e Searle. L’alternativa sta in Stuart Mill, che distingue connotazione e<br />
denotazione. I nomi non hanno connotazione ma solo denotazione.<br />
Sulla scia di Russell, Kripke afferma che i nomi proprio sono termini che designano<br />
rigidamente, ovvero uno e un solo oggetto in tutti i mondi possibili (a differenza delle<br />
descrizioni che possono designare svariati oggetti). E’ dunque errato pensare che i nomi<br />
abbiano un senso (come sostiene Frege) e che questo senso consista in una o più descrizioni<br />
definite (Russell e Searle).<br />
Gli argomenti di Kripke sono, sostanzialmente, raggruppabili in tre tipologie l’argomento<br />
modale, l’argomento semantico e quello epistemico.<br />
1) L’argomento modale: sia “il maestro di Alessandro Magno” la descrizione definita che<br />
un parlante associa al nome “Aristotele”. L’assunzione del descrittivismo `e che tale<br />
descrizione fornisca il significato del nome in questione. Gli enunciati che esplicitano<br />
nessi di significato sono detti enunciati analitici. Gli enunciati analitici sono<br />
necessariamente veri (ad esempio: `e necessario che uno scapolo sia un uomo non<br />
sposato, poiché l’enunciato “uno scapolo `e un uomo non sposato” esplicita il nesso di<br />
significato delle espressioni “scapolo” e “uomo non sposato”). L’enunciato “Aristotele `e<br />
il maestro di Alessandro Magno” `e per i descrittivisti un enunciato analitico e quindi<br />
necessario. Ma `e falso che sia necessario poiché non `e difficile immaginare una<br />
situazione possibile in cui Aristotele non sia il maestro di Alessandro Magno. Quindi `e<br />
falsa l’assunzione del descrittivismo secondo cui la descrizione associata ad un nome<br />
proprio ne fornisca il significato.<br />
2) L’argomento semantico: l’assunzione del descrittivismo `e che il riferimento di un<br />
nome proprio, usato da un certo parlante, sia determinato dal fatto che esso sia la<br />
denotazione di una descrizione definita (o di una serie di descrizioni definite) associate<br />
al nome. Ma non sono difficili da immaginare situazioni in cui, ad esempio, un certo<br />
parlante, non associ ad un certo nome una descrizione definita (ma solo, ad esempio,<br />
una descrizione indefinita) o che associ ad un nome una o più descrizioni definite vere<br />
di qualcun altro. Sia, ad esempio, “il logico che ha dimostrato l’incompletezza