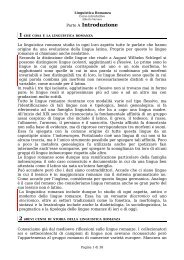Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
Riassunto Penco - Appunti Unict
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lo stesso senso può essere espresso in vari modi, con diverso tono ad esempio (per tono<br />
intendiamo coloritura grammaticale: la pula ha beccato il compare). Le differenti forme<br />
grammaticali o stilistiche non devono far dimenticare il “contenuto concettuale”, che resta<br />
costante da una lingua all’altra o anche nei diversi modi di esprimersi nella stessa lingua.<br />
Frege fornisce una definizione di “identità di senso”: possiamo attribuire lo stesso senso a<br />
enunciati da cui derivano le stesse conclusioni. Il senso o contenuto concettuale di un<br />
enunciato è il suo potenziale inferenziale. Per potenziale inferenziale si intende la capacità di<br />
un enunciato di permettere diverse inferenze, cioè di far derivare un certo insieme di<br />
conseguenze. Capire un enunciato significa conoscere le principali inferenze che sono<br />
connesse ad esso. Il senso di un enunciato non si distingue solo dalla forza ma anche dal tono<br />
o colorazione retorica associata ad esso. Il tono ha la funzione di comunicare quelle intenzioni<br />
dei parlanti che non sono riconducibili al contenuto cognitivo esplicito e diretto, ma<br />
dipendono dal rapporto del parlante con le circostanze e l’uditorio. Non sempre il contenuto<br />
letterale corrisponde con quello che vogliamo far intendere. Quindi il senso è il contenuto<br />
diretto, il tono è il contenuto indiretto.<br />
In enunciati del tipo "questo albero è coperto di foglie" Frege rileva che la semplice sequenza<br />
di parole non è l'espressione completa del pensiero. L'enunciato esprime a volte non di più ma<br />
di meno rispetto a un pensiero completo:<br />
• da una parte una enunciazione spesso esprime qualcosa di più che un pensiero,<br />
esprime sia la forza sia la colorazione e il tono che vanno al di là del mero contenuto<br />
cognitivo dell'enunciato, valutabile come vero o falso<br />
• dall'altra spesso la mera sequenza delle parole di un enunciato non basta a esprimere<br />
un pensiero, ma lo esprime solo se completata da aspetti temporali e da altre<br />
circostanze concomitanti date dal contesto (sguardi o altri aspetti del comportamento).<br />
Nel primo caso, parlando di tono si vanno a toccare le intenzioni dei parlanti (psicologia), nel<br />
secondo è necessario considerare la presenza di circostanze concomitanti, il tempo e il luogo<br />
di proferimento, le intenzioni dei parlanti. Sembra che il pensiero dipenda da situazioni<br />
occasionali e rapporti tra parlanti e perda quella oggettività che Frege voleva riservare al<br />
regno del Senso in quanto contrapposto alla rappresentazione oggettiva.<br />
Frege quindi colloca il pensiero in un "terzo regno" (platonismo fregeano):<br />
" i pensieri appartengono ad un regno che non è costituito né da entità fisiche (cose del<br />
mondo esterno) né da entità psichiche (rappresentazioni mentali), ma è un terzo regno, il<br />
regno dei pensieri".<br />
I pensieri hanno validità atemporale. Ad esempio il teorema di Pitagora: se fosse un'entità<br />
psichica ognuno avrebbe il "suo" teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è vero<br />
indipendentemente dal fatto che qualcuno lo comprenda in un modo e altri in un altro.<br />
"accediamo ai pensieri con il processo mentale del comprendere, che è collocato nel tempo e<br />
nello spazio e nella psicologia del parlante, ma la verità dei pensieri non dipende dalla nostra<br />
comprensione". Bisogna scindere il processo mentale del comprendere dal contenuto di ciò<br />
che si comprende. Comprendere è un processo misterioso perché mette in contatto l'azione<br />
psichica soggettiva e una realtà oggettiva (il pensiero atemporale).<br />
Cap. 9 -‐ Significato e uso: il secondo Wittgenstein<br />
Il Tractatus è l'opera giovanile di Wittgenstein, scritto tra il 1914 e il 1918. influenzato dalle<br />
opere di Frege, verso cui nutriva grande ammirazione, Wittgenstein sviluppa una tormentata<br />
critica della sua opera giovanile. In una lettera di commento, Frege gli suggeriva di produrre<br />
più esempi, cosa che Wittgenstein realizzerà nelle "Ricerche Filosofiche", pubblicate postume