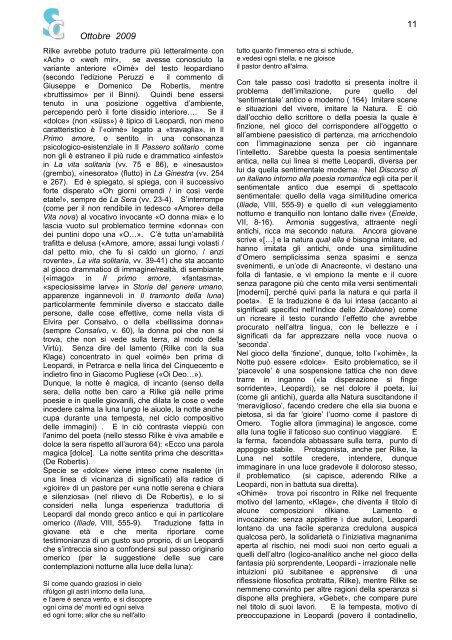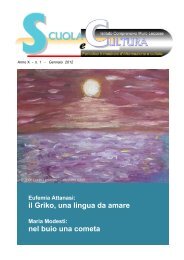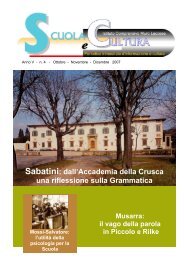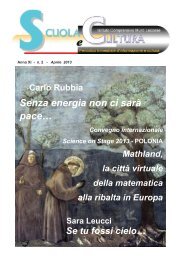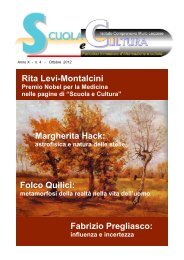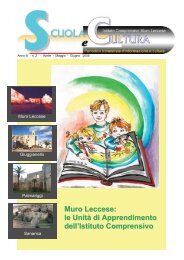Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ottobre</strong> <strong>2009</strong><br />
Rilke avrebbe potuto tradurre più letteralmente con<br />
«Ach» o «weh mir», se avesse conosciuto la<br />
variante anteriore «Oimè» del testo leopardiano<br />
(secondo l’edizione Peruzzi e il commento di<br />
Giuseppe e Domenico De Robertis, mentre<br />
«bruttissimo» per il Binni). Quindi bene essersi<br />
tenuto in una posizione oggettiva d’ambiente,<br />
percependo però il forte dissidio interiore…. Se il<br />
«dolce» (non «süss») è tipico di Leopardi, non meno<br />
caratteristico è l’«oimè» legato a «travaglia», in Il<br />
Primo amore, o sentito in una consonanza<br />
psicologico-esistenziale in Il Passero solitario come<br />
non gli è estraneo il più rude e drammatico «infesto»<br />
in La vita solitaria (vv. 75 e 86), e «inesausto»<br />
(grembo), «inesorato» (flutto) in La Ginestra (vv. 254<br />
e 267). Ed è spiegato, si spiega, con il successivo<br />
forte disperato «Oh giorni orrendi / in così verde<br />
etate!», sempre de La Sera (vv. 23-4). S’interrompe<br />
(come per il non rendibile in tedesco «Amore» della<br />
Vita nova) al vocativo invocante «O donna mia» e lo<br />
lascia vuoto sul problematico termine «donna» con<br />
dei puntini dopo una «O…». C’è tutta un’amabilità<br />
trafitta e delusa («Amore, amore, assai lungi volasti /<br />
dal petto mio, che fu sì caldo un giorno, / anzi<br />
rovente», La vita solitaria, vv. 39-41) che sta accanto<br />
al gioco drammatico di immagine/realtà, di sembiante<br />
(«imago» in Il primo amore, «fantasma»,<br />
«speciosissime larve» in Storia del genere umano,<br />
apparenze ingannevoli in Il tramonto della luna)<br />
particolarmente femminile diverso e staccato dalle<br />
persone, dalle cose effettive, come nella vista di<br />
Elvira per Consalvo, o della «bellissima donna»<br />
(sempre Consalvo, v. 60), la donna poi che non si<br />
trova, che non si vede sulla terra, al modo della<br />
Virtù). Senza dire del lamento (Rilke con la sua<br />
Klage) concentrato in quel «oimè» ben prima di<br />
Leopardi, in Petrarca e nella lirica del Cinquecento e<br />
indietro fino in Giacomo Pugliese («Oi Deo…»).<br />
Dunque, la notte è magica, di incanto (senso della<br />
sera, della notte ben caro a Rilke già nelle prime<br />
poesie e in quelle giovanili, che dilata le cose o vede<br />
incedere calma la luna lungo le aiuole, la notte anche<br />
cupa durante una tempesta, nel ciclo compositivo<br />
delle immagini) . E in ciò contrasta vieppiù con<br />
l'animo del poeta (nello stesso Rilke è viva amabile e<br />
dolce la sera rispetto all’aurora 64): «Ecco una parola<br />
magica [dolce]. La notte sentita prima che descritta»<br />
(De Robertis).<br />
Specie se «dolce» viene inteso come risalente (in<br />
una linea di vicinanza di significati) alla radice di<br />
«gioire» di un pastore per «una notte serena e chiara<br />
e silenziosa» (nel rilievo di De Robertis), e lo si<br />
consideri nella lunga esperienza traduttoria di<br />
Leopardi dal mondo greco antico e qui in particolare<br />
omerico (Iliade, VIII, 555-9). Traduzione fatta in<br />
giovane età e che merita riportare come<br />
testimonianza di un gusto suo proprio, di un Leopardi<br />
che s’intreccia sino a confondersi sul passo originario<br />
omerico (per la suggestione delle sue care<br />
contemplazioni notturne alla luce della luna):<br />
Sì come quando graziosi in cielo<br />
rifùlgon gli astri intorno della luna,<br />
e l'aere è senza vento, e si discopre<br />
ogni cima de' monti ed ogni selva<br />
ed ogni torre; allor che su nell'alto<br />
tutto quanto l'immenso etra si schiude,<br />
e vedesi ogni stella, e ne gioisce<br />
il pastor dentro all'alma.<br />
11<br />
Con tale passo così tradotto si presenta inoltre il<br />
problema dell’imitazione, pure quello del<br />
‘sentimentale’ antico e moderno ( 164) Imitare scene<br />
e situazioni del vivere, imitare la Natura. E ciò<br />
dall’occhio dello scrittore o della poesia la quale è<br />
finzione, nel gioco del corrispondere all’oggetto o<br />
all’ambiene paesistico di partenza, ma arricchendolo<br />
con l’immaginazione senza per ciò ingannare<br />
l’intelletto. Sarebbe questa la poesia sentimentale<br />
antica, nella cui linea si mette Leopardi, diversa per<br />
lui da quella sentimentale moderna. Nel Discorso di<br />
un italiano intorno alla poesia romantica egli cita per il<br />
sentimentale antico due esempi di spettacolo<br />
sentimentale: quello della vaga similitudine omerica<br />
(Iliade, VIII, 555-9) e quello di «un veleggiamento<br />
notturno e tranquillo non lontano dalle rive» (Eneide,<br />
VII, 8-16). Armonia suggestiva, attraente negli<br />
antichi, ricca ma secondo natura. Ancora giovane<br />
scrive «[…] e la natura qual ella è bisogna imitare, ed<br />
hanno imitata gli antichi, onde una similitudine<br />
d’Omero semplicissima senza spasimi e senza<br />
svenimenti, e un’ode di Anacreonte, vi destano una<br />
folla di fantasie, e vi empiono la mente e il cuore<br />
senza paragone più che cento mila versi sentimentali<br />
[moderni], perché quivi parla la natura e qui parla il<br />
poeta». E la traduzione è da lui intesa (accanto ai<br />
significati specifici nell’Indice dello Zibaldone) come<br />
un ricreare il testo curando l’effetto che avrebbe<br />
procurato nell’altra lingua, con le bellezze e i<br />
significati da far apprezzare nella voce nuova o<br />
‘seconda’.<br />
Nel gioco della ‘finzione’, dunque, tolto l’«ohimè», la<br />
Notte può essere «dolce». Esito problematico, se il<br />
‘piacevole’ è una sospensione tattica che non deve<br />
trarre in inganno («la disperazione si finge<br />
sorridente», Leopardi), se nel dolore il poeta, lui<br />
(come gli antichi), guarda alla Natura suscitandone il<br />
‘meraviglioso’, facendo credere che ella sia buona e<br />
pietosa, sì da far ‘gioire’ l’uomo come il pastore di<br />
Omero. Toglie allora (immagina) le angosce, come<br />
alla luna toglie il faticoso suo continuo viaggiare. E<br />
la ferma, facendola abbassare sulla terra, punto di<br />
appoggio stabile. Protagonista, anche per Rilke, la<br />
Luna nel sottile credere, intendere, dunque<br />
immaginare in una luce gradevole il doloroso stesso,<br />
il problematico (si capisce, aderendo Rilke a<br />
Leopardi, non in battuta sua diretta).<br />
«Ohimè» trova poi riscontro in Rilke nel frequente<br />
motivo del lamento, «Klage», che diventa il titolo di<br />
alcune composizioni rilkiane. Lamento e<br />
invocazione: senza appiattire i due autori, Leopardi<br />
lontano da una facile speranza credulona auspica<br />
qualcosa però, la solidarietà o l’iniziativa magnanima<br />
aperta al rischio, nei modi suoi non certo eguali a<br />
quelli dell’altro (logico-analitico anche nel gioco della<br />
fantasia più sorprendente, Leopardi - irrazionale nelle<br />
intuizioni più subitanee e apprensive di una<br />
riflessione filosofica protratta, Rilke), mentre Rilke se<br />
nemmeno convinto per altre ragioni della speranza si<br />
dispone alla preghiera, «Gebet», che compare pure<br />
nel titolo di suoi lavori. E la tempesta, motivo di<br />
preoccupazione in Leopardi (povero il contadinello,