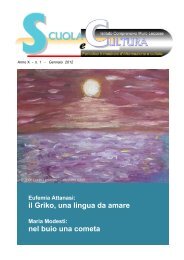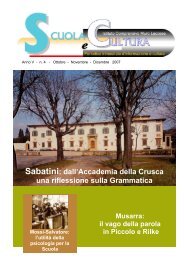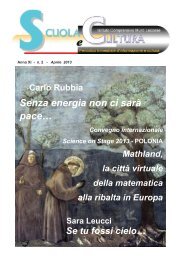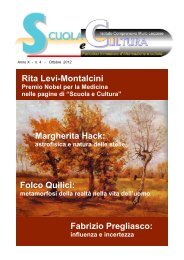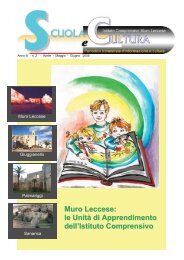Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Ottobre</strong> <strong>2009</strong><br />
La poesia di Pasquale Ciboddo<br />
Nella poesia di Ciboddo è possibile ravvisare<br />
alcune peculiarità salienti che ne fanno un<br />
autore dotato di stile e poetica propri. Già<br />
nell’intervista che precede la raccolta di poesie In<br />
Làcana 1<br />
(Sul confine) – facente parte de La<br />
Biblioteca di Babele, Collana di letteratura sarda<br />
plurilingue, diretta da Nicola Tanda – il poeta<br />
esplicita le motivazioni etiche ed artistiche che<br />
sottostanno alla creazione in versi, quali la<br />
conservazione e la tutela di un patrimonio<br />
linguistico regionale, tramandato spesso in forma<br />
orale, in cui si imprimono e condensano i ‘detti’, le<br />
acquisizioni e le esperienze di civiltà secolari<br />
oramai estinte.<br />
Nelle 51 poesie in gallurese, con traduzione a<br />
fronte, il poeta ‘canta’ e celebra, a guisa di antico<br />
giullare o di rinnovato Omero, le consuetudini,<br />
anche truci, che animarono la vita e le passioni<br />
della remota Gallura al tempo della ‘civiltà degli<br />
stazzi’; luoghi, questi ultimi, che – come ha<br />
acutamente notato Ferruccio Monterosso 2 – lungi<br />
dall’essere un mero recinto all’aperto per la<br />
custodia delle mandrie, costituirono invece i siti in<br />
cui si consumarono vendette, amori devastanti ma<br />
ove si custodì anche la saggezza degli antenati.<br />
E per conseguire tale fine, etico e poetico, Ciboddo<br />
ricorre alla musicalità naturalmente offertagli dalla<br />
lingua ‘madre’ (anche per la ridondanza delle<br />
vocali), corroborando la vena creativa con<br />
assonanze e rime sagacemente giocate.<br />
Emblematica, al proposito, la poesia Festa Manna<br />
(Festa Grande) dove l’incedere della morte scatena<br />
un vento gelido capace di intirizzire i buoi e<br />
illanguidire l’erba: «cu lu pilu drittu, inzuddhunìti /<br />
sudati, intimurìti» (p. 46), («col pelo dritto / sudati e<br />
intimoriti») (p. 47), «Agghju intesu passà, / illu mé<br />
capu arrufatu, / come chissu d’un caldu, / la mòlti,<br />
come un ventu malu. / Era l’òra mala, la malasòlti. /<br />
E disi li parauli fòlti», («Ho sentito passare / nella<br />
mia testa arruffata / come quella di un cardo / la<br />
morte come un vento cattivo. / Era “l’ora mala”, la<br />
malasorte. / E recitai le parole forti») (ibidem). Ora,<br />
se la traduzione inevitabilmente penalizza gli echi<br />
‘responsoriali’ che si generano nel corpo della<br />
parola e del verso, occorre tuttavia rilevare come il<br />
testo ‘a fronte’ non costituisca una traduzione<br />
letterale bensì una versione autonoma, interamente<br />
fruibile, nella sua essenza poetica, in lingua<br />
italiana. Inoltre, la battuta conclusiva «E disi li<br />
parauli fòlti» («E recitai le parole forti») riconduce<br />
all’espressione adoperata nel racconto Antoni<br />
Pizzatu: il volto dell’innocenza, ove il «servo di<br />
Gherra, Chiricu» chiede al vecchio «zio Raimundu»<br />
di recitare tali parole ed egli «[…] si mise a<br />
sussurrare parole incomprensibili». 3 Da una nota<br />
apposta al testo, dallo stesso autore, apprendiamo<br />
che si tratterebbe di una sorta di formula magica<br />
con funzione apotropaica. Nello stesso romanzo<br />
compare inoltre il ricordo della «festa manna» di<br />
Luogosanto quando nel «lontano 1909» la scrittrice<br />
Grazia Deledda «visitò il paese» (pp. 35-36) e non<br />
a caso nella silloge In Làcana è contenuto un<br />
LETTERATURA<br />
Rossella Rossetti<br />
Con una tesi in Letteratura Italiana: La teoria della<br />
conoscenza nel Mestiere di vivere di Cesare Pavese, si è<br />
laureata nella sede cremonese dell’Università di Pavia,<br />
riportando il massimo dei voti, Lode e Dignità di stampa<br />
(relatore: Prof. Ferruccio Monterosso).<br />
Ampi saggi della tesi sono stati pubblicati nelle riviste di<br />
letteratura «Si scrive», «Riscontri» e articoli sullo stesso tema<br />
sono comparsi in «Mondo Padano» e «Nuovo Domani Sud».<br />
Altri lavori concernenti Pavese, autori contemporanei sono in<br />
corso di pubblicazione.<br />
All’attività di ricerca affianca quella didattica negli Istituti<br />
secondari; nutre interessi eclettici e coltiva accanto alla<br />
passione per le lettere quella per la musica, concretizzatasi<br />
nel conseguimento del Diploma di Pianoforte.<br />
omaggio alla stessa (Zia Grazia) (p. 18). Come<br />
pure, nel racconto La verità (appartenente alla<br />
serie Tre racconti di fine Secondo Millennio)<br />
rinveniamo «babbareddhu, cioè zio grande, per i<br />
meriti e la bontà dimostrata» verso «poveri,<br />
accattoni ed amici» (p. 75), la cui figura rievoca,<br />
per i lati più edificanti, Bébbi e Mimméddha (Zio<br />
grande e zia grande) (pp. 60-61) nella poesia<br />
omonima della raccolta In Làcana.<br />
Queste scarne esemplificazioni, benché non<br />
esaurienti della intricata e complessa dinamica<br />
ritratta da Ciboddo, ne mettono comunque in luce<br />
l’ispirazione omogenea e monolitica improntata su<br />
alcuni cardini generatori. Ma soprattutto, in lui,<br />
evidenziano l’accentuata componente poetica e il<br />
dilagare di questa dalla prosa alla poesia (e<br />
viceversa). 4<br />
Similitudini, metafore, metonimie, onomatopee<br />
(adoperate con funzione espressiva e mai<br />
edonistica) vivificano il tessuto immaginifico<br />
creando suggestivi quadri d’insieme,<br />
rappresentativi degli stati d’animo, dei colori, dei<br />
suoni, delle ‘associazioni libere’ (secondo la<br />
psicanalisi di Freud).<br />
Ciboddo, attraverso un inconsueto innesto di<br />
poesia popolare e stilemi tratti dalla tradizione<br />
colta, conduce il lettore in un’aura che non gli<br />
appartiene inducendolo a rivivere emozioni non<br />
sue. Grazie poi al naturale talento poetico e alla<br />
ricercata espressività di stile – nata anche dalla<br />
consuetudine con autori quali Mistral, Verlaine,<br />
Rimbaud, Mallarmé, Dickinson, Garcia Lorca 5 ecc.<br />
– riesce a tracciare variegati e compositi scenari in<br />
cui parola e suono si fondono, in chiuse serrate e<br />
stringenti, fino al parossismo. In Làcana, il confine<br />
tra male e bene si perde, e alle devastazioni che<br />
permeano i destini degli uomini e della natura, la<br />
poesia di Ciboddo sa contrapporre la ferrea legge<br />
della necessità e della rassegnazione. Così<br />
19