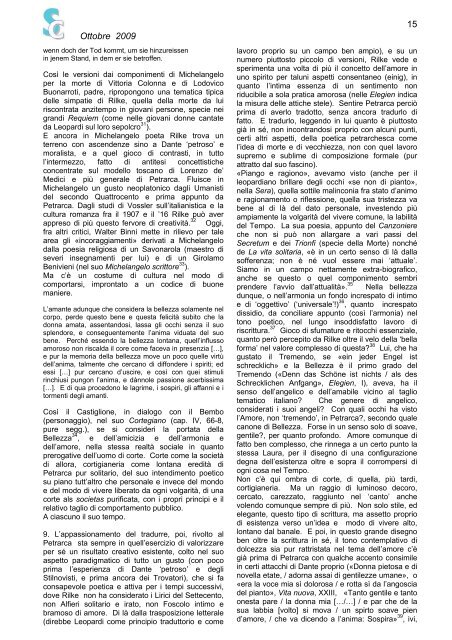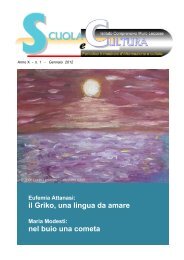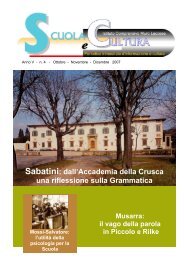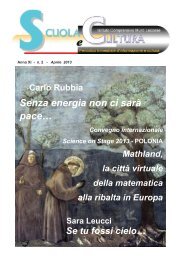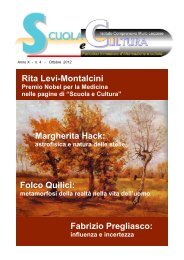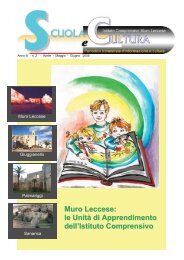Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ottobre</strong> <strong>2009</strong><br />
wenn doch der Tod kommt, um sie hinzureissen<br />
in jenem Stand, in dem er sie betroffen.<br />
Così le versioni dai componimenti di Michelangelo<br />
per la morte di Vittoria Colonna e di Lodovico<br />
Buonarroti, padre, ripropongono una tematica tipica<br />
delle simpatie di Rilke, quella della morte da lui<br />
riscontrata anzitempo in giovani persone, specie nei<br />
grandi Requiem (come nelle giovani donne cantate<br />
da Leopardi sul loro sepolcro 31 ).<br />
E ancora in Michelangelo poeta Rilke trova un<br />
terreno con ascendenze sino a Dante ‘petroso’ e<br />
moralista, e a quel gioco di contrasti, in tutto<br />
l’intermezzo, fatto di antitesi concettistiche<br />
concentrate sul modello toscano di Lorenzo de’<br />
Medici e più generale di Petrarca. Fluisce in<br />
Michelangelo un gusto neoplatonico dagli Umanisti<br />
del secondo Quattrocento e prima appunto da<br />
Petrarca. Dagli studi di Vossler sull’italianistica e la<br />
<strong>cultura</strong> romanza fra il 1907 e il ’16 Rilke può aver<br />
appreso di più questo fervore di creatività. 32 Oggi,<br />
fra altri critici, Walter Binni mette in rilievo per tale<br />
area gli «incoraggiamenti» derivati a Michelangelo<br />
dalla poesia religiosa di un Savonarola (maestro di<br />
severi insegnamenti per lui) e di un Girolamo<br />
Benivieni (nel suo Michelangelo scrittore 33 ).<br />
Ma c’è un costume di <strong>cultura</strong> nel modo di<br />
comportarsi, improntato a un codice di buone<br />
maniere.<br />
L’amante adunque che considera la bellezza solamente nel<br />
corpo, perde questo bene e questa felicità subito che la<br />
donna amata, assentandosi, lassa gli occhi senza il suo<br />
splendore, e conseguentemente l’anima viduata del suo<br />
bene. Perché essendo la bellezza lontana, quell’influsso<br />
amoroso non riscalda il core come faceva in presenzia […],<br />
e pur la memoria della bellezza move un poco quelle virtù<br />
dell’anima, talmente che cercano di diffondere i spiriti; ed<br />
essi […] pur cercano d’uscire, e così con quei stimuli<br />
rinchiusi pungon l’anima, e dànnole passione acerbissima<br />
[…]. E di qua procedono le lagrime, i sospiri, gli affanni e i<br />
tormenti degli amanti.<br />
Così il Castiglione, in dialogo con il Bembo<br />
(personaggio), nel suo Cortegiano (cap. IV, 66-8,<br />
pure segg.), se si consideri la portata della<br />
Bellezza 34 , e dell’amicizia e dell’armonia e<br />
dell’amore, nella stessa realtà sociale in quanto<br />
prerogative dell’uomo di corte. Corte come la società<br />
di allora, cortigianeria come lontana eredità di<br />
Petrarca pur solitario, del suo intendimento poetico<br />
su piano tutt’altro che personale e invece del mondo<br />
e del modo di vivere liberato da ogni volgarità, di una<br />
corte als societas purificata, con i propri principi e il<br />
relativo taglio di comportamento pubblico.<br />
A ciascuno il suo tempo.<br />
9. L’appassionamento del tradurre, poi, rivolto al<br />
Petrarca sta sempre in quell’esercizio di valorizzare<br />
per sé un risultato creativo esistente, colto nel suo<br />
aspetto paradigmatico di tutto un gusto (con poco<br />
prima l’esperienza di Dante ‘petroso’ e degli<br />
Stilnovisti, e prima ancora dei Trovatori), che si fa<br />
consapevole poetica e attiva per i tempi successivi,<br />
dove Rilke non ha considerato i Lirici del Settecento,<br />
non Alfieri solitario e irato, non Foscolo intimo e<br />
bramoso di amore. Di là dalla trasposizione letterale<br />
(direbbe Leopardi come principio traduttorio e come<br />
15<br />
lavoro proprio su un campo ben ampio), e su un<br />
numero piuttosto piccolo di versioni, Rilke vede e<br />
sperimenta una volta di più il concetto dell’amore in<br />
uno spirito per taluni aspetti consentaneo (einig), in<br />
quanto l’intima essenza di un sentimento non<br />
riducibile a sola pratica amorosa (nelle Elegien indica<br />
la misura delle attiche stele). Sentire Petrarca perciò<br />
prima di averlo tradotto, senza ancora tradurlo di<br />
fatto. E tradurlo, leggendo in lui quanto è piuttosto<br />
già in sé, non incontrandosi proprio con alcuni punti,<br />
certi altri aspetti, della poetica petrarchesca come<br />
l’idea di morte e di vecchiezza, non con quel lavoro<br />
supremo e sublime di composizione formale (pur<br />
attratto dal suo fascino).<br />
«Piango e ragiono», avevamo visto (anche per il<br />
leopardiano brillare degli occhi «se non di pianto»,<br />
nella Sera), quella sottile malinconia fra stato d’animo<br />
e ragionamento o riflessione, quella sua tristezza va<br />
bene al di là del dato personale, investendo più<br />
ampiamente la volgarità del vivere comune, la labilità<br />
del Tempo. La sua poesia, appunto del Canzoniere<br />
che non si può non allargare a vari passi del<br />
Secretum e dei Trionfi (specie della Morte) nonché<br />
de La vita solitaria, «è in un certo senso di là dalla<br />
sofferenza; non è né vuol essere mai ‘attuale’.<br />
Siamo in un campo nettamente extra-biografico,<br />
anche se questo o quel componimento sembri<br />
prendere l’avvio dall’attualità». 35 Nella bellezza<br />
dunque, o nell’armonia un fondo increspato di intimo<br />
e di ‘oggettivo’ (‘universale’!) 36 , quanto increspato<br />
dissidio, da conciliare appunto (così l’armonia) nel<br />
tono poetico, nel lungo insoddisfatto lavoro di<br />
riscrittura. 37 Gioco di sfumature e ritocchi essenziale,<br />
quanto però percepito da Rilke oltre il velo della ‘bella<br />
forma’ nel valore complesso di questa? 38 Lui, che ha<br />
gustato il Tremendo, se «ein jeder Engel ist<br />
schrecklich» e la Bellezza è il primo grado del<br />
Tremendo («Denn das Schöne ist nichts / als des<br />
Schrecklichen Anfgang», Elegien, I), aveva, ha il<br />
senso dell’angelico e dell’amabile vicino al taglio<br />
tematico italiano? Che genere di angelico,<br />
considerati i suoi angeli? Con quali occhi ha visto<br />
l’Amore, non ‘tremendo’, in Petrarca?, secondo quale<br />
canone di Bellezza. Forse in un senso solo di soave,<br />
gentile?, per quanto profondo. Amore comunque di<br />
fatto ben complesso, che rinnega a un certo punto la<br />
stessa Laura, per il disegno di una configurazione<br />
degna dell’esistenza oltre e sopra il corrompersi di<br />
ogni cosa nel Tempo.<br />
Non c’è qui ombra di corte, di quella, più tardi,<br />
cortigianeria. Ma un raggio di luminoso decoro,<br />
cercato, carezzato, raggiunto nel ‘canto’ anche<br />
volendo comunque sempre di più. Non solo stile, ed<br />
elegante, questo tipo di scrittura, ma assetto proprio<br />
di esistenza verso un’idea e modo di vivere alto,<br />
lontano dal banale. E poi, in questo grande disegno<br />
ben oltre la scrittura in sé, il tono contemplativo di<br />
dolcezza sia pur rattristata nel tema dell’amore c’è<br />
già prima di Petrarca con qualche accento consimile<br />
in certi attacchi di Dante proprio («Donna pietosa e di<br />
novella etate, / adorna assai di gentilezze umane», o<br />
«era la voce mia sì dolorosa / e rotta sì da l’angoscia<br />
del pianto», Vita nuova, XXIII, «Tanto gentile e tanto<br />
onesta pare / la donna mia […/…] / e par che de la<br />
sua labbia [volto] si mova / un spirto soave pien<br />
d’amore, / che va dicendo a l’anima: Sospira» 39 , ivi,