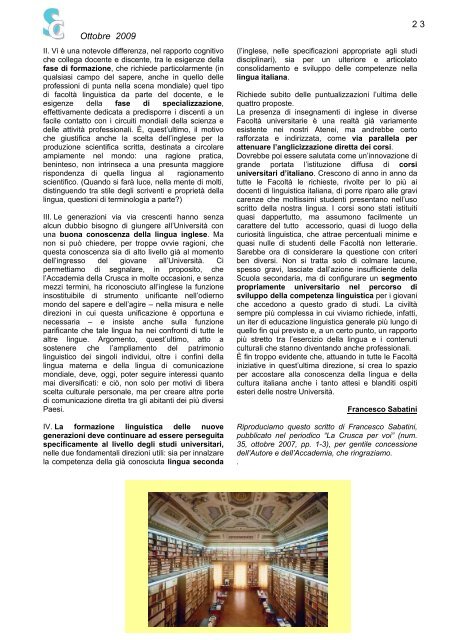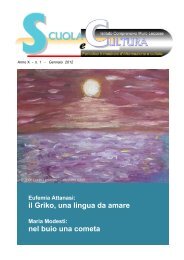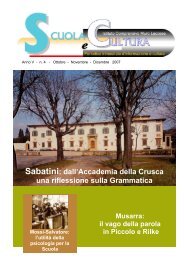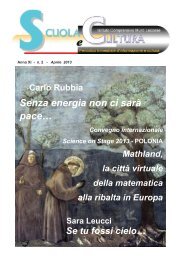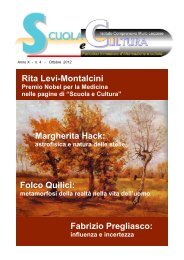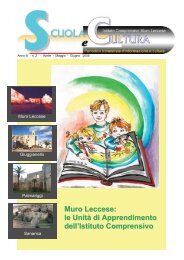Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Scuola e Cultura - Ottobre 2009 - scuola e cultura - rivista
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ottobre</strong> <strong>2009</strong><br />
II. Vi è una notevole differenza, nel rapporto cognitivo<br />
che collega docente e discente, tra le esigenze della<br />
fase di formazione, che richiede particolarmente (in<br />
qualsiasi campo del sapere, anche in quello delle<br />
professioni di punta nella scena mondiale) quel tipo<br />
di facoltà linguistica da parte del docente, e le<br />
esigenze della fase di specializzazione,<br />
effettivamente dedicata a predisporre i discenti a un<br />
facile contatto con i circuiti mondiali della scienza e<br />
delle attività professionali. È, quest’ultimo, il motivo<br />
che giustifica anche la scelta dell’inglese per la<br />
produzione scientifica scritta, destinata a circolare<br />
ampiamente nel mondo: una ragione pratica,<br />
beninteso, non intrinseca a una presunta maggiore<br />
rispondenza di quella lingua al ragionamento<br />
scientifico. (Quando si farà luce, nella mente di molti,<br />
distinguendo tra stile degli scriventi e proprietà della<br />
lingua, questioni di terminologia a parte?)<br />
III. Le generazioni via via crescenti hanno senza<br />
alcun dubbio bisogno di giungere all’Università con<br />
una buona conoscenza della lingua inglese. Ma<br />
non si può chiedere, per troppe ovvie ragioni, che<br />
questa conoscenza sia di alto livello già al momento<br />
dell’ingresso del giovane all’Università. Ci<br />
permettiamo di segnalare, in proposito, che<br />
l’Accademia della Crusca in molte occasioni, e senza<br />
mezzi termini, ha riconosciuto all’inglese la funzione<br />
insostituibile di strumento unificante nell’odierno<br />
mondo del sapere e dell’agire – nella misura e nelle<br />
direzioni in cui questa unificazione è opportuna e<br />
necessaria – e insiste anche sulla funzione<br />
parificante che tale lingua ha nei confronti di tutte le<br />
altre lingue. Argomento, quest’ultimo, atto a<br />
sostenere che l’ampliamento del patrimonio<br />
linguistico dei singoli individui, oltre i confini della<br />
lingua materna e della lingua di comunicazione<br />
mondiale, deve, oggi, poter seguire interessi quanto<br />
mai diversificati: e ciò, non solo per motivi di libera<br />
scelta <strong>cultura</strong>le personale, ma per creare altre porte<br />
di comunicazione diretta tra gli abitanti dei più diversi<br />
Paesi.<br />
IV. La formazione linguistica delle nuove<br />
generazioni deve continuare ad essere perseguita<br />
specificamente al livello degli studi universitari,<br />
nelle due fondamentali direzioni utili: sia per innalzare<br />
la competenza della già conosciuta lingua seconda<br />
(l’inglese, nelle specificazioni appropriate agli studi<br />
disciplinari), sia per un ulteriore e articolato<br />
consolidamento e sviluppo delle competenze nella<br />
lingua italiana.<br />
Richiede subito delle puntualizzazioni l’ultima delle<br />
quattro proposte.<br />
La presenza di insegnamenti di inglese in diverse<br />
Facoltà universitarie è una realtà già variamente<br />
esistente nei nostri Atenei, ma andrebbe certo<br />
rafforzata e indirizzata, come via parallela per<br />
attenuare l’anglicizzazione diretta dei corsi.<br />
Dovrebbe poi essere salutata come un’innovazione di<br />
grande portata l’istituzione diffusa di corsi<br />
universitari d’italiano. Crescono di anno in anno da<br />
tutte le Facoltà le richieste, rivolte per lo più ai<br />
docenti di linguistica italiana, di porre riparo alle gravi<br />
carenze che moltissimi studenti presentano nell’uso<br />
scritto della nostra lingua. I corsi sono stati istituiti<br />
quasi dappertutto, ma assumono facilmente un<br />
carattere del tutto accessorio, quasi di luogo della<br />
curiosità linguistica, che attrae percentuali minime e<br />
quasi nulle di studenti delle Facoltà non letterarie.<br />
Sarebbe ora di considerare la questione con criteri<br />
ben diversi. Non si tratta solo di colmare lacune,<br />
spesso gravi, lasciate dall’azione insufficiente della<br />
<strong>Scuola</strong> secondaria, ma di configurare un segmento<br />
propriamente universitario nel percorso di<br />
sviluppo della competenza linguistica per i giovani<br />
che accedono a questo grado di studi. La civiltà<br />
sempre più complessa in cui viviamo richiede, infatti,<br />
un iter di educazione linguistica generale più lungo di<br />
quello fin qui previsto e, a un certo punto, un rapporto<br />
più stretto tra l’esercizio della lingua e i contenuti<br />
<strong>cultura</strong>li che stanno diventando anche professionali.<br />
È fin troppo evidente che, attuando in tutte le Facoltà<br />
iniziative in quest’ultima direzione, si crea lo spazio<br />
per accostare alla conoscenza della lingua e della<br />
<strong>cultura</strong> italiana anche i tanto attesi e blanditi ospiti<br />
esteri delle nostre Università.<br />
Francesco Sabatini<br />
Riproduciamo questo scritto di Francesco Sabatini,<br />
pubblicato nel periodico “La Crusca per voi” (num.<br />
35, ottobre 2007, pp. 1-3), per gentile concessione<br />
dell’Autore e dell’Accademia, che ringraziamo.<br />
.<br />
23