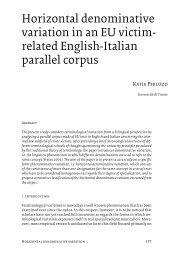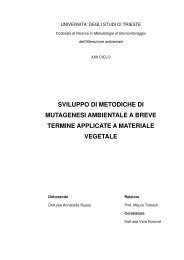S A F F O - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
S A F F O - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
S A F F O - OpenstarTs - Università degli Studi di Trieste
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6<br />
<strong>di</strong>vinità o <strong>degli</strong> eroi atavici. Naturalmente gli assetti socio-politici erano concepiti immutabili; pertanto<br />
eventuali innovazioni o cambiamenti erano accettati soltanto se fossero presentati come un aggiustamento<br />
necessario, un ritorno o una restaurazione della con<strong>di</strong>zione originaria, che si era deteriorata a causa<br />
dell'improvvida azione <strong>degli</strong> uomini. In ogni caso il mantenimento della stabilità e l'immutabilità erano<br />
sempre considerati in<strong>di</strong>spensabili per proteggere la comunità dal deterioramento o dalla <strong>di</strong>struzione.<br />
Inoltre per la conservazione dell'identità sociale era in<strong>di</strong>spensabile presupposto la consapevolezza che il<br />
fluire del tempo non potesse incidere in alcun modo sull'esistente.<br />
In quell'ambito socio-culturale immerso nella tra<strong>di</strong>zione aveva una funzione precisa il dono <strong>di</strong>vino<br />
della memoria. Le uniche figure sociali a possederla erano l'indovino e il poeta, i quali intrattenevano un<br />
rapporto privilegiato con le Muse, figlie <strong>di</strong> Memoria e <strong>di</strong> Zeus. Grazie a questo legame con le <strong>di</strong>vinità<br />
onniscienti, che rivelavano loro la storia sacra (tutte le vicende del passato, del presente e del futuro) e li<br />
rendevano pertanto maestri <strong>di</strong> verità, essi erano gli effettivi garanti e depositari del sapere comunitario.<br />
Quel sapere rivelato, però, aveva bisogno <strong>di</strong> essere conservato religiosamente nella memoria, perché<br />
tutti quanti potessero riconoscere in esso il senso dell'identità sociale della comunità, che era il<br />
presupposto per il mantenimento e la riproduzione dei suoi fondamenti culturali. E tale funzione era<br />
assolta sia dal rito sia dal mito.<br />
Il rito si realizzava in una sequenza fissa <strong>di</strong> atti <strong>di</strong>mostrativi da eseguire in un tempo determinato e in<br />
un luogo prestabilito. Gli atti erano compiuti in modo formale per assicurare stabilità al gruppo e una loro<br />
cattiva esecuzione comportava la violazione del sacro e <strong>di</strong> conseguenza provocava la sanzione <strong>di</strong>vina. Il<br />
mito, invece, consisteva nell'enunciazione <strong>di</strong> un racconto, che dava origine e fondamento a una<br />
determinata realtà rilevante per l'intero gruppo sociale ed era accettato come vero in quanto era ripetuto<br />
incessantemente alla comunità durante le pratiche dei culti. A tale scopo, mito e rito si avvalevano del<br />
canto, cioè <strong>di</strong> un linguaggio <strong>di</strong>stinto da quello impiegato nelle quoti<strong>di</strong>ane relazioni interpersonali.<br />
In pari tempo la comunicazione, rigorosamente aurale, garantiva la vitalità del sistema attraverso un<br />
continuo aggiornamento e un imme<strong>di</strong>ato adeguamento alle novità che si presentassero: lo stesso statuto<br />
della comunicazione orale consentiva <strong>di</strong> cancellare per sempre dalla memoria tutto quello che non fosse<br />
più funzionale oppure <strong>di</strong>ssonante con le esigenze dell'attualità, cosicché il messaggio, pur mo<strong>di</strong>ficandosi<br />
<strong>di</strong> continuo per adeguarsi alle attese dell'u<strong>di</strong>torio, era percepito come immutato e quin<strong>di</strong> riconosciuto<br />
come vero.<br />
5. Le occasioni della comunicazione poetica<br />
Nell'isola <strong>di</strong> Lesbo, come nelle restanti parti della Grecia arcaica, la vita sociale era scan<strong>di</strong>ta da<br />
manifestazioni religiose pubbliche, le cosiddette feste perio<strong>di</strong>che, che seguivano un preciso calendario.<br />
Durante queste solennità i citta<strong>di</strong>ni celebravano il comune passato, le <strong>di</strong>vinità protettrici o gli eroi<br />
ancestrali. Nelle specifiche circostanze erano ricordate con un componimento poetico l'impresa<br />
memorabile fondante la festa o l'occasione in cui la comunità si trovava riunita (l'aition, il racconto mitico<br />
eziologico). Nel corso dell'esecuzione, accompagnata il più delle volte da ritmi melo<strong>di</strong>e e danze, insieme<br />
alla vicenda mitica il poeta faceva conoscere i para<strong>di</strong>gmi appropriati, desumendo da essi i valori eticosociali<br />
e i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> comportamento, che l'u<strong>di</strong>torio accettava e con<strong>di</strong>videva.<br />
Accanto alla molteplicità delle cerimonie ufficiali, esistevano altre occasioni saltuarie, che regolavano<br />
i rapporti dei singoli con la comunità (nascite, matrimoni, anniversari, funerali) o che coinvolgevano<br />
gruppi selezionati <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni (le eterie), i quali si incontravano durante i simposi, dove affermavano i loro<br />
ideali etici e politici, godendo misuratamente dei piaceri del vino, dell'eros e del canto (vd. Sol. fr. 24<br />
PETFr; Anacr. fr. 56 Gent.). Anche queste ricorrenze private erano caratterizzate da precisi atti rituali,<br />
che ne sancivano la correttezza formale e la conformità con la tra<strong>di</strong>zione.<br />
Nelle celebrazioni pubbliche il ruolo dominante era detenuto dalla lirica sacra cerimoniale, eseguita da<br />
un gruppo corale, e dalle recitazioni rapso<strong>di</strong>che. Nelle occasioni non ufficiali prevalevano altre forme<br />
liriche, solitamente affidate agli assolo <strong>degli</strong> esecutori.<br />
Il legame della produzione poetica con l'attività e le necessità sociali della popolazione era realizzato dal<br />
gra<strong>di</strong>mento che essa suscitava nei destinatari: la comunicazione culturale, infatti, era concepita<br />
esclusivamente come evento collettivo che si attuava grazie all'apprezzamento e all'attiva partecipazione<br />
<strong>degli</strong> ascoltatori.<br />
Anche il ruolo <strong>di</strong> Saffo, nei momenti in cui si presentava come poeta <strong>di</strong> fronte al proprio u<strong>di</strong>torio,<br />
consisteva nel cantare eventi esemplari mitici, attinti dalla tra<strong>di</strong>zione panellenica o locale, adeguandoli al<br />
momento presente, e nel rappresentare l'attualità con i tratti solenni dell'antica storia sacra. Così nel canto