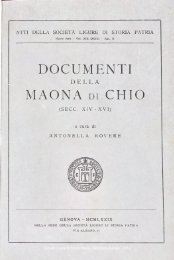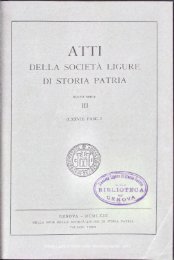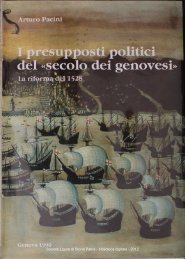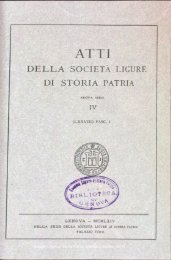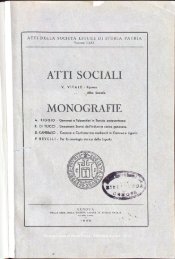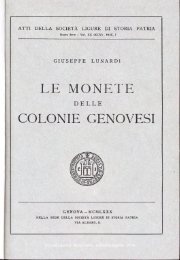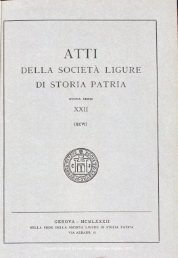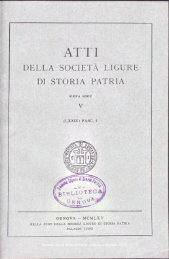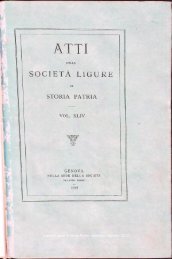DELLA SOCIETÃ LIGURE DI STORIA PATRIA
DELLA SOCIETÃ LIGURE DI STORIA PATRIA
DELLA SOCIETÃ LIGURE DI STORIA PATRIA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tracce di correzioni esistono, infine, anche negli atti stesi dallo stesso<br />
Antonio. Come tutti gli altri notai egli trattava il suo libro come una<br />
minuta di lavoro, che doveva servire di base per la redazione seguente<br />
dell’atto originale (instrumentum). Osserviamo soltanto un particolare<br />
curioso, che non incontriamo nei cartulari di altri notai: Antonio non<br />
riteneva necessario fare le sue registrazioni in seguito, riempiendo gradualmente<br />
le pagine del cartulare, ma le faceva dove gli capitava, perciò,<br />
sotto il profilo cronologico, i suoi atti sono disposti molto confusamente.<br />
Ciò, tuttavia, non significa che Bonizi non osservasse le regole stabilite<br />
per la tenuta dei cartulari notarili.<br />
L’elaborazione e la redazione dell’atto notarile era un fatto comp es<br />
so, che constava di almeno tre momenti: inizialmente, secondo la richie<br />
sta del cliente, il notaio buttava giù lo schema della minuta, riassumendo<br />
l’essenza del contratto e senza preoccuparsi delle formule e delle abbre<br />
viazioni. Questo abbozzo di minuta, chiamato in diplomatica carta non<br />
firmata o scriptum, si faceva solitamente su frammenti di pergamena o<br />
di carta; da ciò deriva il nome italiano di scheda, cioè foglietto . Di t<br />
abbozzi a noi non ne sono giunti molti, poiché, per il loro stesso carattere,<br />
non erano destinati ad una durevole conservazione. In seguito, quan<br />
tutti i dettagli dell’affare erano concordati con le parti interessate, il no<br />
taio inseriva l’atto in un libro speciale39, nel quale la registrazione era<br />
fatta brevemente, ma già in osservanza delle regole stabilite per mezzo i<br />
particolari statuti40. L’atto inserito nel cartulare doveva comprendere<br />
la data, le esatte clausole del contratto, l’enumerazione di tutti 1 testi<br />
moni; le formule potevano essere abbreviate soltanto fino ad un certo<br />
limite e nelle registrazioni dei testamenti generalmente non era ammessa<br />
l’abbreviazione delle formule: l’atto doveva essere letto per esteso, il che,<br />
naturalmente, limitava il notaio nell’impiego delle abbreviazioni. Sulla<br />
base della registrazione fatta nel cartulare il notaio stendeva, infine, il<br />
38 Cfr. A. G audenzi, Redazione del documento italiano nel medioevo, in Archivio<br />
Storico Italiano, 1908, t. 41, serie V; D . H erlihy, Pisa in thè early Renaissance,<br />
New York, 1958, p. 13.<br />
39 In italiano la denominazione consueta è Liber imbreviaturarum o Liber<br />
protocollorum.<br />
40 Sulle regole e sulla pratica della tenuta dei libri di imbreviature a Cremona<br />
cfr. l’interessante studio di E.C. Skrzinskaia nel libro: « Akty Kremony XIU-XIV<br />
w . » (Atti di Cremona nei secoli XIII e XIV), Mosca-Leningrado, 1961, pp. 30-37.<br />
— 126 —<br />
Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012