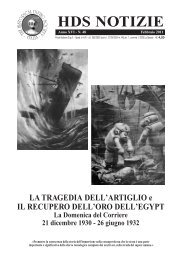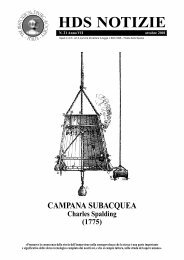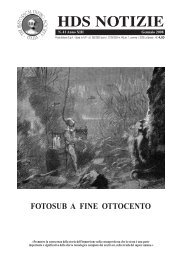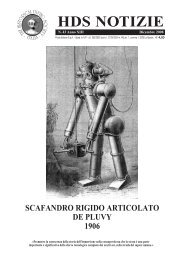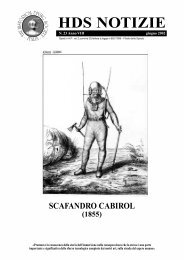INDICI 1994 ~ 2005 - The Historical Diving Society Italia
INDICI 1994 ~ 2005 - The Historical Diving Society Italia
INDICI 1994 ~ 2005 - The Historical Diving Society Italia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il palombaro italiano Antonio Olanda con José Ayub. (foto) p. 8.<br />
Il palombaro libanese José Ayub. (foto) p. 8.<br />
Ayub su uno dei blocchi di cemento utilizzato per la diga. (foto) p. 9.<br />
Immagine senza data che mostra i frangiflutti. (cartolina) p. 10.<br />
328. DOMENICO MACALUSO, Un vascello armato genovese nel mare agrigentino. Quando evidenza archeologica<br />
e ricerca in archivio consentono di fare la Storia. n. 31, p. 11 - 15<br />
Durante la dominazione romana e bizantina Scilla è nella regione che produce più grano. Vengono realizzate enormi fosse granarie in prossimità<br />
dell’approdo come contenitori che consentono un agevole imbarco: sono obiettivi privilegiati per le incursioni barbaresche che comportano<br />
ingenti spese per fortificare la città. Le incursioni continuano per secoli: l’ultima è del 6 settembre 1818.<br />
Il club “Ippocampus” segnala, nel 1992, la presenza di due cannoni e, nel 1996, ne scoprono altri due di pregevoli fusioni bronzee con uno stemma<br />
che li fa risalire al re francese François I. La ricerca in archivio porta al ritrovamento di una carta del 1575 dalla quale si rileva un naufragio e<br />
il recupero di pezzi di artiglieria. Si tratta della nave “Santa Maria del Bissone” e la presenza di pezzi di artiglieria francese a bordo di una nave<br />
commerciale genovese viene spiegata con la cronaca che i cannoni francesi erano considerati preda bellica alla cacciata dei francesi da Genova<br />
nel 1528. I cannoni recuperati sono stati restaurati e torneranno presto nella città di Sciacca.<br />
illustrazioni:<br />
Veduta delle fortificazioni di Sciacca nel ‘700. (incisione) p. 11.<br />
Sinan Pashà. (incisione) p. 12.<br />
Ritrovamento del cannone con l’affusto tortile. (foto) p. 13.<br />
Il documento del 1575 dove appare il nome della nave “Santa Maria del Bissone”. (foto) p. 14.<br />
Cappuccio di Palombaro da Vegezio. (disegno) p. 15.<br />
Recupero di artiglieria. Uffano, 1614. (disegno) p. 15.<br />
329. FRANCESCA GIACCHÉ, Normandia: i palombari italiani dello sbarco. n. 31, p. 16 - 20<br />
Lo sbarco in Normandia è stata una delle più grandi operazioni belliche della storia: oltre all’impiego di circa 6.000 navi e imbarcazioni di vario<br />
tipo, ha richiesto la costruzione a tempo di record di porti artificiali per consentire lo sbarco di truppe e armamenti garantendo i successivi<br />
e indispensabili rifornimenti. Per le costruzioni delle barriere frangiflutti viene utilizzata una quantità enorme di calcestruzzo e molte navi<br />
vengono autoaffondate in bassi fondali in modo che emergesse solo il ponte superiore. Una quantità immensa di materiali che è stata oggetto,<br />
verso l’inizio degli anni ‘50, di una corrispondente grande organizzazione di recuperi condotta da palombari specializzati in grado di condurre<br />
operazioni ad alto rischio, all’inizio da parte di imprese francesi e olandesi e, successivamente, supportate da palombari italiani apprezzati per<br />
le capacità tecniche.<br />
In un ‘box’ si dà notizia della “spedizione D-day” del gruppo subacqueo dell’Ippocampus Club che, nonostante le difficoltà, ha potuto produrre<br />
il documentario girando una intervista con il palombaro Luciano Ambrogini (di cui segue una attenta biografia) che aveva partecipato alle<br />
operazioni di recupero e filmando quattro relitti.<br />
illustrazioni:<br />
Veduta del porto “Mulberry”. (foto) p. 16.<br />
Un carro armato recuperato dai fondali di Omaha Beach. (foto) p. 17.<br />
Omaha Beach vista da dove sorge ora il cimitero americano. (foto) p. 18.<br />
Un gruppo di sub dell’Ippocampus sulla spiaggia di Arromanches. (foto) p. 19.<br />
L’esplosione dell’Iddlesleight. (foto) p. 20.<br />
Luciano Ambrogini a Omaha Beach. (foto) p. 20.<br />
330. PHILIPPE ROUSSEAU, Maurice Fernez - Dallo scafandro da palombaro al sommozzatore con narghilè<br />
e con autorespiratore. Traduzione dal francese e integrazioni di F. Rambelli n. 31, p. 21 - 27<br />
Testimonia la transizione dall’immersione con lo scafandro della fine dell’Ottocento all’immersione autonoma. Fernez, dal 1905, studia un apparecchio<br />
che permetta di restare sott’acqua alcuni minuti e, dopo vari tentativi realizza un sistema di collegamento alla superficie con un tubo<br />
tramite il quale l’aria viene condotta al subacqueo per mezzo di una pompa da automobili. Nel 1912, in una immersione di prova, resta sott’acqua<br />
per 58 minuti. Fernez crea una società e inizia la produzione in serie dell’apparecchio ottenendo il 1° Gran premio dei piccoli inventori e<br />
fabbricanti. Alla fine della prima guerra mondiale produce un nuovo apparecchio che consente immersioni più profonde grazie a una pompa a<br />
pistoni per la mandata d’aria e, successivamente, dal terzo modello con pompa più efficiente, sistemi filtranti e la possibilità di inalare ossigeno.<br />
Yves Le Prieur, nel 1925, rimane impressionato dalle dimostrazioni pratiche di immersione e di taglio subacqueo con la fiamma ossidrica ma<br />
critica il collegamento con la superficie. Nel 1926 nasce l’apparecchio “Fernez-Le Prieur”: l’antesignano dell’Ara.<br />
Seguono note e bibliografia.<br />
illustrazioni:<br />
Maurice Fernez. (foto) p. 21, n. 1.<br />
Un sommozzatore equipaggiato con l’apparecchio di Fernez. (foto) p. 22, n. 2.<br />
L’apparecchio alimentato dalla pompa da automobili. (foto) p. 22, n. 3.<br />
Particolare del boccaglio Fernez. (foto) p. 23, n. 4.<br />
Fernez si appresta all’immersione di prova nel 1912. (foto) p. 23, n. 5 .<br />
L’apparecchio “Fernez 1” completo della cassetta con accessori. p. 24, n. 6.<br />
Il “Fernez 2” la pompa sostituita da una doppia a brandeggio. (foto) p. 24, n. 7.<br />
Pescatore di spugne attrezzato con il “Fernez 2”. (foto) p. 25, n. 8.<br />
L’apparecchio “Fernez-Le Prieur” del 1926. (disegno) p. 26, n. 9.<br />
331. Attività HDSI. IX convegno nazionale sulla storia dell’immersione: “Attività subacquea e archeologia:<br />
storia ed evoluzione”. 26 settembre 2004 - Fortezza del mare - Isola Palmaria, Comune<br />
di Portovenere. n. 31, p. 27<br />
Il programma del convegno con le relazioni di Federico de Strobel, Gian Piero Martino, Claudio Moccheggiani Carpano, Folco Quilici, Lamberto<br />
Ferri Ricchi, Luigi Grisoli, Orlando Pandolfi. La premiazione del concorso “Un film per un museo” e dimostrazione in mare dei palombari<br />
alla calata di Portovenere.<br />
332. GIANLUCA MINGUZZI - DOMENICO PIRO, Notizie e comunicati. n. 31, p. 28 - 32<br />
1 - Operazione fondali puliti.<br />
2 - “Volevo fare il palombaro …” il mio stage con l’HDS, <strong>Italia</strong>.<br />
~ 52 ~