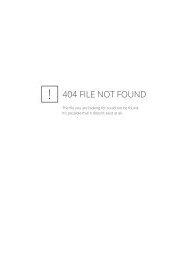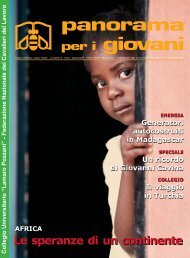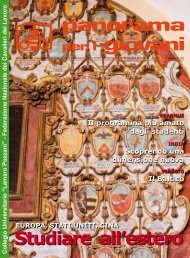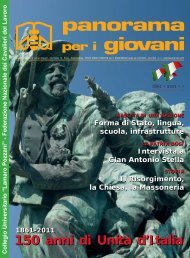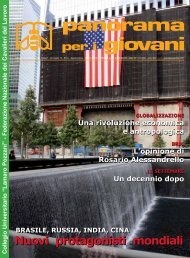numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
abita nella oikìa, nella casa, è il servo domestico.<br />
Doùlos, infi ne, è termine generico<br />
per indicare lo schiavo, attestato trasversalmente<br />
in tutti i contesti letterari e dunque,<br />
ne possiamo dedurre, in molteplici contesti<br />
sociali. Interessante per comprendere la<br />
questione, per entrare in sintonia con una<br />
forma mentis indiscutibilmente tanto lontano<br />
dalla nostra, è notare come la douleia<br />
sia qualcosa di ben più ampio e, parimenti,<br />
altrettanto aborrito dalla mentalità greca. Il<br />
doùlos non è solo lo schiavo in senso stretto<br />
ma anche chi non è libero in un’accezione<br />
più ampia e metaforica, fortemente concettualizzata:<br />
si pensi che uno dei motivi per<br />
cui i greci guardano sprezzanti i “barbari”<br />
persiani all’epoca delle guerre contro Serse<br />
(ne troviamo una formulazione lucida nel<br />
libro VII delle Storie di Erodoto) è proprio<br />
perché nei confronti del Gran Re tutti i<br />
sudditi (e gli stessi ministri) sono sottoposti,<br />
sono per l’appunto dei doùloi.<br />
“E certamente la summa divisio nel<br />
diritto delle persone è questa, che tutti gli<br />
uomini o sono liberi o sono schiavi”. Così<br />
Gaio, giurista romano del II secolo d.C. le<br />
cui Institutiones sono l’unica opera della<br />
giurisprudenza romana classica a esserci<br />
direttamente pervenuta, poneva la principale<br />
distinzione che poteva intercorrere<br />
tra gli individui di fronte all’ordinamento<br />
giuridico. E la Fortuna doveva impegnarsi<br />
affi nché dalla nascita si potesse godere<br />
dello status libertatis e non si fi nisse a<br />
rinforzare la massa di schiavi che, secondo<br />
alcuni storici, arrivava a rappresentare<br />
addirittura il 30% della popolazione<br />
dell’Impero nel I secolo d.C. Sempre<br />
meglio che a Sparta, dove, racconta Erodoto,<br />
la proporzione tra gli iloti, termine<br />
con cui si indicavano gli schiavi, e i liberi<br />
cittadini era di sette a uno! Il fenomeno<br />
schiavistico pervade ogni ambito della<br />
socialità antica, dall’economia al diritto,<br />
ma a Roma assume peculiarità specifi che.<br />
Qui si può, infatti, parlare di “reifi cazione<br />
imperfetta”, in quanto l’assimilazione<br />
dello schiavo a una res non è completa<br />
e subisce <strong>numero</strong>se deroghe. Tali specifi -<br />
cità tenderanno peraltro ad aumentare nel<br />
momento in cui agli schiavi, divenuti perno<br />
dell’economia romana, andrà assicurata<br />
una sempre maggiore tutela giuridica,<br />
non bastando più ricomprenderli tra le res<br />
mancipi, i beni giuridici cui lo ius civile<br />
riconosceva un particolare valore e la cui<br />
proprietà poteva quindi essere trasferita<br />
solo tramite mancipatio, un negozio giuri-<br />
dico contornato da particolari formalità. Il<br />
servo a Roma, ricompreso tra le personae,<br />
era in grado di compiere atti produttivi di<br />
effetti giuridici, tanto da poter parlare di<br />
una “soggettività commerciale” riconosciuta<br />
agli schiavi. Questi, ad esempio, potevano<br />
ottenere dal padrone l’assegnazione<br />
di un piccolo patrimonio (peculium),<br />
cui conseguiva l’obbligo di rispondere,<br />
entro i limiti dell’assegnazione, dei debiti<br />
che il servo avesse contratto nei confronti<br />
di terzi; essi potevano avere rapporti di debito<br />
e credito verso terzi, che davano luogo<br />
a obbligazioni naturali, e pure rapporti<br />
di debito nei confronti del dominus, per il<br />
quale erano peraltro legittimati a compiere<br />
validamente atti di acquisto di cose, diritti<br />
reali e crediti. L’impossibilità di una sussunzione<br />
dello schiavo sotto il concetto di<br />
cosa è resa ancora più evidente dall’essere<br />
questi destinatario di norme penali, cioè<br />
capace di compiere delitti pubblici.<br />
È nel negozio della manumissio, at-<br />
traverso le cui<br />
varie forme era<br />
garantita la possibilità<br />
per i servi<br />
di acquisire la libertà,<br />
che emerge<br />
prepotentemente<br />
la distanza della disciplina schiavile romana<br />
rispetto a quella che ritroviamo nelle<br />
città greche. Se Aristotele inchiodava lo<br />
schiavo nel “paradigma naturalistico della<br />
schiavitù-merce”, a Roma, per quanto non<br />
si arrivi mai a elaborare una teorica dei diritti<br />
umani, non mancano voci di denuncia<br />
La Guerra di Secessione<br />
Sopra: la Grecia, culla della democrazia<br />
antica, non fu molto tenera con gli schiavi<br />
(nella foto l’acropoli di Atene); ad alcuni<br />
di essi vennero garantiti maggiori diritti in<br />
epoca romana (nella pagina precedente:<br />
una stampa ottocentesca rappresenta una<br />
matrona romana e le sue servitrici). Nella<br />
pagina seguente: una statua di Cicerone.<br />
della contrarietà della schiavitù allo ius<br />
naturale. Tale diversità di approccio si riverbera<br />
nelle conseguenze delle manumissiones,<br />
che non solo consentivano l’acquisto<br />
dello status libertatis, ma anche dello<br />
status civitatis, sicché uno schiavo manomesso<br />
si poteva veder attribuita la cittadinanza<br />
romana, con tutti i privilegi del<br />
caso. Nulla di simile si ritrova nel mondo<br />
greco, dove la separazione tra schiavi e<br />
cittadini rimane netta e incolmabile.<br />
Le cause tipiche della schiavitù, oltre<br />
all’ipotesi di essere nato da una schiava,<br />
erano rappresentate dalla sconfi tta militare<br />
– i prigionieri di guerra, divenuti pro-<br />
Sia in Grecia che a Roma non<br />
c’erano radicali opposizioni alla<br />
schiavitù. Essa era considerata<br />
economicamente indispensabile.<br />
prietà dello Stato, venivano venduti al miglior<br />
offerente – e dall’indebitamento, che<br />
faceva del debitore una proprietà del creditore,<br />
il quale poteva decidere di venderlo<br />
nei mercati trans Tiberim, decretandone<br />
il passaggio alla condizione di schiavo.<br />
Vi era inoltre un certo collegamento con<br />
panorama per i giovani • 31