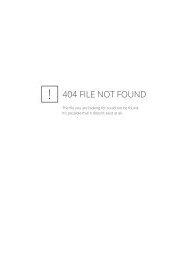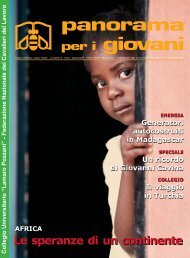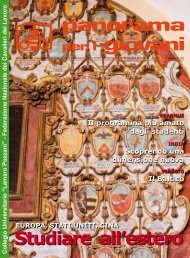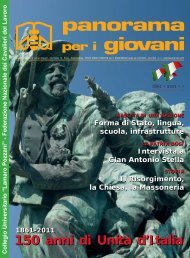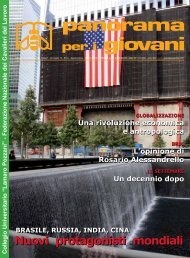numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
numero 1/2011 - Collegio Universitario Lamaro Pozzani
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Alcune incongruità<br />
della schiavitù<br />
Slavery presents some “economic” pitfalls. Maybe, one of the most important<br />
reasons why slavery came to an end was because it was no longer convenient...<br />
di Giuseppe Grazioso<br />
Il fenomeno della schiavitù, fi n dagli albori<br />
delle civiltà più antiche, assunse dimensioni<br />
estremamente rilevanti. Si pensi che,<br />
secondo alcune stime, nelle polis greche<br />
la forza lavoro costituita da schiavi era di<br />
molto maggiore rispetto a quella fornita<br />
da lavoratori liberi. La quasi totalità delle<br />
economie, dalle più primitive fi no a quelle<br />
presenti pochi secoli fa, si basavano largamente<br />
sulla forza lavoro degli schiavi.<br />
Già il codice di Hammurabi prevedeva la<br />
possibilità di esercitare il dominium su un<br />
altro essere umano: la necessità di questa<br />
formalizzazione legislativa, in tempi così<br />
antichi, nasceva anche dall’utilità economica<br />
che lo schiavo rivestiva.<br />
È tuttavia d’obbligo, tralasciando<br />
nella nostra analisi l’indiscutibile negazione<br />
di diritti che esso comporta,<br />
chiedersi fi no a che punto un sistema<br />
di produzione basato sulla schiavitù sia<br />
economicamente valido. La convenienza<br />
di questo modello produttivo si riteneva<br />
risiedere nel fatto che il costo richiesto<br />
allo schiavista risultava grossomodo pari<br />
al necessario per la sopravvivenza dello<br />
schiavo. È pur vero che a quest’onere,<br />
di cui si deve sobbarcare il padrone,<br />
dovevano essere aggiunti ulteriori costi,<br />
quali, ad esempio, quelli connessi al controllo,<br />
necessari affi nché lo schiavo non<br />
fuggisse e svolgesse effettivamente il<br />
lavoro ordinatogli, oppure quelli relativi<br />
all’addestramento, utili affi nché lo schiavo<br />
sapesse come svolgere i propri compiti<br />
e potesse coordinarsi con gli altri<br />
lavoratori. Queste ulteriori voci di spesa<br />
rappresentavano comunque per il padrone<br />
un esborso irrisorio se paragonato alla<br />
quantità di forza lavoro di cui poteva disporre.<br />
Non deve però essere trascurata<br />
nemmeno un’altra importante componente<br />
di costo, quella per acquistare lo<br />
A destra: una stampa del 1881 rappresenta<br />
il momento in cui gli schiavi vengono<br />
caricati su una nave che li porterà<br />
dall’Africa all’America.<br />
schiavo o per allevarlo, se fi glio di schiavi.<br />
Spesso, infatti, la maggior parte della<br />
ricchezza dei grandi proprietari terrieri<br />
era rappresentata dal valore di mercato<br />
degli schiavi da essi posseduti e non dal<br />
terreno di loro proprietà.<br />
L’acquisto di un essere umano –<br />
prescindendo da ogni valutazione etica<br />
che risente dei valori oggi presenti<br />
nella nostra civiltà – poteva anche non<br />
risultare sempre<br />
economicamente<br />
conveniente.<br />
Si tratta del caso<br />
in cui il prezzo<br />
pagato per lo<br />
schiavo si fosse<br />
rivelato eccessivo ex post a causa delle<br />
sue cattive o insuffi cienti prestazioni.<br />
Chiaramente questo rischio andava imputato<br />
alla non corretta valutazione, da<br />
parte dello schiavista, della forza lavoro<br />
che lo schiavo era in grado di assicurargli<br />
o che gli era necessaria per la produzione,<br />
il che accade ancor oggi con<br />
un cavallo da tiro o un asino da soma.<br />
A tal proposito l’economista e fi losofo<br />
La Guerra di Secessione<br />
tedesco Max Weber, nella sua analisi<br />
economica del ruolo della schiavitù,<br />
pose l’attenzione proprio sull’impossibilità,<br />
da parte del padrone, di operare<br />
correttivi all’entità della forza lavoro<br />
schiavizzata, per adattarla alle normali<br />
oscillazioni che il mercato, o l’attività<br />
economica, comporta.<br />
D’altro canto diversi studi, come<br />
quello condotto dall’economista statunitense<br />
Kenneth Milton Stampp, sostengono<br />
la tesi secondo la quale i costi relativi<br />
allo schiavo erano egualmente gravosi<br />
rispetto a quelli necessari per mantenere<br />
un lavoratore libero che svolgesse le<br />
stesse mansioni. L’unica differenza tra<br />
le due situazioni risulterebbe dal divario<br />
temporale su cui i costi stessi sono ripartiti:<br />
nel caso del non libero, sono quasi<br />
totalmente (al netto dei costi di sopravvi-<br />
Nelle città greche la forza lavoro<br />
costituita da schiavi era di molto<br />
maggiore rispetto a quella fornita<br />
da lavoratori liberi.<br />
venza) concentrati nel prezzo d’acquisto<br />
(se lo schiavo è stato acquistato), mentre<br />
nel caso dello stipendiato sono rinvenibili,<br />
diluiti nel tempo, nel salario mensile.<br />
In ogni caso, a questa parità sostanziale<br />
di costi non corrisponde una parità di<br />
produttività-uomo, in quanto il <strong>numero</strong><br />
di ore lavorate da uno schiavo è in media<br />
superiore a quelle di un dipendente.<br />
In ultima analisi, per Stampp, il sistema<br />
panorama per i giovani • 33<br />
Foto: iStockphoto.com/Grafi ssimo