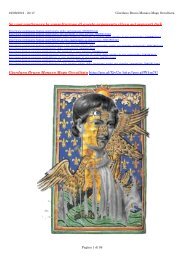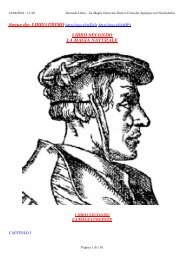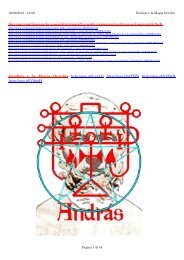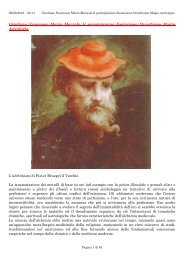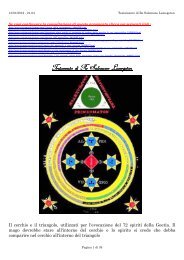Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
01/06/2012 - 18.06 <strong>Ruggero</strong> <strong>Bacone</strong> <strong><strong>fra</strong>te</strong> <strong><strong>fra</strong>ncescano</strong> <strong>fra</strong> i <strong>primi</strong> <strong>Alchimisti</strong><br />
le miniature contenute in questo manoscritto, ma una scelta che ho ritenuto particolarmente<br />
significativa.<br />
La prima immagine è proprio il primo capolettera della prima opera contenuta in questo<br />
manoscritto, il Testamentum, e ha due settori, entrambi significativi (Figura 1). L’immagine di<br />
sinistra, la donna bionda che si strappa i capelli, col volto palesemente in lacrime, è la natura<br />
che si lamenta. Il motivo di natura lugens è un motivo che percorre la poesia tardo latina e poi<br />
torna nel XII sec. e che ancora ritroviamo in Jean de Meung. Natura si lamenta e dice<br />
all’alchimista che alcuni vogliono strapparle i suoi segreti, vogliono lacerarle le vesti, afferma<br />
"morti me tradere volunt" (mi vogliono ammazzare). Riecheggia in questo lamento il titolo del<br />
libro di Carolyn Merchant, La morte della natura. La Merchant ha analizzato un accadimento<br />
storico collocandolo nel momento in cui proprio è arrivato a compimento, al tempo della<br />
rivoluzione scientifica in cui la natura come grande dea, come figura divina era ormai decaduta a<br />
oggetto dell’indagine e quindi torturabile, come diceva nel ‘600 Francesco <strong>Bacone</strong>.<br />
Nell’immagine del manoscritto<br />
abbiamo una natura che ancora<br />
è vitale ed è in grado di<br />
lamentarsi, non è ancora stata<br />
definitivamente uccisa, ma<br />
manifesta proprio nelle sue<br />
parole questo pericolo e si<br />
appella all’alchimista perché<br />
solo l’alchimista potrà<br />
comprendere i suoi segreti in<br />
maniera non lacerante, in<br />
maniera non violenta.<br />
L’alchimista infatti, come vedremo in seguito, ha un modo di rapportarsi alla natura per cui la<br />
natura gli svela volentieri i suoi segreti, perché sa che non ne farà cattivo uso, perché ha<br />
raggiunto una consapevolezza etica che gli consente di fare buon uso dei segreti di natura e una<br />
metodologia di approccio per cui interagisce con la natura ma non "la mette alla tortura" – <strong>fra</strong>se,<br />
quest’ultima, di Francesco <strong>Bacone</strong>.<br />
L’altra immagine, quella racchiusa nella lettera O, è invece un’illustrazione sintetica di che cosa<br />
è l’alchimia. La scena illustra l’angelo che guida Tobia, il Tobia biblico, nel ritorno verso casa,<br />
dove con il fiele del pesce guarirà la cecità del padre. Tobia è raffigurato un po’ più giovane che<br />
nell’episodio biblico, è un bambino (vedremo alla fine il perché di questa piccola figura di puer), e<br />
il pesce è un simbolo dai molti significati, ma qui sta chiaramente per il "farmaco’’. Dunque<br />
l’alchimia perché? Per ottenere il farmaco, non ‘un’ farmaco, ma ‘il’ farmaco, il rimedio<br />
universale. L’angelo è il segno della rivelazione, cioè indica che questo sapere alchemico è<br />
appunto un sapere dalle caratteristiche particolari. Il <strong><strong>fra</strong>ncescano</strong> inginocchiato, a sinistra, che<br />
ammira questa scena con devozione, è un’immagine di Raimondo Lullo. Raimondo Lullo che non<br />
Pagina 21 di 60