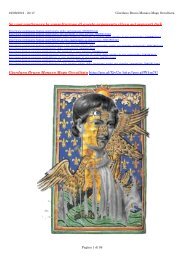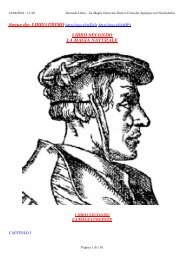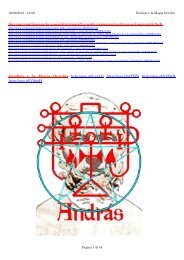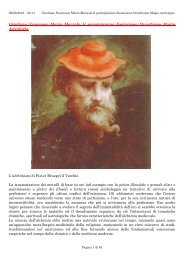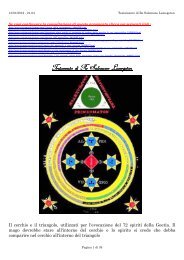Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
Ruggero Bacone frate francescano fra i primi Alchimisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
01/06/2012 - 18.06 <strong>Ruggero</strong> <strong>Bacone</strong> <strong><strong>fra</strong>te</strong> <strong><strong>fra</strong>ncescano</strong> <strong>fra</strong> i <strong>primi</strong> <strong>Alchimisti</strong><br />
farmacologica, a metà del ‘300, con il <strong><strong>fra</strong>ncescano</strong> Giovanni da Rupescissa che è uno dei<br />
precedenti di Paracelso della ricerca iatrochimica di Paracelso.<br />
Ciò che spiega perché i medici rinascimentali sono interessati a questo sapere.<br />
Nella dodicesima immagine il medico che stringe la mano all’alchimista è una persona<br />
particolare: è Arnaldo da Villanova, che compare in una versione della leggenda di Lullo<br />
alchimista, in cui si dice che Arnaldo sapeva fare la distillazione ma non ne conosceva il quadro<br />
di riferimento alchemico.<br />
Quando questo gli viene insegnato dall’alchimista i due diventano socii, condividono la stessa<br />
ricerca, e a questa comunanza di interessi allude il fatto che si stringono la mano in gesto<br />
amichevole (Figura 12).<br />
Nella figura successiva vediamo<br />
invece raffigurato l’interesse dei<br />
religiosi per la ricerca alchemica<br />
(Figura 13). Il monaco vestito di<br />
bianco è un certosino; e infatti<br />
l’illustrazione è riferita al Liber de<br />
secretis naturae, che l’alchimista<br />
avrebbe scritto su richiesta di un<br />
monaco della Certosa Parigina.<br />
Quello che qui viene illustrato è il<br />
momento in cui l’alchimista<br />
consegna al monaco il libro che gli<br />
è stato richiesto.<br />
Di fatto ci sono numerosi divieti di<br />
praticare l’alchimia rivolti dagli<br />
ordini religiosi ai propri membri;<br />
ma proprio il ripetersi però di questi divieti mostra che in realtà i religiosi praticavano la ricerca<br />
alchemica con tutte le implicazioni che questa ha relativamente alla salvezza del corpo e alla<br />
salvezza spirituale, con la sua richiesta di perfezionamento anche etico, di disposizione religiosa<br />
nei confronti della natura e naturalmente anche di ricerca medica dell’elixir.<br />
Del resto tutti quei liquori che nelle Certose, nelle fondazioni di antica memoria ancora si<br />
producono, testimoniamo una tradizione di distillazione che poi si è certo abbassata a scopi più<br />
utilitaristici, ma che è radicata in questo sapere.<br />
C’era, in Italia, un ordine religioso che fu soppresso alla fine del ‘600, fondato dal senese<br />
Giovanni Colombini dopo la peste nera verso il 1365/67 per assistere gli ammalati di peste e i<br />
moribondi, che venne presto ribattezzato "I Frati Speziali" o "I Fratelli dell’Acquavite". In tutte<br />
le fondazioni di questi Gesuati, c’erano officine di distillazione, perché era coi farmaci distillati<br />
che essi curavano i malati gravi e i moribondi.<br />
Un testo attribuito ad Arnaldo da Villanova racconta del resto come si possa ottenere mediante<br />
la distillazione un farmaco che è in grado di risuscitare i morti," vel quasi" – dice -, insomma non<br />
proprio del tutto.<br />
Cioè si può far sì che una persona che sta malissimo, che sta perdendo i sensi, che se ne sta<br />
andando all’altro mondo, ma che non ha fatto in tempo a fare testamento o a confessarsi, si<br />
riprenda con questo prodotto alchemico, detto appunto perciò elixir vitae, quel tanto che basta<br />
per mettersi in pace con Dio e con gli eredi: e pare che i Gesuati di questa possibilità vel quasi ne<br />
abbiano forse un po’ abusato.<br />
Pagina 29 di 60