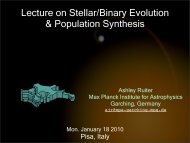scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10. Di solito tradotto come “flauto”, <strong>il</strong> termine indica invece uno strumento ad ancia<br />
(semplice o doppia); fra gli strumenti moderni <strong>il</strong> più vicino ad esso nella struttura essenziale<br />
è l’oboe. Aveva in genere due canne, ciascuna con un certo numero di fori.<br />
11. Si veda ad esempio Pindaro, Olimpica III, 6 ss.: “Ora da me le ghirlande annodate<br />
alla chioma reclamano un debito eretto dal dio: che io fonda in giusta misura <strong>il</strong> vario tono<br />
di cetra e clamore di flauti e una trama di voci per <strong>il</strong> figlio di Ainesídamos [trad. L.Lehnus,<br />
M<strong>il</strong>ano 1981].<br />
12. Lo strumento a corda di uso più comune (normalmente adoperato nell’educazione dei<br />
giovani), che consisteva in una cassa armonica costituita in origine da un guscio di tartaruga<br />
e in due bracci che, a differeza della kiqavra, non costituivano un prolungamento<br />
della cassa ma erano a questa applicati.<br />
13. Amato in particolare dai poeti di Lesbo, era uno strumento la cui maggiore differenza<br />
con la luvra consisteva nella presenza di due lunghi bracci ricurvi. Le dimensioni molto<br />
ridotte della cassa di risonanza e la lunghezza delle corde dovevano produrre un suono<br />
di volume non ampio e di intonazione grave.<br />
14. Teognide, vv. 239-243: “Sarai presente a tutte le feste e a tutti i banchetti posando sulle<br />
labbra di molti: te celebreranno al suono degli auli brevi d’acuta nota giovani seducenti<br />
nell’armonia di melodiose canzoni” [trad. F.Ferrari, M<strong>il</strong>ano 1989].<br />
15. Plutarco, ad esempio, racconta (Vita di Nicia, 29, 4) come alcuni Ateniesi sopravvissuti<br />
al disastro m<strong>il</strong>itare di Siracusa (413 a.C.) nel corso della guerra del Peloponneso,<br />
ottennero cibo e acqua grazie alla loro capacità di cantare brani di Euripide.<br />
16. V. 101.<br />
17. V. 69.<br />
18. Insieme a frammenti minori, di lui ci è giunta una parte piuttosto ampia di una estesa<br />
composizione incentrata sulla battaglia di Salamina (fr. 15 Page).<br />
19. Euripide, almeno nell’ultimo periodo della sua attività, sembra partecipe di alcune<br />
delle nuove tendenze: così si potrebbe interpretare <strong>il</strong> maggior ricorrere di canti astrofici,<br />
per lo più affidati agli attori. Aristofane, d’altro canto, gli rimproverava, non sappiamo<br />
quanto a ragione, l’uso di una ridondante aggettivazione e di frequenti anadiplosi come<br />
semplici pretesti per modulazioni musicali. E ancora, ne deprecava la mescolanza di<br />
motivi provenienti da generi musicali diversi (Rane, vv. 1301 ss.: “lui prende <strong>il</strong> suo miele<br />
dappertutto: canti di puttane, canzoni di Meleto, motivetti per l’aulo della Caria, compianti<br />
funebri, arie di danza”[trad. D.Del Corno, M<strong>il</strong>ano 1985]). D’altra parte variazioni di<br />
ritmo compaiono in particolare nelle virtuosistiche monodie tardo-euripidee; ed è ancora<br />
Euripide a introdurre in alcune delle sue ultime tragedie canti corali che sembrano<br />
scorrelati dall’azione, basati come sono sulla narrazione di vicende mitiche e sul rincorrersi<br />
di belle immagini, forse precorrendo o rifacendosi al procedimento, che ci viene<br />
attestato per <strong>il</strong> tragico Agatone, di introdurre al posto degli stasimi della tragedia canti<br />
corali privi di aggancio con la situazione scenica, che si configurano come veri e propri<br />
riempitivi.<br />
20. Ciò si basa sulla concezione diffusa, attestata tra l’altro dai Pitagorici e da Damone,<br />
secondo la quale la musica poteva alterare lo stato d’animo di chi la ascoltava, e che<br />
quindi collegava a diversi effetti emozionali ed etici ritmi o modi musicali diversi.<br />
> Fig. 5, vaso attico, 470 a.C. ca.: Alceo e Saffo con barbitoi. (München, Staatliche<br />
Antikensammlung inv. nr. 2416).<br />
26




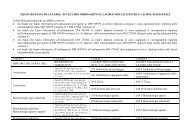



![4. Ghost [Å] vowels in French - Laboratorio di Linguistica](https://img.yumpu.com/49999334/1/184x260/4-ghost-a-vowels-in-french-laboratorio-di-linguistica.jpg?quality=85)