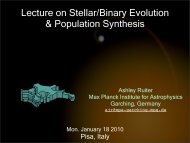scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
scarica il PDF - Scuola Normale Superiore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
di Euripide, è testimoniato da Plut. Crass. 33. 6, sebbene in un contesto significativamente<br />
diverso (simposiale): quando la testa di Crasso venne portata al cospetto di Orode,<br />
re dei Parti, durante un banchetto (eJçtiavçeiç kai; povtoi) che comprendeva la rappresentazione<br />
di molti spettacoli provenienti dalla Grecia (kai; polla; pareiçhvgeto tw'n ajpo;<br />
th'ç JEllavdoç ajkouçmavtwn), l’uJpokrithvç (attore) Giasone di Tralle stava per l’appunto intrattenendo<br />
i convitati con una selezione tragica comprendente parti di Agave che includevano<br />
anche l’intervento del coro: ∆Iavçwn o[noma Tralliano;ç h\iden Eujripivdou Bakcw'n ta; peri;<br />
th;n jAgauvhn [...] ajidomevnwn de; tw'n ejfexh'ç ajmoibaivwn pro;ç corovn ktl. (“un attore tragico, di<br />
nome Giasone, di Tralle, stava cantando <strong>il</strong> brano delle Baccanti di Euripide che riguardava<br />
Agave [...] quando poi fu cantato <strong>il</strong> dialogo seguente col coro...”, trad. di C. Carena,<br />
Plutarco. Le vite di Nicia e di Crasso, M<strong>il</strong>ano 1993).<br />
11. Contro <strong>il</strong> tentativo di T.J. Fleming-E.C. Kopff, Colometry of Greek Lyric Verses in Tragic<br />
Texts, «SIFC» s. III 10 (1992), pp. 758-770, e T.J. Fleming, The Survival of Greek Dramatic<br />
Music from the Fifth Century to the Roman Period, in B. Gent<strong>il</strong>i- F. Perusino, La<br />
colometria antica dei testi poetici greci, Roma 1999, pp. 17-29, di istituire un legame diretto<br />
fra f<strong>il</strong>ologia alessandrina e testi con notazioni musicali, cfr. da ultimo le obiezioni della<br />
Parker, art. cit., pp. 35-36 n. 16.<br />
12. Uno degli elementi più appariscenti della vita culturale ellenistica è proprio una più<br />
accentuata spettacolarità, insieme con la creazione di nuovi contesti performativi. L’esibizione<br />
di questi tragwidoiv era vissuta come un momento di puro intrattenimento che<br />
godeva di grande popolarità: è in contesti come questo che <strong>il</strong> testo poetico continuò ad<br />
essere espresso in stretto legame con l’elemento musicale, diversamente da quanto<br />
avveniva nella cultura ‘alta’, erudita e scritta delle corti ellenistiche, cfr. R. Pretagostini,<br />
«Mousike»: poesia e «performance», in S. Settis, I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2.<br />
III, Torino 1998, p. 626.<br />
13. Il mondo sommerso di questi spesso mediocri ‘artisti di provincia’, secondo la felice<br />
definizione di P. Collart, Réjouissances, divertissements et artistes de province dans<br />
l’Egypte romaine, «RPh» 18 (1944), pp. 132-155, ci è noto soprattutto grazie a papiri egiziani<br />
di età tolemaica e romana: statutariamente inferiori rispetto alla potente corporazione<br />
dei tecni'tai dionisiaci, le loro associazioni, interamente profane, erano costituite da<br />
effettivi variab<strong>il</strong>i (essenzialmente strumentisti, danzatori e qualche cantante: da un minimo<br />
di due a dieci e più elementi) solitamente ingaggiati da committenze private per un<br />
periodo limitato di tempo, cfr. Bélis, op. cit., pp. 61 ss.<br />
14. Si pensi al già citato episodio narrato da Plut. Crass. 33. 2 ss., ancora più significativo<br />
in quanto attesta <strong>il</strong> persistere di tale prassi simposiale in zone periferiche della cultura<br />
mediterranea del I sec. a.C. Un’altra testimonianza, sempre in un contesto di banchetto<br />
e brindisi privato, è Plut. Lys. 15. 4 ss., in cui si narra della commovente esibizione<br />
‘estemporanea’ di un vecchio focese che, per impedire la distruzione di Atene (404 a.C.)<br />
dinanzi ai generali spartani brindanti alla sconfitta del nemico, intona un brano euripideo<br />
(celebre episodio immortalato anche da J. M<strong>il</strong>ton, Sonn. VIII, 12-14): ei\ta mevntoi çunouçivaç<br />
genomevnhç tw'n hJgemovnwn kai; para; povton tino;ç Fwkevwç a[içantoç ejk th'ç Eujripivdou jHlevktraç<br />
th;n pavrodon, [...] pavntaç ejpiklaçqh'nai, kai; fanh'nai çcevtlion e[rgon th;n ou{twç eujklea' kai;<br />
toiouvtouç a[ndraç fevrouçan ajnelei'n kai; diergavçaçqai povlin (“I capi si riunirono allora per<br />
decidere, ma quando, nel corso di una bevuta, un Focese intonò l’inizio della parodo dell’Elettra<br />
di Euripide [...] tutti furono presi da un moto di pietà e compresero l’assurdità di<br />
voler distruggere e cancellare dalla faccia della terra una città tanto gloriosa e che dava i<br />
natali a uomini di tanto valore”, trad. di G. Pisani, Plutarco, Le vite di Lisandro e di S<strong>il</strong>la,<br />
M<strong>il</strong>ano 1997).<br />
15. Cfr. la celebrazione della panhvguriç tw'n Nemeivwn nel 205 a.C. descritta in Plut. Ph<strong>il</strong>op.<br />
11. Qui P<strong>il</strong>ade, rinomato kiqarwidovç del suo tempo, intona casualmente l’incipit dei Persiani<br />
di Timoteo proprio durante l’ingresso nel teatro di F<strong>il</strong>opemene, vincitore di Mantinea:<br />
a[rti d j aujtw'n eijçelhluqovtwn, kata; tuvchn Pulavdhn to;n kiqarwido;n a[idonta tou;ç Timoqevou<br />
36




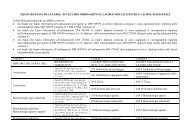



![4. Ghost [Å] vowels in French - Laboratorio di Linguistica](https://img.yumpu.com/49999334/1/184x260/4-ghost-a-vowels-in-french-laboratorio-di-linguistica.jpg?quality=85)