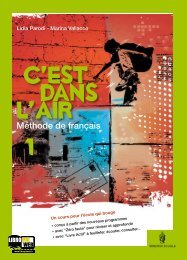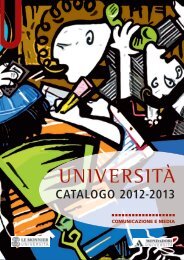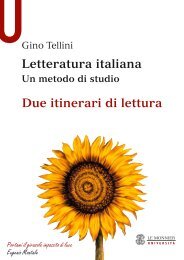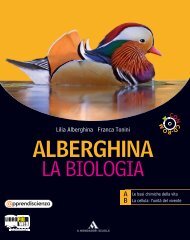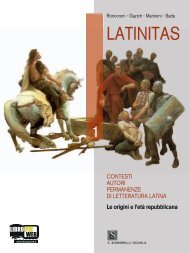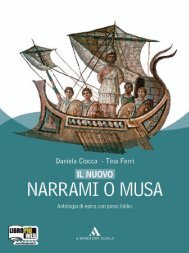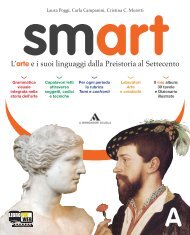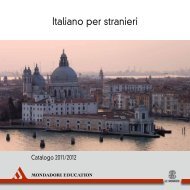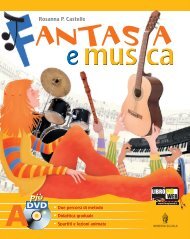LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
46<br />
Profilo<br />
Lo stile<br />
L’esametro<br />
dattilico<br />
I cola<br />
e le incisioni<br />
La recitazione<br />
ritmica<br />
dell’esametro<br />
Sullo stile va detto che l’epos racconta, e che racconta in modo continuato e piano, prediligendo<br />
la paratassi sia del periodo (l’ipotassi è ammessa di rado) sia della struttura narrativa<br />
(racconti paralleli). L’ordine delle parole è molto semplice e prevedibile: estremamente<br />
raro è l’iperbato (e cioè la collocazione a distanza di parole che sono in rapporto<br />
sintattico tra loro), soprattutto in confronto con la lirica corale (vedi la scheda a p. 427).<br />
Questa semplicità e linearità dello stile dipende dal fatto che il destinatario, ovvero l’ascoltatore<br />
della narrazione, doveva poter cogliere ogni particolare del racconto.<br />
MEMO La lingua omerica<br />
caratteristiche<br />
artificialità la lingua omerica nasce principalmente dalla commistione del dialetto ionico<br />
e letterarietà e dell’eolico<br />
si tratta di una lingua ‘mista’, che non è mai stata destinata<br />
alla comunicazione quotidiana<br />
dorismi sono del tutto assenti (così come manca qualsiasi riferimento nei poemi<br />
omerici alla storia e alla cultura dei Dori)<br />
atticismi testimoniano di un passaggio del testo omerico attraverso Atene<br />
7. Metrica<br />
L’esametro è una sequenza di sei cellule dattiliche (-gg), in cui si ammette l’equivalenza<br />
di una sillaba lunga con due sillabe brevi (- = gg). Questa caratteristica rivela che nel verso<br />
è determinante la quantità, cioè la durata delle sillabe, e non il numero delle sillabe che lo<br />
compongono, come invece accade in molte lingue moderne (l’endecasillabo italiano, per<br />
esempio, è definito così proprio perché è formato da 11 sillabe).<br />
L’ultima cellula dell’esametro è bisillabica (-g oppure --) per necessità ritmica. L’elemento<br />
finale di ogni verso, infatti, è sempre lungo, a prescindere dal fatto se sia rappresentato<br />
da una sillaba breve o da una sillaba lunga (e per questo viene definito elemento ‘indifferente’):<br />
se la fine del verso fosse costituita da un dattilo -gg, perderebbe la sua dattilicità<br />
perché corrisponderebbe a -g-, ovvero a un cretico. Per questo motivo non è giusto definire<br />
l’esametro un verso ‘catalettico’ (che presenta cioè la ‘caduta’ dell’elemento finale, -g<br />
in luogo di -gg), come fanno quasi tutti; l’esametro è piuttosto un verso dattilico completo,<br />
che finisce nell’unico modo in cui può finire un verso dattilico.<br />
Al suo interno, ogni esametro si struttura in più cola, cioè in unità ritmiche minime delimitate<br />
da fini di parola che ricorrono regolarmente in precise sedi del verso e che si chiamano<br />
incisioni o cesure. Nell’analisi metrica vengono segnate convenzionalmente con |,<br />
mentre || indica la pausa più marcata, che coincide con la fine dell’intero verso.<br />
Facciamo un esempio di analisi ritmico-verbale, esaminando il verso iniziale di ciascuno<br />
dei due poemi, che si articola in quattro cola. Le cifre indicano la consistenza dei singoli<br />
cola in more ovvero in durate di una breve; ricordiamo che una sillaba lunga vale due more.<br />
Il. 1,1 Mh`nin a[eide, qeav, Phlhi>avdew ∆Acilhò~<br />
- g g - g | g- | - -gg - |g g -- || 7 + 3 + 8 + 6<br />
Od. 1,1 “Andra moi e[nnepe, Mou`sa, poluvtropon, o}~ mavla pollav<br />
- g g - g g | - g | g - g g | - g g - g || 8 + 3 + 5 + 8<br />
All’interno del singolo verso i cola non sono uguali dal punto di vista della durata: alcuni<br />
sono molto brevi (3 more), altri ben più lunghi (7 o 8 more). Tuttavia, nella resa sonora i<br />
cola venivano riequilibrati perché un colon breve era recitato più lentamente di uno lungo,<br />
che era invece affidato a una resa più rapida, quasi affrettata.<br />
Pur nella loro varietà interna, gli esametri ripetuti uno dopo l’altro producevano