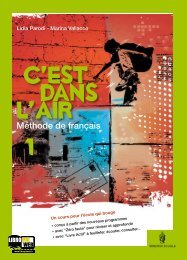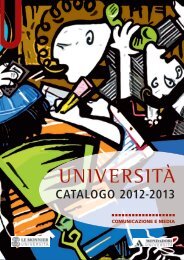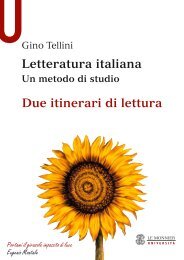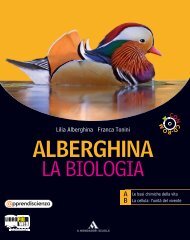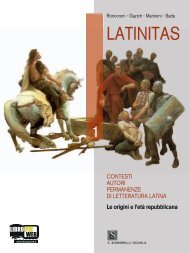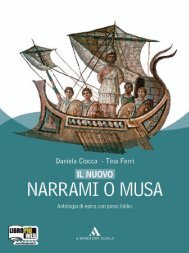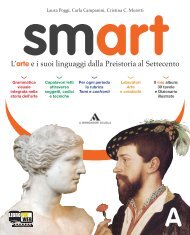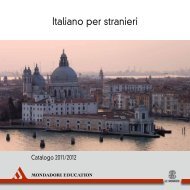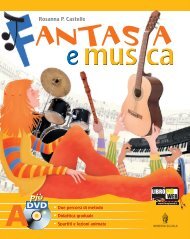LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
66<br />
Antologia<br />
Guida<br />
alla lettura<br />
STRUTTURA<br />
7 versi:<br />
Dall’ira alla contesa Il proemio vero<br />
e proprio dell’Iliade si estende per<br />
v. 1 contiene l’invocazione alla Musa<br />
e la dichiarazione del contenuto<br />
vv. 2-3 alludono sinteticamente alle vicende belliche<br />
che porteranno alla morte molti valorosi guerrieri<br />
di entrambi gli schieramenti<br />
vv. 4-5 toccano un tema che verrà sottolineato spesso<br />
nel corso del poema: la triste sorte riservata ai<br />
cadaveri lasciati insepolti, preda di cani randagi<br />
e uccelli rapaci<br />
v. 5 allude alla promessa che nel corso del I libro<br />
Zeus farà a Teti di vendicare l’offesa arrecata<br />
ad Achille favorendo in guerra le sorti dei Troiani<br />
(vv. 493-530): la boulhv, la «decisione» del dio<br />
darà inizio a una fase della guerra in cui<br />
Agamennone e il suo esercito saranno la parte<br />
soccombente; l’anticipazione dei contenuti<br />
comincia dunque a spostarsi dal<br />
macrocontesto, rappresentato dall’intero<br />
poema, al microcontesto, coincidente con<br />
il I libro<br />
vv. 6-7 introducono al tema specifico del I libro:<br />
la contesa fra Agamennone e Achille che segna<br />
l’inizio della mh'ni"<br />
GENERI LETTERARI Il proemio: fra invocazione<br />
alla Musa... Il mondo epico lega<br />
la creatività e la sapienza poetica dell’aedo all’azione<br />
Variabilità e indipendenza dei proemi La necessità di<br />
adattare i proemi alle diverse occasioni esecutive comportò<br />
ovviamente che queste sezioni introduttive<br />
mantennero una notevole variabilità e indipendenza:<br />
il proemio dell’Iliade, come anche quello dell’Odissea<br />
(vedi T11), sono solo due tra i molti che vennero<br />
composti nel corso della prassi epica per introdurre<br />
singole recitazioni o diverse organizzazioni narrative.<br />
I due proemi alternativi dell’Iliade Ne sono prova, in<br />
particolare, i due proemi dell’Iliade, alternativi a quello<br />
‘vulgato’. Uno, secondo la testimonianza del pitagorico<br />
e peripatetico Aristosseno (IV-III secolo a.C.),<br />
era attestato in alcune ejkdovsei", «copie, edizioni» antiche<br />
del poema omerico:<br />
PER APPROFON<strong>DI</strong>RE<br />
I proemi alternativi dell’Iliade<br />
ispiratrice di un dio, in particolare della Musa (o delle Muse),<br />
divinità tutelare dell’arte poetica. Questa concezione<br />
trova la sua dimostrazione più evidente nel proemio,<br />
dove l’elemento caratteristico è proprio l’invocazione alla<br />
dea (v. 1) preposta all’ispirazione del canto: l’aedo le<br />
chiede di infondergli quella conoscenza dell’oi[mh («via del<br />
canto») prescelta, che (vedi T37) si riteneva provenisse<br />
al cantore da una sfera esterna e superiore.<br />
...e dichiarazione dei contenuti Ma la funzionalità del<br />
proemio non si limitava a questo: esso assolveva anche<br />
al compito, non secondario, di introdurre l’argomento<br />
della successiva narrazione, anticipandone il tema mitico.<br />
In altre parole il proemio orientava l’attesa del pubblico,<br />
facendo capire quale segmento del mito, ossia quale<br />
parte degli eventi compresi in una vasta saga eroica,<br />
l’aedo stava per affrontare. Muovendosi infatti nell’ambito<br />
di cicli di leggende che il pubblico ben conosceva<br />
nel loro svolgimento, l’aedo di volta in volta poteva cominciare<br />
il racconto da un momento qualsiasi di una<br />
determinata saga eroica, o scegliendolo da solo o adattandolo<br />
alle esigenze imposte dall’uditorio e dall’occasione.<br />
Prima di dare inizio al canto era dunque necessario<br />
che il cantore facesse capire al suo pubblico da dove<br />
avrebbe preso le mosse e verso quali eventi mitici<br />
avrebbe proceduto la sua narrazione: il proemio dell’Iliade<br />
fa capire che la oi[mh seguita tratterà gli eventi del<br />
ciclo mitico troiano dalla mh'ni" (v. 1) di Achille in<br />
avanti.<br />
“Espete nu`n moi, Mou`sai, ∆Oluvmpia dwvmat∆ e[cousai,<br />
o{ppw~ dh; mh`niv~ te covlo~ q∆ e{le Phleivwna<br />
Lhtou`~ t∆ ajglao;n uiJovn∑ oJ ga;r basilhì colwqeiv~...<br />
Narratemi ora, o Muse che abitate le case dell’Olimpo,<br />
in che modo l’ira colse il Pelide<br />
e lo splendido figlio di Latona. Costui infatti, adirato<br />
col re, ...<br />
Questo proemio alternativo attribuisce maggior rilievo,<br />
rispetto a quello ‘vulgato’, al motivo dell’ira di Apollo,<br />
ponendo quest’ultima sullo stesso piano della mh'ni" di<br />
Achille nella richiesta di ispirazione rivolta alle Muse.<br />
Nel testo iliadico ‘vulgato’, infatti, la menzione di<br />
Apollo e della sua ira compare solo dopo la conclusio-