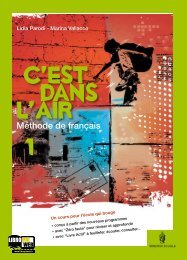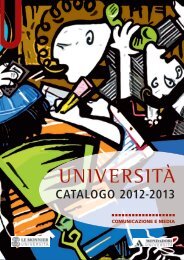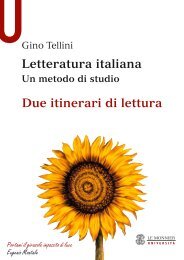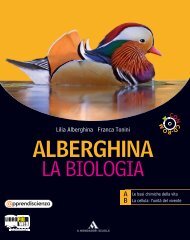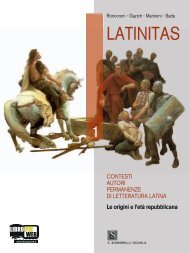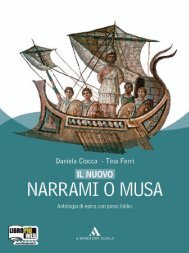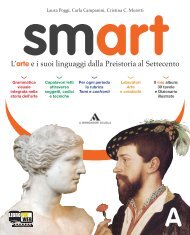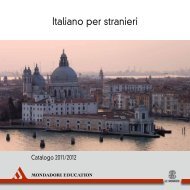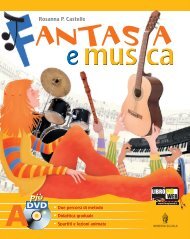LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
Profilo<br />
Composizione,<br />
pubblicazione,<br />
trasmissione<br />
I poemi come<br />
testimonianza<br />
di oralità<br />
Indizi di oralità<br />
È per questo che la principale caratteristica dei temi epici è la loro tipicità, che si estende<br />
anche alla rappresentazione della psicologia dei personaggi: non a caso, si tende a descrivere<br />
gli aspetti psicologici che tutti possono osservare e che rivestono un interesse collettivo,<br />
e si trascurano invece i risvolti più intimi e privati. Tale tipicità, che è poi alla base delle<br />
varie forme di stilizzazione epica, è diretta a interessare tutti i componenti del gruppo raggiungibili<br />
dalla voce di chi recita nella narrazione epica, la quale è una vera e propria celebrazione<br />
appunto perché in essa si esaltano i valori considerati positivi di quella cultura in<br />
cui l’intera collettività si riconosce. L’epos è dunque il luogo della lode: la violenta lite fra<br />
Achille e Agamennone (Iliade 1) e la presentazione del diverso e non eroico Tersite (Iliade<br />
2) sono solo eccezioni che confermano la regola.<br />
MEMO Definire i poemi omerici: le parole chiave<br />
«enciclopedia tribale» i poemi omerici sono depositari del sapere<br />
e delle tradizioni di una civiltà intera<br />
ecumenicità i poemi omerici sono destinati a tutta la collettività<br />
tipicità i poemi omerici descrivono personaggi e fatti<br />
sottolineando gli aspetti di rilievo per tutta la comunità<br />
3. I poemi omerici tra oralità e scrittura<br />
Stabilita la natura dei poemi omerici dal punto di vista dei contenuti, resta ora da capire<br />
in che modo siano stati composti. All’inizio di questa sezione (p. 45) si è fatto riferimento<br />
alla composizione orale dei poemi: un lungo processo che ha richiesto secoli di elaborazione<br />
prima di giungere alla forma che noi leggiamo oggi, quella che a un certo momento<br />
venne fissata mediante la scrittura.<br />
Uno sforzo che i poemi omerici ci chiedono è quello di avvicinarci a essi dimenticando il<br />
nostro abituale atteggiamento storico-letterario: queste opere sono composte, pubblicate<br />
e trasmesse in un modo non usuale per noi e completamente diverso dalla prassi moderna.<br />
In particolare, i due poemi omerici furono:<br />
1. composti oralmente, senza l’ausilio della scrittura;<br />
2. pubblicati attraverso una recitazione orale davanti a un pubblico di ascoltatori<br />
(quella che chiameremo pubblicazione ‘aurale’, e cioè destinata all’orecchio);<br />
3. trasmessi dapprima oralmente, poi per iscritto.<br />
3.1 L’oralità<br />
Quando si parla di ‘oralità dei poemi omerici’, bisogna fare due precisazioni preliminari.<br />
Innanzitutto, nella prima fase compositiva per ‘oralità’ si intende oralità integrale ovvero primaria,<br />
e cioè la composizione senza il tramite della scrittura. In secondo luogo, per ‘poemi’<br />
si intende non il testo che abbiamo di fronte, ma tutti i suoi stadi anteriori, che dovevano<br />
essere integralmente orali e certo più abbondanti e ricchi di varianti narrative ed espressive:<br />
le redazioni scritte sono venute dopo. In altre parole: i poemi non sono un documento di oralità<br />
– il che sarebbe stato possibile solo con i mezzi moderni di registrazione del suono – ma<br />
una testimonianza di oralità, perché li abbiamo di fronte a noi come un testo scritto.<br />
Il valore dei poemi come testimonianza di poesia orale lo ricaviamo da una serie di indizi<br />
interni. Innanzitutto il metro: l’esametro (vedi p. 46), con la sua regolarità ritmica, è il<br />
segno di una lunga elaborazione orale. In secondo luogo la formularità, che è un forte<br />
indizio di composizione orale, non solo nel senso più banale di fornire un aiuto alla memoria<br />
del cantore, ma anche in quanto strumento compositivo più ampio della parola e aiuto<br />
all’orientamento dell’ascoltatore.