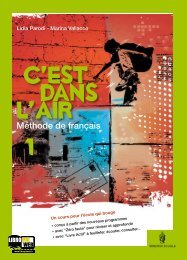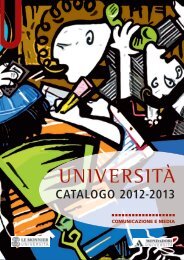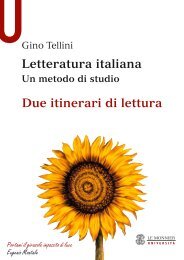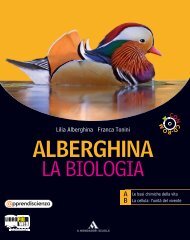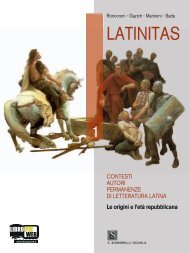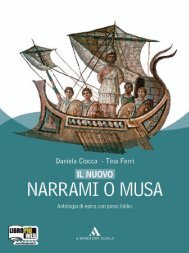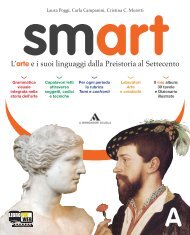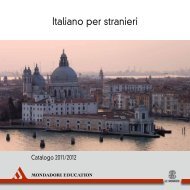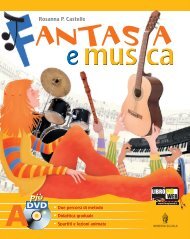LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
48<br />
Profilo<br />
Roma<br />
L’età moderna<br />
9. Fortuna dei poemi omerici<br />
La fortuna di Omero nel mondo greco richiederebbe un discorso dettagliato, perché<br />
Omero non è tanto il fondatore della lingua letteraria nel senso in cui lo furono per noi i<br />
grandi autori del Trecento toscano, ma è quella lingua letteraria stessa. Non che i Greci<br />
scrivano tutto in lingua omerica, ma Omero sarà sempre, quanto alla lingua, il punto di<br />
partenza da cui misurare la maggiore o minore distanza dei singoli stili praticati nei diversi<br />
generi letterari.<br />
Per quanto riguarda l’immensa fortuna che Omero ebbe nelle altre letterature, i Romani<br />
mostrano di apprezzare Omero proprio in conseguenza del rilievo che i poemi avevano già<br />
in ambiente greco: è una fortuna in qualche modo non autonoma, bensì legata alla fortuna<br />
del genere epico in se stesso, nell’ambito del quale i due poemi omerici detengono il<br />
primato assoluto.<br />
La letteratura latina comincia nel III secolo a.C. con un traduttore dell’Odissea in verso<br />
saturnio, Livio Andronico. Dopo di lui, Nevio, Ennio e soprattutto Virgilio considerano<br />
i poemi omerici come modello da seguire. Virgilio, in particolare, arriva a concepire<br />
l’Eneide nei termini di una sintesi dei due poemi: la prima metà è un’Odissea, con i viaggi<br />
di Enea, mentre la seconda è un’Iliade, con le guerre nel Lazio.<br />
Per una fortuna di Omero che non sia semplicemente fortuna del genere epico veicolata<br />
da Virgilio bisogna aspettare l’Umanesimo e la ripresa degli studi greci: Petrarca<br />
possedeva Omero ma non poteva leggerlo; per Boccaccio Leonzio Pilato approntò una<br />
traduzione in prosa latina (e da allora si susseguirono numerose traduzioni di Omero<br />
sia in versi sia in prosa). La letteratura cavalleresca si ispira a materiale epico ripreso<br />
tanto dalle epiche medievali nazionali quanto da Omero. Il razionalismo del XVII e del<br />
XVIII secolo segna invece un periodo di lunga sfortuna del genere epico.<br />
La rinascita dell’interesse per l’epica, sentita come espressione di voce popolare e primigenia,<br />
è tipica del Romanticismo fin dalle sue fasi iniziali, specie in Inghilterra e in<br />
Germania, e da questo momento in poi non è facile separare un tale interesse dallo studio<br />
storico-filologico di Omero. Tuttavia, la fortuna di Omero nel mondo moderno<br />
non è confrontabile con quella che ebbe nel mondo antico: la funzione educativa del<br />
genere epico e la conseguente utilizzazione di modelli epici sono fatti peculiari del<br />
La lingua omerica è un amalgama molto complesso,<br />
data la compresenza di forme riconducibili a più dialetti,<br />
e cioè lo ionico, l’eolico e l’attico. Di seguito riassumiamo<br />
gli aspetti principali, senza ovviamente pretendere<br />
di fornire un’analisi completa ed esaustiva dei<br />
numerosi problemi presentati dalla lingua omerica (il<br />
richiamo all’attico ha qui il solo scopo di orientare lo<br />
studente verso la forma a lui più familiare).<br />
Fonetica Dal punto di vista fonetico:<br />
a. a lungo originario passa sempre a h, per es. Troivh<br />
(att. Troiva);<br />
b. le contrazioni spesso non sono ancora avvenute, per<br />
es. a[lgea (att. a[lgh);<br />
PER APPROFON<strong>DI</strong>RE<br />
La lingua omerica<br />
c. alcune consonanti possono apparire sia semplici sia<br />
geminate, per es. ∆Acil(l)euv~, sthvqes(s)i,<br />
tovs(s)o~;<br />
d. al posto di p iniziale si può trovare pt, per es. ptovli~<br />
(att. povli~) e ptovlemo~ (att. povlemo~).<br />
Morfologia nominale Per quanto riguarda i sostantivi<br />
delle tre declinazioni (e gli aggettivi):<br />
e. il genitivo singolare dei temi maschili in -a esce<br />
spesso (non contratto) in -ao o in -ew (att. -ou), per<br />
es. ∆Atrei?dao e Phlhi>avdew;<br />
f. il genitivo plurale dei temi in -a esce spesso in -avwn<br />
o in -evwn (att. -w`n), per es. pulavwn;<br />
g. il dativo plurale dei temi in -a esce spesso in -hÛsi o