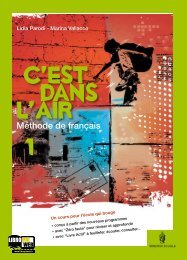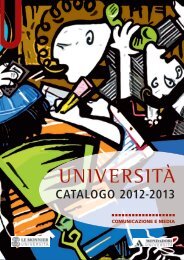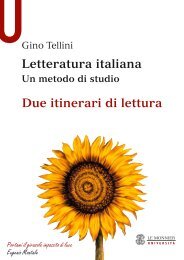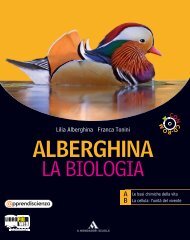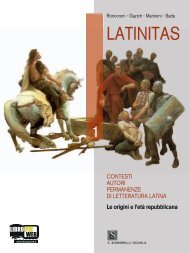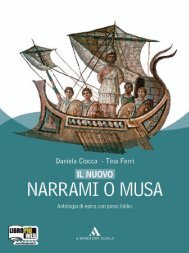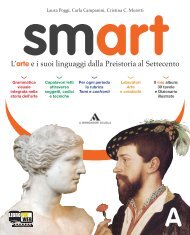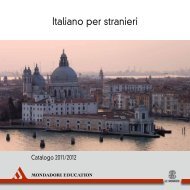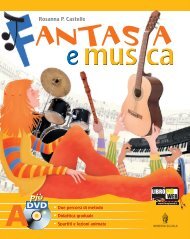LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
LEZIONI DI LETTERATURA GRECA - Mondadori Education
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
50<br />
Profilo<br />
I poemi come<br />
«libro di cultura»<br />
unico corpus i canti epici di Omero tramandati fino ad allora in ordine sparso; lo scopo<br />
era quello di creare un’edizione ‘nazionale’, adatta alle recitazioni dei poemi in occasione<br />
della festa ateniese delle Panatenee.<br />
I due orientamenti antichi dimostrano una certa difficoltà a considerare i poemi sia come<br />
l’opera di un unico autore, sia soprattutto come un’opera unitaria in sé e per sé. In effetti,<br />
la tematica trattata non è frutto di una selezione personale: è un’intera cultura che si<br />
rispecchia nei poemi, con le sue componenti religiose, civili, guerresche e le sue istituzioni,<br />
presentando una vasta gamma di reazioni individuali alle sollecitazioni della vita. Non<br />
a caso, i poemi omerici sono stati definiti «libro di cultura» esattamente come la Bibbia:<br />
un libro collettivo in cui si rispecchia un’intera civiltà e nella cui stesura è possibile trovare<br />
l’eco di più voci autoriali di epoche diverse.<br />
Qualcuno potrebbe obiettare che il fatto di essere un «libro di cultura» potrebbe non<br />
bastare a fare dell’epos omerico l’opera di una collettività: anche la Divina Commedia<br />
MEMO La ‘questione omerica’<br />
le tendenze critiche le linee interpretative<br />
Xenone, Ellanico i poemi omerici sono opera di autori diversi<br />
Ipparco pseudo-platonico, Cicerone i poemi omerici sono il frutto della riunificazione<br />
Pausania, Flavio Giuseppe di un corpus di canti epici nell’Atene di Pisistrato<br />
una parte della critica moderna i poemi omerici sono un «libro di cultura»,<br />
contenitore delle tradizioni di un’intera civiltà<br />
e modello per le generazioni future<br />
PER APPROFON<strong>DI</strong>RE<br />
Le varie tappe della ‘questione omerica’<br />
Le prime fasi moderne della ‘questione omerica’<br />
L’impostazione della ‘questione omerica’ si delinea tra la<br />
fine del Seicento e la fine del Settecento a opera di vari<br />
studiosi.<br />
Nel 1664 (ma l’opera fu pubblicata postuma nel 1715)<br />
François Hédelin abate d’Aubignac sostenne la tesi che<br />
Omero non era mai esistito e che i poemi erano il risultato<br />
di una redazione. Nella Scienza nuova (la cui ultima edizione<br />
è del 1744) Giambattista Vico affermò che la composizione<br />
e la trasmissione dei poemi erano state orali, e<br />
che Omero non era una persona, bensì il simbolo della<br />
facoltà storico-narrativa di un popolo. Nel 1769 Robert<br />
Wood, mettendo a frutto la sua curiosità antropologica di<br />
viaggiatore nel mondo egeo (dove aveva osservato l’attitudine<br />
narrativa e la vivace gestualità della gente), dedusse<br />
che i poemi erano stati composti e pubblicati oralmente.<br />
Ma il vero salto di qualità nella critica omerica si ebbe con<br />
i Prolegomena ad Homerum di Friedrich August Wolf (1795),<br />
che aveva studiato gli scolî del manoscritto Veneto<br />
Marciano A dell’Iliade, pubblicati pochi anni prima<br />
(1788). Grazie a questa preziosa riserva di testimonianze<br />
sull’attività filologica degli alessandrini, Wolf poté impostare<br />
per la prima volta la storia di un testo nella sua fase<br />
antica, nel nostro caso da Pisistrato agli alessandrini. Quanto<br />
all’origine dei poemi, Wolf sostenne che non potevano essere<br />
stati composti da una sola persona, ma dovevano essere<br />
una serie di canti trasmessi oralmente e infine raccolti<br />
nella redazione pisistratea.<br />
La critica analitica... La posizione maturatasi con Wolf<br />
portò tutta la critica omerica successiva a tentare di individuare,<br />
analiticamente, i vari ‘autori’ dei poemi, che venivano<br />
immaginati come opere moderne composte in<br />
forma scritta. E così, secondo alcuni (G. Hermann, 1772-<br />
1848), i poemi si sarebbero sviluppati a partire da un<br />
nucleo originario (per l’Iliade l’‘ira’ di Achille); secondo<br />
altri (Lachmann, 1793-1851), l’Iliade sarebbe il risultato<br />
dell’aggregazione di canti originariamente isolati; altri<br />
ancora elaborarono la teoria della compilazione, secondo<br />
cui vari rielaboratori e redattori avrebbero ripreso e integrato<br />
materiale preesistente. Nel XX secolo il più influente<br />
seguace e perfezionatore di questa teoria fu Ulrich von<br />
Wilamowitz-Moellendorff (1849-1931), che propose una<br />
genesi articolata in più fasi: Omero avrebbe raccolto e rielaborato<br />
canti tradizionali organizzandoli intorno a un<br />
tema; successivamente, sarebbero state aggiunte nuove<br />
sezioni di varia estensione.